
Susanna Tamaro,
rispondimi.
Copyright 2001 RCS Libri S.p.A., Milano.
Prima edizione: gennaio 2001.
Indice.
Rispondimi;
L'inferno non esiste;
Il bosco in fiamme;
Rimanete nel mio amore.
Giovanni 15,9.
Rispondimi.
I.
In fondo era soltanto il Natale dell'anno scorso, le mie ultime vacanze trascorse dagli zii.
Faceva freddo e il paese era sprofondato nella
nebbia. Lì la vita era noiosa come sempre, non telefonava nessuno, nessuno veniva a trovarmi.
Lo zio si addormentava davanti ai balletti della televisione, la zia faceva grandi coperte all'uncinetto. Nella
penombra, l'albero di plastica lampeggiava come un semaforo rotto.
Anche a mezzogiorno la nebbia avvolgeva la casa come un sudario. Ogni mezz'ora mi affacciavo alla
finestra per vedere se era spuntato il sole. Non si vedeva mai niente. Di notte sognavo di avere braccia

lunghissime, talmente lunghe da arrivare fino al cielo. Arrivavo lassù e afferravo le nuvole, le spostavo una
dopo l'altra come fossero i tendoni del cinema. C'è il sole o non c'è? mi domandavo con rabbia. Alla fine lo
trovavo, il suo raggio luminoso mi colpiva in
mezzo alla fronte. Colpiva me e nessun altro perché ero stata io a cercarlo, l'avevo stanato con le mie
braccia smisurate, con la mia volontà.
L'ultimo dell'anno sono andata nella legnaia e mi sono ubriacata. Da fuori giungeva, intermittente, il rumore
delle macchine. Tutti correvano nella nebbia. Per andare dove? Forse, per la tristezza, a uccidersi già prima
del cenone.
La legna odorava di muffa, era lustra, bagnata come quella di un galeone affondato. Sono nel ventre della
balena, pensavo, mentre tutto mi girava intorno. Mi ha ingoiata e non posso più liberarmi. Sono prigioniera
nelle segrete di un castello, o forse sono già nell'aldilà e questa è la mia tomba. Marcisce la legna e
marciscono già le mie ossa. Se questa è la tomba, dov'è l'oltretomba? A un certo punto si sarebbe dovuto
aprire uno spiraglio, da qualche parte sarebbe entrata la Luce. O divampate le fiamme.
Dovevo crederci? Ricadere nel tranello e crederci ancora?
Da qualche parte, comunque, doveva pur esserci mia madre. Forse era già all'inferno, per questo non
riuscivo a vederla. O forse non c'era niente, niente di niente. Dopo un anno si era vermi e dopo due, polvere.
«Fai una preghierina per la mamma e per le anime del purgatorio», mi dicevano ogni sera le suore, quando
ero in collegio. Io ubbidivo, stavo li con le mani giunte, lo sguardo verso l'alto.
Mi aspettavo che, da un momento all'altro, apparisse la mamma, una sciabolata di luce seguita dal vento.
L'avrei riconosciuta per il caldo, per il piccolo tornado di tepore che sarebbe salito dallo stomaco. L'amore,
mi sarei detta,
l'ha fatta tornare dal mondo dei morti.
Pregavo e pregavo, ma l'unica cosa che continuava ad accendersi e spegnersi era una lampadina difettosa.
Esisteva davvero l'amore? E in che forma si
manifestava?
Più passava il tempo, meno riuscivo a capirlo. Era una parola, una parola come tavolo, finestra, lampada.
Oppure era qualcos'altro? E quanti tipi di amore esistevano?
Da piccola ci avevo creduto, come si crede all'esistenza dei folletti. Un giorno, però, avevo guardato nelle
fessure dei tronchi, sotto le cappelle dei funghi. Non c'erano folletti né fate, soltanto muschi, licheni, un po' di
terriccio e qualche insetto.
Invece di baciarsi, gli insetti si divoravano l'un l'altro.
Mia madre è morta che avevo quasi otto anni. Un incidente d'auto mentre ero a scuola. Ricordo bene quel
giorno. La maestra mi ha portato nella stanza della direttrice. Una teneva un braccio sulla mia spalla, l'altra
muoveva la
bocca: «E' successa una brutta cosa...».
Io sono rimasta lì ferma, senza piangere.
Chissà se da qualche parte ritroverò mai il suo profumo, ho pensato.
Perché i volti con il tempo scompaiono mentre gli odori no? Com'era il suo profumo, cosa c'era dentro? Di
sicuro dell'acqua di colonia di poco prezzo, mista all'odore della sua pelle e a quello di un sapone o di un
talco. Mia madre si lavava in continuazione.
Per i miei primi sette anni siamo state sempre insieme. Vivevamo in un piccolo appartamento. Lei era
allegra, vistosa, colorata. Andava al lavoro dopo avermi messo a dormire e, al risveglio, la trovavo di nuovo
in piedi accantto al letto. Mi si precipitava addosso, ridendo: «E' in arrivo una tempesta di baci...».
Così era e così, pensavo, sarebbe stato per sempre.
Ancora non sapevo che i nostri nomi non erano scolpiti nella roccia, ma soltanto tracciati su una lavagna.
Ogni tanto, qualcuno passava il cancellino e si usciva dalla lista. Lo passava con volontà precisa? Lo
passava per distrazione? Era proprio quello il nome che voleva cancellare, o forse era quello appena sopra,
quello appena sotto?
Sulla porta del cucinino avevamo appeso un quadretto di Gesù. Sotto, c'era una lucina sempre accesa.
Anche se non scottava, si muoveva come una fiammella. Gesù aveva il suo cuore in mano, ma non mi
faceva impressione, perché, invece di essere scomposto e urlare dal dolore, era pettinato, con le guance
rosee e
sorrideva senza alcun timore. «Chi è quel signore? » ho chiesto la prima volta che l'ho visto. «E' un amico»,
ha risposto la mamma, «un amico che ti vuole bene. » «Vuole bene anche a te?» «Certo. Lui vuole bene a
tutti.»
L'odore di quel giorno, il giorno della morte, per me è rimasto quello del pane appena fatto.
Alla sedia della direttrice era appeso il sacchetto di un panificio. Da lì il profumo era uscito e aveva invaso la
stanza.
Sul davanzale della finestra, una patata americana agonizzava in un vasetto con l'acqua sporca.
La "brutta cosa" era la morte.
«Voglio andare da lei», ho detto.

«Mi dispiace. Non è più possibile.»
Nei giorni seguenti si erano sovrapposti un numero pressoché infinito di odori. L'odore dell'ospedale, un
odore che ancora non conoscevo ma brutto, l'odore della terra smossa e dei fiori arrivati già vecchi, l'odore
delle sue amiche, la
Pina, la Giulia e la Cinzia che mi avevano abbracciato già tante volte, l'odore della tonaca del vecchio prete
che aveva fretta e parlava veloce, l'odore di un panino alla mortadella che qualcuno stava mangiando li
vicino, l'odore di pino massello della credenza che avevamo in cucina.
Ora era lei a stare chiusa in quella credenza lunga e stretta.
Le sue amiche piangevano e si soffiavano il naso. La signora che mi aveva accompagnata mi teneva forte
come se avesse paura che volassi in cielo.
«Devo piangere anch'io? » le ho chiesto. Lei ha mosso la testa avanti e indietro, come a dire "Sì". Mi sono
sforzata di farlo, ma con poco successo. Avevo un unico pensiero in testa. Dove va una persona quando
non è più da nessuna parte?
Il giorno dopo, ho cominciato a chiedere a Gesù di farmi perdere la vista. A scuola mi era stato raccontato
che aveva guarito molti ciechi, sputando sulle loro palpebre. Se aveva fatto questo, pensavo, poteva fare
anche il contrario.
Dicono che anche certi animali sono capaci di farlo, ti spruzzano un liquido negli occhi e tu sprofondi nel
mondo delle ombre.
Era questo che io volevo con tutte le mie forze. Finire nel mondo dove non c'è più niente, né le strade né le
case né le auto né i volti né la mattina né il pomeriggio. Soltanto la notte. Una notte in alto mare, con il cielo
coperto, senza stelle né lune né fari all'orizzonte.
Di solito i ciechi capiscono dove andare con il tatto. Io sarei stata una cieca diversa, me ne sarei andata
intorno annusando. Avrei sentito l'odore del semaforo rosso e di quello verde, l'odore della pioggia e quello,
più intenso, che precede la neve. Avrei sentito l'odore delle persone antipatiche e di quelle simpatiche,
l'odore di quelle di cui mi potevo fidare e di quelle che
bisognava mordere prima che si avvicinassero troppo.
Avevo chiesto a Gesù di portarmi nell'ombra perché ero convinta che mia madre si nascondesse laggiù.
Girando in lungo e in largo nelle tenebre, prima o poi avrei annusato una traccia, dalla traccia sarei arrivata
a lei, alla turbolenza tempestosa dei suoi baci.
Odore di disinfettante, odore di minestra di verdura, di cipolla, di porro, odore di chiuso, di polvere, di gonne
sporche, odore di pipì nel letto e di sapone economico, odore di umidità, odore di incenso. Nella mappa di
questi odori, non ne riconoscevo uno solo come mio.
In collegio c'era una suora che mi prendeva sempre in braccio. Voleva consolarmi, invece mi faceva paura.
Era quello l'odore nuovo della mia vita, quello a cui mi dovevo abituare?
Non ero ancora cieca, ma avevo imparato lo stesso a fare un gioco con gli occhi. Quando qualcuno mi stava
davanti, immaginavo di essere una lumaca. Li mandavo avanti e indietro, indietro e avanti, fino a che tutto
diventava opaco.
Soltanto di sera ero contenta, quando eravamo tutte in pigiama vicino alletto e la suora diceva: «Uniamo le
manine e preghiamo Gesù».
Gesù mi aveva seguito da una vita all'altra e, visto che era mio amico e mi voleva bene, era una buona
cosa. Così, a mani giunte, dentro di me ripetevo: «Per piacere, visto che vuoi bene a me e anche alla mia
mamma, facci tornare insieme per sempre».
Il Gesù della camerata era comunque diverso da quello del cucinino. Invece di sorridere con il cuore in
mano, stava inchiodato su una croce, sporco, quasi nudo e con gli occhi chiusi.
Era lì nel suo dolore e non guardava proprio nessuno.
Nel frattempo, cercavano i miei parenti. Un padre non c'era mai stato. La mamma non aveva fratelli né
sorelle. I suoi genitori erano morti da tempo.
«Che fortunata», mi aveva detto un giorno la mia vicina di letto, «finirà che ti adottano. »
Così, con il passare delle settimane, anche quello era diventato un mio sogno. Non volevo un'altra mamma,
ma mi sarebbe piaciuto avere finalmente un papà e una casa con una stanza solo mia, con i miei giochi, i
miei odori.
Un giorno è arrivata un'assistente sociale.
Aveva le guance rosse e un cappotto verde bottiglia molto consumato. «Sei fortunata», ha esclamato con
allegria. «Oggi facciamo la valigia e domani vai dagli zii. Lo zio Luciano è il fratello del tuo nonno. E'
sposato, ma non ha fi
gli. Per le vacanze di Natale e per l'estate starai in campagna da loro. Sei contenta? »
Non ho detto né sì né no. Sono rimasta ferma, con gli occhi di lumaca che andavano avanti e indietro.
La mattina dopo è arrivato lo zio a prendermi. Le sue scarpe cigolavano mentre attraversava il grande atrio.
Invece di darmi un bacio mi ha teso la mano: «Piacere, Luciano».
La sua macchina aveva sedili di plastica rossa, molto lucidi. Dietro c'erano due cuscini tondi all'uncinetto
pieni di pizzi e merletti. A ogni curva oscillavano come grandi meduse. Siamo rimasti sempre in silenzio.
«Adesso conoscerai la zia Elide», mi ha detto, poco prima di arrivare alla cascina.

La zia sembrava scolpita nel legno. Guance rosse e dure e un naso molto grande. Mi ha dato due baci
come morsi, dicendo: «Benvenuta».
Il pomeriggio l'ho aiutata a pulire il pollaio.
Il giorno dopo abbiamo preparato i biscotti per Natale. Parlava poco. «Passami questo, prendi quello.»
Avevo una stanza al piano di sopra, con un grande letto freddo. C'erano un tavolino, un armadio e il
pavimento di mattonelle. Dalla finestra si vedeva il cavalcavia della provinciale.
Vuom, vuom, facevano le macchine, grrrrn, i camion.
C'era spesso la nebbia. In quei giorni, i grandi Tir sembravano dei mammut. Emergevano dal nulla, come
fantasmi, e dal nulla, nuovamente, venivano inghiottiti.
Quel Natale, sotto l'alberello di plastica con le luci lampeggianti, avevo trovato un pacco. E dentro al pacco,
una scatola. Dentro la scatola,
una camicetta bianca.
«Ti piace? » ha chiesto la zia Elide.
«Sì», ho risposto.
In realtà, della camicia bianca non mi importava niente. L'unica cosa che avrei voluto davvero era un orsetto
con cui dividere il letto.
Quello che avevo sempre avuto era finito nel mondo dell'ombra, con tutto il resto.
Ho ricevuto una camicia bianca quel Natale, e ho ricevuto una camicia bianca quasi tutti i Natali seguenti.
Una camicia sempre più chiusa, sempre più casta.
II.
In collegio stavo sempre sola. Ogni tanto qualche suora mi prendeva da parte e diceva:
«Non va bene isolarsi, poi vengono le tristezze».
Allora, per accontentarla, raggiungevo le compagne, mi mettevo nel circolo ma nessuna mi faceva mai
arrivare la palla. Rimanevo un po' lì, con le mani in mano, e poi mi ritiravo di nuovo su una panchina con i
miei pensieri.
Ci sono pensieri buoni e pensieri cattivi, ripetevano spesso le suore. Quali erano i pensieri buoni e quali
quelli cattivi? Com'era possibile distinguere gli uni dagli altri? I pensieri non hanno odore e questo rende
tutto più difficile.
Camminavo per i vialetti del giardino e pensavo. Se Dio fosse veramente gentile, anche a loro avrebbe dato
un profumo, così sarebbe possibile distinguerli fin da quando si formano nella mente. Una cosa è avvicinarsi
a una rosa, un'altra a una primula. La prima ti stordisce con il suo odore, dell'altra quasi non ti accorgi. Allo
stesso modo, i pensieri cattivi dovrebbero avere un odore forte, disgustoso, di cacca o di pesce marcio, ad
esempio, e quelli buoni invece un
profumo morbido, affettuoso, odore di vaniglia o di cioccolato. Così il mondo sarebbe più semplice. Nessuno
potrebbe nascondersi dietro le parole perché tutti sentirebbero subito la puzza o il profumo. Chi pensa male
o ha cattive intenzioni,
sarebbe scoperto ancor prima di aprire la bocca.
Verso gli Otto anni, al catechismo, avevo scoperto l'esistenza dell'angelo custode. Da quel giorno, quando
mi domandavano: «Perché stai sempre sola?», rispondevo: «C'è il mio angelo con me, non sono sola».
«L'angelo di Rosa è sempre con lei», bisbigliavano le suore, guardandomi da lontano.
«Dio ti benedica», mormorava la vecchia suora portinaia, passandomi davanti. Così potevo pensare in pace.
C'era una cosa che mi tormentava ormai da qualche tempo. Riguardava Gesù. Avevo fatto un po' di calcoli.
Nella camerata eravamo in dodici e ognuna di noi, la sera, gli domandava qualcosa. Di camerate ce ne
erano altre quattro, con richieste analoghe e, in più, c'erano le suore. Insomma, già lì da noi doveva
occuparsi di un bel po' di persone. Se poi andava fuori dal collegio, il numero cresceva in modo spaventoso.
Come faceva Gesù a ricordarsi di tutte le richieste e, soprattutto, ad assolverle? E, poi, eravamo proprio
sicuri che le assolvesse? La mamma mi diceva che Gesù mi voleva bene e che voleva bene anche a lei. Le
suore dicevano che lui voleva bene a tutti.
Ma cos'era l'amore? Non riuscivo a capirlo.
Non era un odore né una moneta per comprare le cose. Le suore parlavano dell'amore come
fosse il collante del mondo, però oscuravano le finestre e leggevano le lettere per paura che l'amore
esplodesse. Di quale amore stavano parlando?
Più me lo chiedevo, meno riuscivo a capirlo.
L'avevo chiesto alla mia compagna di banco.
«E' quando un uomo e una donna dormono nudi, uno sopra e l'altra sotto.»
Le estati dagli zii erano interminabili. Non veniva mai nessuno a trovarci. Non facevamo gite, se non per
Ferragosto a un santuario mariano, poco distante. L'aria era immobile, la luce abbagliante, il caldo faceva

fermentare gli escrementi. Pipì di coniglio, cacca di gallina. Si poteva andare in giro soltanto con il naso
tappato.
«Ti dovrai abituare, signorinetta», mi diceva la zia, con aria cattiva. Un giorno, il pollaio, la conigliera, la
legnaia e la casa con l'orto sarebbero
stati miei. Era a questo che si riferiva la zia. Dovevo abituarmi perché quella sarebbe stata la mia vita, pulire
le galline, tirargli il collo, raccogliere i
pomodori, spellarli, bollirli, scuoiare i conigli e poi la sera, sfinita, sedermi davanti casa al tramonto a
guardare i Tir sfrecciare sulla provinciale.
«Se non fosse stato per noi... » ripeteva spesso.
Se non fosse stato per voi, continuavo dentro di me, a quest'ora avrei avuto una bella casa e un papà. O
forse sarei al mare con le suore, in colonia. Comunque, sempre meglio che stare lì a inalare il piombo dei
motori, il metano della decomposizione.
Anche le persone d'estate avevano più odore.
A trenta metri, con gli occhi chiusi avrei potuto distinguere lo zio dalla zia, il parroco dal postino.
Col caldo i rumori diventavano terribili.
Vrouum vrouumm, le sgasate dei camion sul cavalcavia. Bzzzzbzz, il ronzare delle mosche.
Croac croac, il gracidare delle rane in un fosso poco distante. E di notte, le zanzare. Zanzare di tutte le
dimensioni. Appena spegnevi la luce, ti venivano addosso, sibilavano intorno alle orecchie, zssszss.
Ucciderle non serviva a niente.
Per una morta, altre dieci arrivavano dal nulla.
In cucina, lo zio aveva messo una specie di lampada comprata a una fiera. Appena un insetto la sfiorava,
finiva carbonizzato. Il rumore era cics, l'odore quello del pollo bruciato. A ogni decesso, la zia gridava:
«Eccolo!» e poi tipeteva il numero di progressione della giornata.
Zsss, croac, vrouinm, cics, bzzzzbzz... Con chi potevo parlare? Le domande che d'inverno accumulavo nella
testa, d'estate diventavano
un cappello stretto.
Alla zia non ero simpatica, allo zio ero indifferente. Il postino mi regalava sempre una caramella e il parroco
non mi poteva soffrire.
L'ho capito dalla prima volta che l'ho visto.
Odore di minestra, odore di cantina, odore di qualcosa che era comunque sporco. Aveva occhi piccoli e
obliqui come quelli di un cinghiale. Quando la zia mi ha presentato, è rimasto lì immobile a guardarmi come
se avesse visto un
insetto. Non mi ha dato la mano né fatto una carezza. Si è soltanto toccato il naso dicendo:
«Già, la figlia della Marisa».
Un giorno di agosto sono andata lo stesso da lui. Se non mi sapeva rispondere don Firmato, chi altro
avrebbe potuto farlo? Stava sonnecchiando nella penombra fresca in fondo alla chiesa. Mi sono seduta
accanto, gli ho sfiorato una manica.
«Sei tu», ha borbottato.
«Voglio sapere una cosa.»
«Dimmi. »
«Che cos'è l'amore?»
Si è girato a guardarmi, i suoi occhi erano lenti, acquosi.
«Quanti anni hai? »
«Dodici. »
«L'amore è peccato. »
Tra tutti i peccati, don Firmato preferiva quelli della carne, per questo gli altri bambini lo chiamavano tra di
loro don Bistecca. Non c'era domenica che, dopo giri piùo meno lunghi, non arrivasse a parlare di quello. Se
la lettura del giorno erano le beatitudini, lui riusciva comunque a
parlare della perdizione dei sensi. Per don Firmato, il mondo era diviso in due da un muro invalicabile. Chi
stava da una parte e chi dall'altra.
Una parte era l'inferno e l'altra il paradiso. Si nasceva già predisposti. Non c'era possibilità di scelta. Tutto
era deciso dall'inizio.
Una volta, qualcuno aveva scritto "Firmato =
Porco" con la vernice rossa sui muri della canonica. Passandoci davanti, mi era scappato da ridere.
Il pomeriggio stesso, erano arrivati i carabinieri e avevano fatto tante domande alla zia. La porta di casa era
aperta di notte, oppure no? Si poteva uscire dalle finestre e rientrare senza che nessuno se ne accorgesse?
Poi erano saliti nella mia camera e avevano guardato nell'armadio e sotto il letto. Mi avevano controllato le
mani e gli avambracci. Avevano scrutato fin sotto le unghie per vedere se era rimasta qualche traccia di
vernice.
«Mia nipote», ripeteva la zia alle loro spalle, «è una brava ragazza. Tutte le domeniche viene a messa con
me. La sera va a dormire presto. E poi, maresciallo, se fosse stata lei, l'avrei ammazzata con le mie stesse
mani. »

I carabinieri annuivano con le facce serie.
Don Firmato doveva essere assolutamente certo della mia colpevolezza. Se fosse stato per lui, avrei dovuto
già ardere nelle fiamme dell'infer no. La zia mi aveva difesa unicamente perché sapeva che era impossibile
per me uscire di casa,
la notte. Ogni sera, infatti, chiudeva a chiave tutte le porte e dal secondo piano, dove dormivo io, non si
poteva scendere senza farsi male.
Il giorno dopo ho dovuto comunque unirmi al gruppetto di fedeli incaricato di cancellare la scritta dai muri
della canonica. Passandomi accanto, il parroco mi ha sibilato: «Tale madre, tale figlia. Lei sta all'inferno e tu
sei già in sala
d'aspetto».
Mia madre era una puttana. A Otto anni non lo sapevo ancora, ero convinta che lavorasse di notte a pulire
gli uffici. Ho continuato a crederci fino a undici anni.
Intanto il sogno di inseguirla tra le ombre era scomparso. Le suore avevano chiamato uno psicologo, per
aiutarmi. Lo psicologo era venuto in collegio. Avevamo parlato in una stanza, noi due soli.
«Morta», mi aveva detto. «Riesci a capire cosa significa? Significa che la tua mamma non cammina più qui
sulla terra, che non ti succederà mai più di aprire una porta e vederla. Non potrai più toccarla né
abbracciarla. Ti devi abituare a vivere con le cose belle di lei nel ricordo. » Poi mi aveva sfiorata e aveva
continuato:
«Se vuoi piangere, piangi pure».
Tutti volevano che piangessi, ma io non ne avevo voglia. Invece di piangere mi chiedevo:
dove finisce la spazzatura? Anche la spazzatura è così. Un giorno il sacchetto sta a casa, nell'angolo sotto il
lavello e il giorno dopo non c'è più. Viene un grande camion e lo divora. Quando il camion è passato, resta
soltanto una forte
puzza nell'aria.
La morte non doveva essere qualcosa di molto diverso, andava in giro e divorava le persone come i
sacchetti lasciando dietro di sé una nuvola di cattivo odore. Lo stesso odore di quando i Tir sulla provinciale
prendevano sotto un cane.
La verità me l'ha gridata in faccia la zia Elide, una mattina. Per qualche ragione si era arrabbiata con me. In
quei momenti, i suoi occhi diventavano di vetro, la sua lingua di metallo.
«E' ora di finirla con la farsa» ha urlato. Poi ha sgranato la verità come un rosario. «Tua madre non è morta
in un incidente, ma è stata investita mentre aspettava i clienti su una curva del raccordo. »
«Che cosa vendeva? » ho chiesto.
La zia mi ha scrutata con aria di sfida. «Non lo capisci? Vendeva il suo corpo. Era una donna capace
soltanto di aprire le gambe. »
Da quel giorno, ogni volta che parlava di lei, la zia Elide la chiamava così. La donna che apriva le gambe.
L'ho sopportato per più di un anno. Poi un mattino, mentre eravamo in cucina, appena lei è partita dicendo:
«Era capace solo... » non ci ho visto più.
«Sapeva spalancare anche le braccia! » le ho gridato.
La zia è diventata pallidissima.
«Disgraziata», ha sibilato, «con tutti i sacrifici che facciamo per te. »
Allora ho preso un tizzone dal caminetto con le pinze e l'ho sventolato vicino alle tende.
«Toccami e do fuoco a tutto. »
E' arrivato lo zio in suo soccorso: «Il fuoco si spegne con l'acqua» e mi ha gettato in faccia il contenuto della
brocca.
E' stato da quel giorno che ho cominciato ad odiarli?
Credo di sì.
Ero nella mia camera e scrivevo dei bigliettini. Vi odio, voglio che moriate, vi prenda sotto un'auto, vi venga
un colpo, una malattia tremenda. Alle scritte, univo dei disegni, poi facevo tutto a pezzettini, andavo in
bagno e, prima
di farli sparire, ci scaricavo le mie cose sopra.
Davanti a loro, però, facevo finta di niente, mi sforzavo di essere gentile. Avevo paura delle rappresaglie. Lo
zio minacciava sempre di chiudermi nella legnaia perché era piena di topi, ragni e serpenti. Per vincere la
paura, avevo
iniziato ad andarci da sola. Lì nessuno mi trovava e nessuno mi dava fastidio. In breve tempo, la legnaia era
diventata il mio rifugio prefe rito. Gli esseri umani ormai mi facevano più paura dei topi e dei serpenti.
Una volta, mentre andavo in bicicletta, per una strada bianca, avevo incontrato una donna con due bambini.
Urlava come una pazza perché a pochi metri da lei c'era una biscia. Per mostrarle che non faceva niente di
male sono scesa, l'ho afferrata per la coda e gliel'ho messa sotto il naso. «Vede», le ho detto, «basta
prenderle per la coda. Mica ce la fanno a rivoltarsi». Invece di ringraziarmi, lei ha continuato a urlare come
un'ossessa.
Il giorno dopo, tutto il paese diceva che dovevo avere qualcosa che non andava perché giravo con i serpenti
in tasca e li accarezzavo sul muso, come si accarezzano i cani.

III.
A tredici anni ero più che stufa degli zii. Il solo immaginare le loro voci e le loro facce mi metteva in uno stato
di profondo disagio. Così, qualche giorno prima di Natale, ho deciso che quell'anno non sarei andata da
loro. Ho chiesto
un colloquio con la direttrice e gliel'ho detto.
«Perché? » mi ha chiesto guardandomi dritta negli occhi,
«Perché non mi va.»
«C'è qualche problema? »
«Nessuno. Loro sono vecchi e io mi annoio. Tutto qui.»
«Allora mi dispiace, ma devi andare, Il tribunale ti ha affidato a loro. E poi stare da soli il giorno di Natale è
diverso che stare da soli in qualsiasi altro giorno dell'anno. Se restassi qui, finiresti per pentirti.»
Per tutta la notte, ho covato l'idea di fuggire, ma al mattino ho fatto la stessa identica cosa degli anni prima.
Ho preso la corriera e sono
andata alla cascina.
I biscotti erano già nel forno.
«Finalmente sei arrivata! » ha gridato la zia, vedendomi entrare. «Cambiati e pulisci i conigli. Poi vieni qui,
che c'è da spennare il cappone. »
Tutta l'antivigilia ho lavorato per lei.
La sera è cominciata a cadere una pioggerellina ghiacciata. Abbiamo mangiato in silenzio sul tavolo di
formica della cucina, davanti al televisore acceso. I vetri erano coperti dal vapore. In una grande pentola
bolliva il tacchino.
Era troppo grande e così, dall'alto, uscivano i moncherini delle zampe.
Ho lavato i piatti e sono andata a letto. Le lenzuola erano ghiacciate e la trapunta sembrava bagnata. Vuom
grnn vuom. Dalla finestra chiusa veniva il rumore delle macchine. Mi sentivo triste, quella tristezza quieta
che precede il
pianto. Alle labbra, per abitudine, mi è salita una preghiera ma l'ho ricacciata indietro. Ero ormai troppo
grande per gli orsacchiotti e non riuscivo più ad aggrapparmi alle preghiere.
Qual era allora l'antidoto alla tristezza? Volevo piangere ma dagli occhi non usciva niente. Sentivo il mio
corpo come fosse quello di un'altra persona. Ho provato ad abbracciarmi. Freddo su freddo. Un abbraccio
tra due serpenti, tra
due pezzi di ferraglia. Adesso salto giù dalla finestra, ho pensato. Probabilmente non muoio ma almeno mi
spezzo le gambe o la spina dorsale, passo il Natale in ospedale e il resto dei miei giorni su una sedia a
rotelle. In quel preciso istante mi è parso di sentire il profumo della mamma. Ho acceso la luce. Nella stanza
non c'era nessuno. Da dove veniva? C'era davvero o me l'ero soltanto sognato? Sul soffitto, sopra al letto,
era comparsa una macchia di muffa.
Sembrava il muso di un orso o quello di una scimmia con la bocca aperta.
Dal piano di sotto saliva ancora il rumore della televisione. I due monoliti stavano lì, sulle poltrone coperte
dal cellophane antipolvere.
Due insetti stecchiti. Due mummie incartapecorite. La zia ordinava e lo zio obbediva. «Sì, Elide. Va bene,
Elide. Hai ragione, Elide.»
Per tutta la Vigilia ho cercato di stare tranquilla. La zia diceva una cosa e io subito la eseguivo. Facevo tutto
con gli occhi bassi, perché non riuscisse a leggermi dentro. Ogni tanto andavo nella mia stanza e
scaraventavo con forza
il cuscino contro il muro, poi vi tuffavo il volto dentro e urlavo in silenzio.
La sera avremmo aperto i pacchetti, ci saremmo scambiati i baci di ringraziamento, avremmo divorato il
tacchino freddo davanti a uno spettacolo di varietà e lo zio avrebbe riso alle battute più cretine, le più
volgari.
Mi aspettavo la sesta camicia bianca, invece ho ricevuto un paio di guanti di lana blu, con rinforzi in
similpelle. Anch'io ho sorpreso gli zii. Invece del solito vasetto fatto con le mie mani o delle presine
all'uncinetto, ho regalato loro una pera e una mela avvolte in un bel fiocco rosso. Da anni, scartando i doni,
la zia ripeteva sospirando: «Com'era bello il Natale quando l'unico dono erano due noci e un'arancia! ». Così
l'ho accontentata.
Poi ci siamo seduti a tavola. Proprio mentre la zia si stava lamentando che i tortelloni non erano venuti bene
come l'anno precedente e lo zio la rassicurava dicendo che, anzi, forse erano anche più buoni, qualcuno ha
suonato alla porta. La zia ha tirato su il collo come un tacchino.
«Chi può essere a quest'ora? E in una giornata come questa? »
Io mi sono alzata e sono andata ad aprire.

Era un negro con un grande borsone. Vendeva mutande e asciugamani. Il bianco dei suoi occhi brillava
nella notte.
«Vuoi comprare belle cose? » mi ha chiesto.
«Vieni dentro», ho detto, «c'è la cena di Natale. »
La zia è balzata subito in piedi: «Chi è? » ha gridato. «Come ti viene in mente di farlo entrare? »
«E' o non è la cena di Natale? » ho risposto.
«Lo è, ma non per lui. Se era un cristiano, non andava certo in giro questa sera a vendere i suoi stracci. »
Lo zio si è alzato in piedi e con una mano, debolmente, ha toccato la mano del negro.
«Grazie», ha detto per mostrare la sua autorità virile, «non abbiamo bisogno di niente» e l'ha accompagnato
alla porta.
«Hai chiuso bene a chiave? » gli ha domandato la zia, quando è rientrato.
«Certo. »
Abbiamo ripreso a mangiare in silenzio. Sul video, dei bambini di tutti i colori, conciati come scimmie del
circo, stavano cantando delle melense canzoncine di Natale, gli adulti intorno battevano le mani con gli
occhi lustri.
Ho sbattuto il cucchiaio sul bordo del piatto.
I monoliti hanno alzato lo sguardo.
«E se fosse stato Gesù?» ho detto.
La zia si è alzata a raccogliere i piatti. «Non dire cretinate. Gesù non era negro. E poi non andava in giro a
vendere mutande. »
Quando mi è passato davanti il piatto con le fette di tacchino bollito, ho pensato, sembrano pezzi di
cadavere. Anzi sono pezzi di cadavere, e l'ho lasciato li.
«Come fai a sapere che non ti piace, se neanche lo assaggi? »
Invece di mandarla al diavolo, ho detto solo:
«Non ho più fame».
Con la forchetta, ha infilzato una fetta e me l'ha sbattuta nel piatto. «Lo mangi lo stesso. »
A quel punto è successa una cosa strana. Ho sentito il cuore che cominciava a gonfiarsi.
Sembrava che avessero svitato un'arteria e, al suo posto, avessero attaccato una pompa di bicicletta. Il
manometro saliva e il cuore diventava più largo. Cosa sarebbe successo se fosse andato a sbattere contro il
lato tagliente delle costole?
Così ho aperto la bocca.
«Perché non parliamo dell'amore?»
Di che amore? ha chiesto subito Collo di tacchino.
«Non lo so. Lo chiedo a voi. Quanti amori esistono? Due? Tre? Quattro? Dieci? Mille? Visto che siete
sposati, almeno uno dovreste conoscerlo, no? Ci si sposa per quello, no? Oppure voi... »
Lo zio si è alzato in piedi. Tremava tutto.
«Porta rispetto o... »
«Ho solo fatto una domanda! Non so cos'è l'amore, dove sta. Non so neppure se davvero esiste e come... »
La zia mi ha interrotto con un sorrisetto:
«Dovevi chiederlo a tua madre. Lei era una vera specialista».
In quell'istante il cuore ha toccato le costole spingendo ogni cosa fuori posto. Ho preso la fetta di tacchino
con le mani, l'ho sbattuta per terra e l'ho schiacciata forte sotto la scarpa.
«Detesto la carne» ho gridato. «La detesto! » E
sono uscita sbattendo la porta con violenza.
Faceva freddo e non avevo preso la giacca.
La bici della zia era appoggiata al muro, sono salita e ho cominciato a pedalare. Non sapevo da che parte
andare, sentivo soltanto un'incredibile forza nelle gambe.
Nel cielo c'erano un po' di nuvole e un po' di stelle.
La rotella della dinamo faceva vrrrr contro il cerchione della ruota, la luce del fanale era debole,
intermittente, fendeva di pochissimo il buio della notte.
Quasi senza rendermene conto sono arrivata alla stazione. Mancava poco alle dieci e il piccolo ristoro era
ancora aperto. Sono entrata e ho detto: «Una grappa».
Era la prima volta nella mia vita che ordinavo qualcosa di diverso da una cioccolata calda.
Il primo sorso mi ha fatto tossire e anche il secondo. Al terzo ho sentito le gambe diventare morbide. In un
angolo brillavano le luci di un flipper.
«A che ora passa il prossimo treno?» ho chiesto.
«L'ultimo è già passato», mi ha risposto l'uomo al banco, pulendo i bicchieri. «E il prossimo passa domani
mattina.»
Aveva una faccia larga con grandi baffi spioventi. Magari è lui mio padre, ho pensato.
La mamma era venuta come me in stazione, fuggiva da qualcosa e aveva paura, se ne stava zitta in un
angolo e lui, fingendo di consolarla, l'aveva schiacciata con il suo corpo enorme contro il muro del gabinetto.
E nove mesi dopo

ero venuta al mondo io.
Avevo finito di bere e mi sentivo strana.
«Lei ha figli?» gli ho chiesto stupidamente.
«Purtroppo no», ha risposto lui. «Però, ti posso dire lo stesso che non è bello che tu te ne stia qui a
quest'ora. Adesso io chiudo il locale e tu torni a casa, d'accordo?»
Mi ha accompagnata alla porta e ha tirato giù la serranda. Aveva una 127 decrepita, ci ha impiegato un bel
po' prima di metterla in moto. A ogni tentativo, la marmitta tremava come dovesse staccarsi. Poi si è
allontanato lasciando dietro di sé una scia di nuvoloni bianchi.
Tornare a casa? Che cosa mi aspettava, a casa? E se invece fossi tornata in collegio? Magari anche lì non
c'era più nessuno, tutte le suore erano andate a trovare le famiglie. Dopo la volta del tizzone, non avevo mai
osato ribellarmi in quel modo agli zii. Al massimo, ero stata un po' maleducata. Come mi avrebbero accolto?
In fondo, ero da sempre un'ospite sgradita.
Ho alzato lo sguardo, un satellite attraversava il cielo come fosse la cometa. Era la notte di Natale. Forse le
mie paure erano paure inutili.
Forse con la sua coda incandescente la stella aveva scaldato anche il cuore degli zii. Avrei suonato alla
porta e, per la prima volta, mi avrebbero accolto a braccia aperte.
Stavo già pedalando verso casa, quando ho sentito una voce chiamarmi. Era il venditore di mutande.
Fumava seduto tra i borsoni della mercanzia.
«Sei qui», ho detto.
Mi ha fatto segno di sedermi e mi ha offerto la sua sigaretta. Una, due, tre boccate. Alla terza, qualcuno ha
preso il mio stomaco e l'ha capovolto. Dov'ero? Ero su una barca? Mi veniva da vomitare come se ci fosse il
mare grosso.
Tutto mi girava intorno. Sì, ero su una barca e la barca stava affondando, roteavo nel gorgo che mi avrebbe
portato a fondo. «Mai fumato?»
ha chiesto il negro. La sua mano si è posata sulla mia gamba, in alto, vicino all'inguine.
Di colpo, il gorgo si è fermato e sono scoppiata a ridere. La notte era nera, la strada era nera, il venditore di
mutande era nero. Di che colore era l'anima? Forse era anche lei nera, per questo mi era sempre sfuggita.
Invece di sprofondare, adesso brancolavo. Tendevo le mani avanti come quando si gioca a mosca cieca.
Dov'era il limite delle cose? Non riuscivo più a trovarlo.
Alle nostre spalle è passato un treno. Il suo rumore ha coperto le sue parole. Che odore era quell'odore?
Odore di bosco, di giungla, odore di animale che insegue e che viene inseguito. Il suo corpo era vicinissimo,
così vicino da schiacciare il mio. Voleva scaldarmi? e allora perché premeva così forte? Non mi veniva più
da ridere ma da piangere. Vedevo il bianco dei suoi occhi, le sue mani erano scomparse nella notte.
Quante mani aveva? Mi sembrava di sentirle dappertutto. Quando nella mia bocca è entrata una specie di
lumaca prepotente, per difendermi ho chiuso di scatto i denti.
A un tratto, mi sono trovata a terra. Lui gridava cose che non capivo e sputava. Poi mi è arrivato un calcio
nella schiena.
Subito dopo, ero sulla bici e pedalavo.
Pedalavo e pedalavo nella notte con il fanale spento e tutto mi sembrava assolutamente fermo. Le gambe
erano pesanti come quelle degli incubi, quando devi scappare ma più niente risponde ai tuoi comandi. Prima
ero sudata. Poi
il sudore si è trasformato in ghiaccio. Una macchina, superandomi a tutta velocità, ha suonato con rabbia il
clacson. Ho quasi perso l'equilibrio. Quando ho rimesso i piedi a terra mi sono guardata intorno e non ho
riconosciuto niente. Né un cartello, né un semaforo, né un capannone.
Dove stavo andando? E chi ero? Osservavo quelle dita che stringevano i freni come le dita di uno
sconosciuto. Come mi chiamavo? Era come cercare di prendere un pesce con le mani, più lo inseguivo, più
mi sfuggiva. Non c'era nessuno intorno a cui poter chiedere: «Sa chi sono?».
All'improvviso al mio interno si è formata un'enorme cavità e in quella cavità mi aggiravo con l'occhio
sbarrato e la bocca spalancata, come un pesce nell'acquario. Ero il pesce e anche il suo proprietario.
Esistevo e mi guardavo esistere. E pur esistendo e guardandomi esistere, non ero ancora certa di esistere.
Poi, a un tratto, tutte insieme, hanno cominciato a suonare le campane. Così mi sono risvegliata. E' Natale,
ho detto, e sono Rosa. La Rosa uscita di casa con il tacchino sotto i piedi, la Rosa che nessuno vuole, la
Rosa tutta spine e
niente fiore, la Rosa che ha appena preso un calcio dal negro. Mi sono guardata intorno e ho finalmente
capito dov'ero, così ho ripreso a pedalare verso il paese.
Se non avessi fumato quella sigaretta sarebbe andato tutto in modo diverso? Chi lo può sapere? Avevo la
grappa nello stomaco, la prima grappa della mia vita. Con il fumo, la grappa si era trasformata in dinamite.
Non pedalavo con calma ma con rabbia. Il fanale era ancora spento, ma la dinamo girava ugualmente. Non
caricava la luce, ma l'oscurità del mio cuore. A ogni giro della catena, quel dolore confuso, quel senso vago
di umiliazione si

trasformavano in odio. Un odio puro, trasparente e indistruttibile come il carbonio nella composizione del
diamante. Salendo alla bocca, l'odio si trasformava in parole. Sfrecciavo lungo la provinciale e gridavo.
«Andate tutti all'inferno! Crepate tutti, stronzi bastardi merdosi!»
Ecco, il cuore aveva toccato le costole, vi era rimasto impigliato come un palloncino tra i rami di un albero.
Per farlo scoppiare, sarebbe bastato un minuscolo movimento. Le costole erano come coltelli. Respiravo e
si conficcavano nella carne. Più respiravo, più il dolore diventava lancinante. Su un ventricolo forse si era
formato un ascesso e adesso, finalmente, stava spurgando.
Il piazzale della chiesa parrocchiale era pieno di macchine. Dalle vetrate filtrava la lu ce calda delle candele.
Ho scaraventato a terra la bicicletta. Se avessi trovato qualcuno davanti alla porta, gli avrei dato un pugno.
Non
l'ho trovato, così ho spalancato la porta con un calcio.
E' successo tutto molto rapidamente. La chiesa era piena di gente. Nonostante l'omelia, tutti si sono girati a
guardarmi. Ho attraversato la navata centrale a grandi passi.
«Mi fate tutti schifo! » ho gridato, «e sapete perché? Perché non siete altro che dei luridi, schifosi sepolcri
imbiancati!»
Il parroco è rimasto a bocca aperta con un braccio sospeso in aria. Qualche ragazzo si è messo a ridere.
Sono andata al presepe, ho preso il bambino dalla mangiatoia e l'ho sollevato sulla mia testa, come un
trofeo.
«Sapete cos'è questo?» ho urlato, roteandolo in aria. «Volete davvero sapere cos'è? E' una piccola, stupida
statua! »
Nessuno fiatava, tutti mi guardavano sgomenti.
«Voi adorate una statua! » ho detto, prima di scaraventarla in mezzo alla navata. «Soltanto una statua! »
Il rumore del bambino che andava in pezzi li ha risvegliati. Si sono fatti tutti il segno della croce. Ho visto la
zia accasciarsi in prima fila, lo zio balzare fuori per prendermi.
Don Firmato ha afferrato il candelabro e si è precipitato verso di me.
Sono riuscita a fuggire per la navata di sinistra. Passando al volo, ho strappato i cartelloni colorati del
catechismo. A grandi lettere, c'era
scritto: "L'amore è...". Li ho gettati sulle candele di sant'Antonio. In meno di un secondo hanno preso fuoco.
Io ero già sulla porta.
Prima di uscire, mi sono girata e ho gridato ancora, con tutto il fiato che avevo in gola.
«Ascolta, Firmato porco! Amore sarebbe baciare la Maddalena, non vomitarle in faccia! »
Poi ho iuforcato la bici e sono tornata a casa.
Volevo morire? Probabilmente sì. La casa era vuota. In fondo al camino, ardevano ancora le braci.
All'improvviso, non sapevo più che cosa fare.
Mi sentivo svuotata. Non era più il cuore a pulsare, ma la testa. Sentivo un dolore fortissimo in mezzo agli
occhi. Tutto girava. Mi sono lasciata cadere sul cellophane della poltrona. Cosa sarebbe successo adesso?
Sarebbero venuti i carabinieri e mi avrebbero arrestato? O forse la zia mi avrebbe ucciso. Come aveva detto
quel giorno al maresciallo?, «con le mie stesse mani».
Ero troppo stanca per provare una qualsiasi
forma di paura. Niente andava bene e dunque tutto andava bene. Non lontano, un cane ululava in modo
triste. Dalla provinciale, giungeva il rumore delle auto che tornavano a casa.
«Mamma.. . » ho detto prima di addormentarmi e, nel breve sonno, ho sognato un suo abbraccio. Mi
stringeva forte, sorridendo, senza dire niente. Poi, a un tratto, la zia stava sopra di me, urlava con le molle
del camino in mano.
Quando le molle mi sono arrivate addosso, ho capito che non era più un sogno. Non mi andava più di
morire, così ho cercato di sgusciare via dalla poltrona.
«Non farla scappare, prendila! » gridava allo zio. Lo zio mi è piombato addosso come un giocatore di rugby.
Siamo scivolati distesi in mezzo al corridoio.
«Io ti ammazzo! Ti ammazzo, bastarda figlia di Satana! » continuava a gridare la zia. E colpiva. Colpiva
come quando sbatteva le trapunte, colpiva alla cieca, con furore. Cercavo di coprirmi la testa con le braccia.
Quando ho visto il sangue, ho cominciato a urlare anch'io.
«Ammazzami! Amnmazzami pure! Così finalmente ti porto con me all'inferno! »
Ha vibrato ancora un paio di colpi, sempre più deboli, poi ha scagliato le molle per terra.
Con le mani si è coperta il volto ed è scoppiata in singhiozzi.
Il cane dei vicini stava ancora latrando.
Sono rimasta a letto per due giorni. Non avevo voglia di mangiare, non avevo voglia di niente. Già muovere
una gamba mi sembrava impossibile. Ogni tanto dormivo, ogni tanto guardavo le muffe sul soffitto.
Il pomeriggio del secondo giorno, ho sentito la voce del maresciallo giù in cucina. Non era venuto per
portarmi via, come speravo, ma so!tanto per dire che don Firmato, per rispetto alla devozione e alla fede
della zia, aveva ritirato
la denuncia. «Anzi», ha aggiunto poi, «nel paese le sono tutti molto vicini.»
La zia l'ha ringraziato con un filo di voce.

«E pensare che io l'avevo presa in casa soltanto per fare un'opera buona. Senza padre, e orfana di quella
madre! E noi siamo anche anziani. Speravamo di salvarla, maresciallo. Lei mi capisce. E adesso dobbiamo
portare questa croce. »
Prima di uscire, il maresciallo aveva detto:
«Coraggio!».
Il terzo giorno, quando gli zii sono usciti per andare al centro commerciale, sono scesa al piano di sotto, ho
preso la bottiglia dell'alkermes per dolci e mi sono nascosta nella legnaia.
IV.
Quanti strati di pelle esistono nel nostro corpo? Ci sono ustioni di primo grado, di secondo e di terzo. C'è
l'abrasione lieve, quando si urta qualcosa, e quella in cui la pelle viene letteralmente scorticata. Tra una e
l'altra c'è la stessa differenza che corre tra un leggero fastidio e la sopravvivenza. La pelle serve per farci
respirare, per proteggere gli strati di tessuto più fragili.
A me, quanti strati erano rimasti?
Bevevo l'alkermes seduta sul cavalletto per tagliare la legna e mi guardavo il braccio. In un punto la pelle
c'era, in un altro no. Il dolore avrebbe dovuto essere limitato, invece, con i suoi tentacoli correva dappertutto.
Forse anche
la faccia ormai era nuda. Non era più rosa ma rosso scarlatto. Doveva sembrare quella di una scimmia del
Borneo. O quella del demonio.
L'inferno c'era o non c'era? Se il niente stava sopra le nostre teste, il niente stava anche sotto i nostri piedi?
O piuttosto, tra i due poli c'era un grosso squilibrio? Sopra, un cielo crepitante e leggero come un velo di
tulle e, sotto, tutti gli scarti, tutta la limatura di ferro del mondo? Forse per questo la terra stava insieme,
perché il centro era di una pesantezza straordinaria.
C'era fuoco, là sotto, e piombo e stagno e carbone. E c'erano anche tutte le anime più sporche. Si
rotolavano tra le fiamme come i maiali si rotolano nel fango. Senza il centro pesante, il nostro pianeta
sarebbe stato come una meringa.
Voluminoso ma leggerissimo. Non sarebbe riuscito a mantenere la sua rotta neppure per una frazione di
secondo. Uscendo di strada, sarebbe esploso come una palla di neve contro il cristallo di un'auto. Dunque
se stavamo ancora qui, il
centro doveva essere per forza pesante. Pesante e abitato, come la mela è abitata dal baco.
Ogni casa ha un proprietario. Qual era il volto del padrone dell'inferno? Era lo stesso che dominava i nostri
giorni?
Quando avevo strappato il cartellone con sopra scritto: "L'amore è..." e lo avevo avvicinato alle fiamme,
aveva preso immediatamente fuoco. Avrebbe potuto opporre almeno un po' di resistenza, prima di farsi
consumare, lottare per una manciata di minuti. Così la gente avrebbe potuto dire: «Vedi? L'amore resiste al
fuoco. O quanto meno ci prova...».
L'amore vince tutto, avevo spesso sentito ripetere. L'amore è più forte della morte. E invece non era vero,
perché l'amore, anche se esiste, è fragile. E' così fragile da essere pressoché invisibile. Ed essere invisibile
e non esistere è quasi la stessa cosa. Il fumo di un incendio si può scorgere a chilo metri di distanza, per
anni tutt'intorno resta il segno delle fiamme. L'amore invece non si riesce a vedere neppure se ci si mette il
naso sopra.
Anch'io bruciavo. Mi bruciava il corpo e bruciavo dentro. Per questo bevevo, per avere una qualche forma di
sollievo. Ma era un sollievo di breve durata. Mi sarei dovuta rotolare nella neve ghiacciata oppure avrei
dovuto gridare
con voce tremenda ciò che mi veniva dal cuore.
"Odio" era la mia parola preferita. Ho cominciato a ripeterla piano, a fior di labbra. Ti odio. Vi odio. Mi odio.
Ti odio. Vi odio. Mi odio.
Poi ho tolto il pronome ed è rimasto soltanto "odio". L'ho rivoltato ed è diventato "oido".
Separando le lettere, l'ho trasformato in "O
dio"...
Perché tutti avevano paura di finire all'inferno? Mi avrebbe fatto molto più paura finire in paradiso. Avrei
anche potuto sostenere lo sguardo di Satana, ma quello di Dio! Assolutamente impossibile. Lui avrebbe
visto la mia pochezza.
Mi avrebbe disprezzato, come mi disprezzavano il parroco e la zia. E poi, avevo rotto la statua di Gesù.
L'avevo rotta nella notte più sacra, quella in cui era nato. Dove avrei mai potuto andare, se pure esisteva un
altro mondo?

La sera, nel letto, ho pensato: come esistono preghiere all'angelo, ne esisteranno pure rivolte al diavolo. Ho
provato a ripetere l'Angelo di Dio, sostituendo l'invocazione. Poi, però, non riuscivo ad addormentarmi.
Avevo l'impressione che la macchia sul soffitto avesse mille occhi.
Occhi fluorescenti e lingue che brillavano saettando nell'oscurità della stanza. Mi sono svegliata nel cuore
della notte al suono della mia voce. Urlavo. Per un attimo mi è sembrato che la macchia sul soffitto fosse
una grande scimmia con la bocca sporca di sangue e gli occhi di brace e che mi stesse precipitando
addosso.
I rimanenti giorni di vacanza li ho passati come un clandestino su una nave. Sempre chiusa in camera mia.
Appena loro uscivano, scendevo in cucina.
Il quattro di gennaio ho deciso di tornare in collegio. L'ho comunicato alla zia mentre stava nel pollaio. Non
ha detto né sì né no né «buon viaggio». Non ha neppure alzato il viso dal secchio del becchime.
Ho messo le mie poche cose nella borsa. La corriera partiva a mezzogiorno. Lo zio era a caccia. Quando la
zia è uscita per andare al mercato, al cibo dei conigli e delle galline ho mescolato del veleno per topi.
«Sei già qui?» ha osservato la superiora, vedendomi arrivare.
Siamo entrate nel suo studio. Nell'angolo fumava un bollitore elettrico. La suora l'ha spento, ha versato
l'acqua nella teiera e si è seduta di fronte a me.
«E' successo qualcosa? » mi ha chiesto.
Ho alzato le spalle. «Assolutamente niente.
Mi annoiavo. »
Cominciavo a provare disagio per l'insistenza del suo sguardo.
«Cosa ti sei fatta in testa?»
« Sono caduta dalla bicicletta. »
La pendola dietro la scrivania ha battuto le quattro e mezzo. Fuori era quasi buio. La mano della superiora
ha sfiorato la mia. La sua voce era bassa, calma.
«Rosa, perché non dici la verità? Da me non devi temere nulla. »
«Non esiste la verità.»
«Ne sei sicura? »
Ho risposto la prima cosa che mi è venuta in mente.
«A me nessuno vuole bene. Che io viva o muoia è indifferente. »
«Ti sbagli, io te ne voglio.»
«Lei vuole solo incassare la retta. »
«Cosa posso fare perché tu cambi idea? »
«Niente. »
«Vuoi che chiami lo psicologo? »
«Detesto gli psicologi. »
«E allora?»
«Va bene così.»
«Non credo che vada bene.»
«A me va bene così e questo basta.»
A quel punto ho sentito le sue mani sulle mie, erano piccole e piuttosto fredde.
«Perché non mi guardi negli occhi?»
«Non è mica obbligatorio. »
«Non è obbligatorio, ma sarebbe gentile.»
«Della gentilezza non mi importa niente.»
In quell'istante è suonata la campanella del rosario.
La superiora si è alzata in piedi.
«Devo andare, ma prima che tu esca ti voglio dire due cose. La prima è questa: la porta del mio studio e
della mia stanza sono sempre aperte, che sia giorno o notte, se hai voglia di parlare puoi spingerle ed
entrare... »
«E la seconda?»
«Ricordati che non hai nessuna responsabilità del tuo passato ma ne hai molta riguardo al tuo futuro. Il
futuro è nelle tue mani e sarai tu a costruirlo. Per questo ti invito a riflettere e ad aprirti prima di compiere
qualche sciocchezza. »
I mesi seguenti sono stati mesi di oscurità, squarciati da bagliori improvvisi e violentissimi. Tutto mi
sembrava inutile, non sopportavo la compagnia di nessuno. Andavo a scuola e non sentivo neppure una
delle parole dei professori. Passavo ore china sui libri ma davanti a me scorrevano soltanto pagine e pagine
opache.
Mi mancava un solo anno al diploma, ma neppure questo riusciva a darmi gioia.
Il mio futuro era come le pagine, opaco.
Probabilmente sarei tornata alla cascina e avrei passato il resto dei miei giorni a pulire la
cacca dei conigli e delle galline. Un giorno, gli zii sarebbero morti e io sarei diventata la padrona di tutto, ma
sarebbe stato troppo tardi. Ormai brutta e vecchia, non avrei trovato più nessuno con cui vivere. O forse, un

giorno avrei mollato ogni cosa e mi sarei messa a vivere per strada, insieme ai cani. Loro, almeno, mi
avrebbero voluto bene. Oppure, niente di tutto questo. Sarei semplicemente rimasta alla cascina e, anno
dopo anno, la nebbia mi sarebbe entrata dentro, avrebbe divorato le mie ossa. A divorare il cervello ci
avrebbe pensato l'alcool. Tra i buchi del naso e quelli delle orecchie ci sarebbe stato il buio fondo di una
stiva. Sarebbe circolata una sola idea là dentro, vecchia come il mondo: il modo migliore di farla finita. Così,
un giorno, strascinando i piedi, avrei raggiunto la legnaia e mi sarei appesa alla trave più alta. In cronaca, mi
avrebbero dedicato appena un trafiletto:
Squilibrata trovata morta nella sua casa.
Intanto intorno a me, le compagne parlavano soltanto del proprio futuro. C'era chi pensava a sposarsi e chi
sognava di andare all'università. Una voleva fare l'infermiera e un'altra entrare nella guardia forestale. Della
più timida e
silenziosa, si diceva che volesse prendere i voti e restare chiusa per sempre là dentro. Io non dicevo a
nessuno ciò che pensavo. Se qualcuna mi interrogava, rispondevo nel modo più banale.
Studierò computer, aiuterò gli zii in campagna.
Succede, alle volte, che dal mare all'improvviso spunti un'isola che prima non esisteva o che la lava di un
vulcano crei o cancelli un'intera regione. A me stava capitando un po' la stessa cosa, non era un'isola quella
che nasceva
dentro di me bensì una palude. Era una palude senza albe né tramonti, il vento non stormiva tra le sue
canne e neppure tra le fronde dei salici. L'aria era buia, ferma. Nell'aria buia e ferma, il fango fermentava
emanando miasmi.
Durante la notte li sentivo uscire lentamente dagli orifizi del mio corpo. Era odore di metano, odore di zolfo,
odore di qualcosa che marciva nel profondo.
L'inverno è passato e le giornate hanno cominciato a diventare più lunghe. I passeri e i merli correvano
indaffarati da una parte all'altra del giardino, mentre sui rami già si gonfiavano le gemme. Tra l'erba dei fossi
e dei pendii
comparivano i primi fiori, il lillà delle viole, il giallo chiaro delle primule. Ogni cosa sfiorata dal sole ritornava
alla vita. Con il cambio di stagione, anche la fermentazione della palude aveva prodotto qualche forma di
energia. Non è successo forse lo stesso ai primordi del mondo?
Nelle pozze senza ossigeno a un certo punto gli
aminoacidi sono impazziti e hanno dato luogo alla vita. Non sono impazziti da soli ma con l'aiuto di un
fulmine. Un fulmine caduto nell'acqua che ha prodotto il cortocircuito. Anche dentro di me cominciavano a
cadere fulmini, fischiavano ed esplodevano come i botti della fine dell'anno. Per un istante la loro luce
bianca stracciava il velo dell'oscurità. Camminavo per
i lunghi corridoi e mi chiedevo, per quanto tempo ancora potrò tenere nascosta quest'energia tremenda?
Il cortocircuito è avvenuto a Pasqua, durante la messa. A un tratto, durante l'offertorio, i fulmini hanno
lasciato la loro traiettoria solita e invece di spegnersi nella palude, si sono diretti verso la testa. In una
frazione di secondo ho visto tutto e sono diventata cieca, ho sentito tutto e sono diventata sorda. Dentro di
me c'era potenza, energia, devastazione. Correvo verso il
muro e vi sbattevo contro. Tra la fronte e la parete, chi l'avrebbe avuta vinta? In qualche modo cercavo un
interruttore, un pulsante, qualcosa che smorzasse la corrente. Lo cercavo e non lo cercavo.
Quando una mano ha tentato di fermarmi, per prima cosa l'ho morsa. La cerimonia si è interrotta. Qualcuno
ha gridato: «Presto, un dottore!». Sentivo le urla di chi correva verso l'uscita.
Poi qualcosa è entrato nel mio corpo, un ago probabilmente. Quello che era fuoco, rapidamente si è
trasformato in nebbia. Sono odio, furore, ho pensato, prima di venire inghiottita. Sono io e non sono io. Pura
voglia di distruggere.
V.
Sono rimasta all'ospedale quattro giorni.
L'elettroencefalogramma è risultato assolutamente perfetto. Ogni mattina veniva un medico e mi chiedeva:
«Sei sicura di non aver preso qualcosa? E magari di averci bevuto sopra?».
Ma dalle analisi risultavo pulita.
Anche le suore mi facevano domande. «Hai forse sbattuto la testa? » E io: «Certo, durante le vacanze di
Natale. Sono caduta dalla bicicletta».
Non ero mai stata abile a dire bugie, ma improvvisamente lo ero diventata. Sapevo imbro- gliare gli altri,
manovrarli. Sapevo fingere un volto innocente mentre al mio interno balenavano pensieri terribili. Per la
prima volta nella mia vita mi sentivo sicura, capace, potente. Quand'ero sola mi ripetevo: mentire e avere in
mano il mondo sono i due lati della stessa medaglia.

Tornata in collegio sono diventata l'ospite più tranquilla, la più devota. Ero la prima a correre al rosario e la
sera, nella camerata, du rante le preghiere la mia voce sovrastava le altre. In chiesa, davanti al tabernacolo,
ero l'unica a genuflettermi fino a toccare il pavimento.
Potevo farlo, potevo permettermi di farlo perché ormai sapevo che era vuoto. Il crocifisso era una statua e là
sotto c'erano soltanto delle cialde.
Inchinarsi lì davanti o inchinarsi davanti a un fustino di detersivo era esattamente la stessa cosa.
Sentivo che ormai il mio sguardo e il mio pensiero coincidevano. Uno era acciaio e l'altro il taglio della lama.
Dell'amore non mi importava più niente, era un totem che adoravano in troppi e, come tutti i totem, era
vuoto. Importava che io fossi forte, che io fossi in grado di prendere in mano la mia vita, di dirigerla in modo
da trarne il massimo beneficio.
La lucidità era il mio cavallo di battaglia, vedere le cose come sono e non come si vorrebbe che fossero.
Durante la messa, osservando tutti quei capi chini intorno a me, dovevo compiere un grande sforzo per non
scoppiare in una risata. In fondo, mi dicevo stringendo le labbra, la compassione deve essere questa, capire
che sono soltanto delle poveracce, non conoscono altra vita che quella dello schiavo, per questo hanno
bisogno di credere che nel cielo ci sia qualcuno. Al momento del Padre Nostro, aprivo le mani verso l'alto
come aspettassi la manna e dicevo: «Padre nostro che non sei in cielo e da nessuna altra parte...».
Naturalmente volevo qualcosa di più. Volevo l'assoluta certezza che tutto fosse una truffa. Avevo già
percorso molte strade ma mi mancava ancora la più irta. Quella del sacrilegio a cuore freddo. La notte di
Natale, al momento di scaraventare il Bambino, avevo fumato e bevuto, non c'era scienza in quel gesto
ma soltanto rabbia. Adesso desideravo la dimostrazione perfetta del teorema.
Dio può uccidere chi vuole e in mille diversi modi, tutta la Bibbia, nero su bianco, sta lì a dimostrarlo. Se Dio
esiste, mi dicevo, farà cadere sulla mia persona una punizione spaventosa. Se invece non esiste, non
succederà nulla.
Di notte, ho raggiunto lo studio della superiora. Non mi aveva mentito, la porta era sempre aperta. Sul tavolo
non c'era niente di interessante, così ho cercato nei cassetti. Lì ho avuto più fortuna, c'erano un rosario
consunto dall'uso e una piccola croce di legno con sopra scritto "Jerusalem".
Dalla mia mano sono finiti direttamente nella tazza del cesso.
Tornata a letto, ho dormito un sonno profondo e privo di sogni.
Dopo una settimana il gabinetto si è intasato. E' venuto l'idraulico a smontarlo. Ha tirato
fuori il rosario e la croce, avvolti nella carta igienica come nel velo di una sposa.
Sul collegio è scesa una cappa di gelo. Ci sono stati interrogatori, incontri con il padre confessore, indagini a
tappeto. Io stessa ero meravigliata della mia abilità nel mentire, della naturalezza con cui lo facevo.
Per dieci giorni non si è parlato di altro. C'è stata una cerimonia di riconsacrazione degli oggetti oltraggiati.
Poi, anche su quel fatto è
sceso l'oblio.
Sono tornata nell'ufficio della superiora ai primi di giugno. E' stata lei a convocarmi. Ero convinta si trattasse
della solita visita di routine prima delle vacanze. Invece, subito dopo avermi fatto accomodare, mi ha detto:
«Mi dispiace, Rosa, ma non possiamo più tenerti qui».
E' seguito un lungo silenzio. Dalla finestra
aperta entrava l'odore del gelsomino.
«Perché?» avrei dovuto chiedere ma non ne avevo voglia. Quando ho aperto la bocca ho detto soltanto:
«Va bene».
«Fino alla maggiore età starai dagli zii. . . »
«Va bene...»
La superiora si è seduta di fronte a me. Dal sospiro che ha fatto, ho capito che ormai era una persona
vecchia. Di nuovo le sue mani piccole e fredde sulle mie.
«Non vuoi dire nient'altro? »
«Che cosa dovrei dire? Siete voi che avete deciso, non io.»
«Perché non mi apri il tuo cuore? »
«Il cuore è una scatola. »
«Nelle scatole c'è sempre qualcosa.»
«La mia scatola è vuota.»
«Permettimi di non crederci.»
«E' libera di credere o non credere quello che vuole. »
«Rosa, c'è qualcosa che mi nascondi? Sono molto preoccupata per te.»
«Visto che sto per andarmene, la mia vita non la riguarda più. »
«La prima volta che ho preso la tua mano tra le mie avevi quasi otto anni. »
Cominciavo ad essere stufa.
«Pazienza», ho detto, alzandomi. «Tutto passa. »
«L'amore non passa», aveva risposto inseguendomi sulla porta. Mi stringeva con le sue mani gracili.
«Ricordati che io sono sempre qui e ti aspetto. Qualsiasi cosa mi dirai, l'accetterò,»
Era patetica.

«Va bene», ho risposto secca.
«Abbracciami almeno, fatti dare un bacio.»
Mi sono chinata alla sua altezza. La pelle delle guance era morbida e fresca.
Gli zii mi hanno accolto in silenzio. Al loro silenzio, ho opposto il mio. Nessuno più mi chiedeva di andare in
chiesa, non avevo più l'obbligo delle buone maniere, da me tutti si aspettavano il peggio ed io non facevo
nessuna fatica nell'offrirglielo.
Invece di correre ad aiutare la zia, la mattina dormivo fino a tardi. Scendevo a fare colazione quando loro
stavano pranzando. Le narici di Collo di Tacchino erano dilatate dal furore ma, invece di saltarmi alla gola,
stava zitta. Il
giorno del ritorno le avevo detto: «Se soltanto mi sfiori faccio uno scandalo tale che per la vergogna dovrai
cambiare paese». Per questo stava ferma, immobile, con la bocca chiusa e, appena uscivo, se la prendeva
con il marito. In fondo ero sua nipote, era stato lui a portarle quella croce in casa. L'orfanella che aveva
adottato per carità cristiana e che eternamente avrebbe dovuto esserle grata, le si era rivoltata contro come
una serpe con i denti pieni di veleno.
Quando il sole smorzava un po' la sua forza, prendevo la bicicletta della zia e me ne andavo in giro per le
strade bianche. Aspettavo il crepuscolo per vedere le lucciole e spesso rimanevo a guardare anche le stelle.
Quando rientravo gli zii dormivano già da un pezzo. Anche se lo zio non ne aveva voglia, la zia lo trascinava
comunque a letto con le galline. Allora andavo nel salottino e aprivo l'armadietto dei liquori. C'erano tre o
quattro bottiglie, stavano lì da anni, regalo di qualcuno che probabilmente era già morto. Ho cominciato con
la Vecchia Romagna e ho proseguito con l'Amaretto. Mi sdraiavo sul divano e finalmente sentivo caldo. Non
il caldo esterno del sole d'agosto ma un caldo che veniva da dentro. Lo stesso caldo delle tempeste di baci.
Dopo due settimane le bottiglie erano vuote.
Tornavo a casa e avevo bisogno di bere. Così ho cominciato a prendere i soldi dalla giacca dello zio.
Quando lui se ne è accorto e ha nascosto il portafoglio, ho iniziato ad andare in giro per le chiese dei paesi
vicini. Portavo con me un filo di ferro ritorto e lo infilavo nella cassetta delle offerte. Con uno o due pomeriggi
di lavoro riuscivo sempre a comprare un'altra bottiglia di liquore.
In settembre avrei dovuto iscrivermi a scuola, sforzarmi in un modo o nell'altro di finire gli studi. In realtà
avevo un solo pensiero in mente, il compimento della maggiore età. Mi sentivo come un velocista in
prossimità della partenza, i muscoli erano tesi, lo sguardo rivolto verso il traguardo. Volevo andare lontano,
mostrare a tutti di cos'ero capace.
Alla fine di dicembre compivo gli anni. A metà di ottobre ho cominciato ad organizzare la fuga.
Dopo un mese, rispondendo ad un annuncio, ho trovato la mia strada. Nella città vicina, una famiglia
cercava una ragazza alla pari.
Avrei dovuto occuparmi di una bambina, accompagnarla a scuola, in piscina. In cambio avrei avuto una
stanza con il bagno tutta per me, un piccolo compenso e la possibilità di frequentare un corso di istruzione.
Ero andata a conoscerli e ci eravamo piaciuti. Al loro ritorno dalla settimana bianca, in gennaio, avrei co
minciato il lavoro. Naturalmente non avevo detto niente agli zii. Avevo aspettato per mesi con la stessa
pazienza di un ragno che tesse la tela.
Il giorno precedente alla partenza, ho comprato una bottiglia di spumante. Prima di uscire di casa l'ho
lasciata sul tavolo, accanto a due bicchieri e a un biglietto. «Finalmente potete brindare. La croce se ne va
con le sue gambe. »
Fuori era ancora buio, sulla provinciale già correvano le macchine dei pendolari.
Da qualche parte suonava una campana.
Finché non sono scomparsa alla sua vista, il cane dei vicini ha continuato ad abbaiare.
VI.
Poche cose al mondo sono delicate come le piante d'appartamento. Basta un cambiamento d'esposizione,
uno spiffero microscopico, perché in pochi giorni passino dal massimo rigo- glio alla morte.
La casa nuova era piena di piante. Era un doppio attico con molte finestre sul tetto. Sotto ogni spicchio di
luce cresceva una piccola foresta.
Giulia, la mamma della bambina, le amava molto e appena arrivata, per prima cosa, mi ha insegnato ad
avere cura di loro. Bagnandole e lustrandone le foglie, non ho potuto fare a meno di pensare alle piante che
crescevano in collegio, giallognole, tristi, stentate. Un pothos che cadeva polveroso da un armadio, un vaso
di miseria in fondo al corridoio.
Le piante parlano del luogo in cui vivono ma parlano anche di chi vive loro intorno. Nel collegio a nessuno
importava niente di loro, mentre qui erano trattate con amore.
Con il passare dei giorni mi sono resa conto che quello che succede alle piante non è poi molto diverso da
quello che succede agli uomini. Dalle suore, ero una pianta delle suore, una pianta opaca dalle foglie

smorte. Dagli zii, ero una pianta che moriva di sete, mi avevano comprato convinti che fossi di plastica.
Nella nuova casa, invece, ero una pianta che si abbeverava di luce. La luce mi entrava dentro e faceva
evaporare la nebbia, l'aria penetrava nei pori e scacciava la polvere. La mattina mi guardavo allo specchio e
ripetevo il mio nome. «Rosa», dicevo piano, come se mi vedessi per la prima volta.
Per anni ero stata una pentola con il coperchio. Bollivo, bollivo e la condensa restava dentro. Lentamente la
condensa stava scomparendo. Sentivo nuovi discorsi intorno a me, scoprivo un modo diverso di affrontare
la vita. Ascoltavo e sapevo che era quello il modo giusto di vivere, il modo che avrebbe dovuto essere mio
fin dall'inizio.
I primi giorni la signora Giulia mi aveva seguita passo passo. Aveva voluto vedere come me la cavavo ai
fornelli. Mi aveva insegnato i tre o quattro piatti preferiti dalla figlia. Aveva valutato se ero capace o meno di
seguirla nei
compiti. Siccome tutto andava bene, dopo una settimana mi aveva lasciata libera ed era tornata a
insegnare.
Tra noi era nata una simpatia immediata.
Era molto affettuosa con me e io rispondevo al suo affetto cercando di eseguire i miei compiti nel migliore
dei modi. Non so quanti anni potesse avere, di sicuro più di quaranta perché aveva già parecchi capelli
bianchi. Una volta,
mescolando un risotto, aveva detto: «Ai figli ho pensato solo all'ultimo momento». Il marito doveva avere
pressappoco la stessa età. Forse un
paio di anni in più. Si erano conosciuti all'università, mi aveva raccontato la signora Giulia.
Lui ormai era un architetto famoso e aveva un grande studio dove, spesso, restava a lavorare fino a tardi.
Era alto, con una barba ben curata, elegante e, oltre all'architettura, amava molto la musica. Quando lui era
in casa, le note del suo potente stereo invadevano tutte le stanze.
La sera, prima di addormentarmi, dall'abbaino guardavo le stelle, gli aeroplani e i satelliti. Guardandoli,
immaginavo che la signora Giulia e l'architetto fossero i miei veri genitori, quelli che avrebbero dovuto
adottarmi al posto
degli zii. E pensavo che adesso, anche se in ritardo di una decina di anni, ero finalmente arrivata alla mia
vera casa.
Pranzavo e cenavo insieme a loro e, la sera, guardavamo la televisione seduti sullo stesso divano. Dopo
qualche settimana ho cominciato a intervenire anche nelle loro conversazioni. Mi chiedevano: «Che ne
pensi, Rosa? » e io rispondevo liberamente. Nessuno rideva quando parlavo, anzi sembravano ascoltarmi
con un certo interesse. Per la prima volta sentivo che le mie idee erano degne di rispetto e non sfiguravano
accanto a quelle delle persone normali.
La mia camera era in mansarda, accanto a quella di Annalisa, la bambina. L'abbaino era proprio sopra il
letto così la sera, quando non riuscivo a prendere sonno, potevo guardare il cielo.
Il collegio, la cascina esistevano ormai in una nebulosa differente, li vedevo piccoli, lontani, inoffensivi.
Erano spariti dalla mia vita e stavano per sparire dalla mia memoria. Ormai ero nella famiglia giusta, quella
in cui sarei dovuta nascere.
Osservavo il cielo e poi, sotto le coperte, ripetevo le parole proibite da sempre. Papà.
Mamma. Papà.
Dov'era finita la ragazza che tutte le sere si ubriacava nel salotto? Quella ragazza che, per più di dieci anni,
aveva vissuto prigioniera tra lo
squallore della cascina e la tristezza del collegio? Dell'odio che aveva dominato così a lungo il mio cuore,
riuscivo a intravedere appena
qualche traccia. Era come un temporale che, dopo essersi sfogato imitando la fine del mondo, tutt'a un tratto
finisce e corre veloce verso un'altra regione. Per terra l'erba è ancora bagnata, qualche albero si è
incendiato ma lui è già lontano. Quella sottile linea viola in fuga verso l'orizzonte non fa più paura.
L'unica cosa che mi dava un po' fastidio, in quella casa, era la bambina. L'avevano viziata in modo
spaventoso. Bastava che alzasse un dito per indicare una cosa e, subito, l'otteneva.
La madre l'abbracciava spesso, sembrava volesse stritolarla. «So che sbaglio», diceva, «ma non posso
farne a meno. Quando si diventa genitori così tardi, si è anche un po' nonni. »
Annalisa era arrogante e nervosa. Quando eravamo sole, mi trattava come una vecchia scarpa.
Naturalmente, io non glielo pennettevo
e, se nessuno mi vedeva, le stringevo forte i polsi. Non per farle male, soltanto per farle capire chi
comandava in quel gioco.
Una mattina, siamo andate in un grande negozio del centro per rinnovare il suo guardaroba. Passando
davanti allo specchio, mi sono un po' vergognata. Lei sembrava la principessa e io Cenerentola. I miei vestiti
erano ancora quelli della cascina, quelli del collegio. Sotto le luci impietose del negozio, mostravano la loro
vera natura di stracci.
La commessa ha dovuto mostrare decine di vestiti. La madre glieli provava e lei faceva i capricci perché era
stufa.

«Come ti sembra, Rosa?» mi chiedeva, di tanto in tanto, la signora Giulia e io davo il mio parere. Troppo
largo. Troppo vistoso. Poco adatto.
Quando sul banco si sono accumulati una decina di capi la commessa ha chiesto: «Basta così?».
«Ma sì. Basta così», ha risposto la signora.
«Adesso passiamo alla ragazza? »
All'improvviso ho sentito le guance bruciar mi come dopo una lunga corsa. Ero stata scambiata per la sorella
di Annalisa. Che cosa avrebbe risposto la signora? «Oh no, lei non c'entra, è una persona di servizio»?
Oppure...
Tenevo gli occhi bassi quando l'ho sentita dire: «Ma si. Passiamo alla ragazza».
Abbiamo dovuto cambiare reparto. Attraversando il negozio, mi sentivo come ubriaca, ero incerta, in
imbarazzo.
La commessa ha fatto scorrere l'anta di un grande armadio. Mentre sceglieva i vestiti, si è messa a
chiacchierare con la signora.
«Al giorno d'oggi i ragazzi sono tutti così.
Vogliono soltanto le cose smesse. Più sono di buona famiglia, più amano sembrare degli straccioni. Lei non
ci crederà, signora, ma ho visto delle madri implorare le figlie di accettare un vestito. E' che noi siamo così,
copiamo tutto dagli americani. Tutto il peggio, intendo.»
Poi ha preso un bel vestito di cotone azzurro fiordaliso e me l'ha posato addosso: «Che ne dice di questo?
Oppure osiamo qualcosa di un
pochino più vistoso?».
«Sì, più colore», ha annuito la signora, «qualcosa sul verde. Un verde che le faccia risaltare gli occhi. »
Ne ho provati quattro o cinque. Ogni volta che uscivo dalla cabina, mi sentivo una persona diversa. A un
certo punto, la signora Giulia mi è venuta accanto e mi ha tirato su i capelli, guardandomi nello specchio.
«Lo vedi come sei carina, quando ti valorizzi! »
Siamo uscite dal negozio con due buste in mano, una per me, l'altra per Annalisa.
Per la prima volta, nella mia vita, facevo attenzione al mio aspetto fisico. Fino ad allora, avevo badato
soltanto a ciò che c'era dentro.
Non avevo mai pensato che potesse essere importante il modo in cui gli altri mi vedevano.
Cominciavo a rendermi conto di non essere né troppo magra, né troppo grassa. Non ero altissima, ma
neppure bassa. Se lasciavo i capelli sciolti sulle spalle e mi guardavo allo specchio, di fronte a me vedevo
una bella ragazza.
Poco tempo dopo la visita al negozio, la signora ha cominciato a insistere perché riprendessi gli studi
interrotti. Non faceva altro che ripetere: «Ti manca solo un anno, è un peccato buttare via tutto. E poi, con la
testa che hai, non vorrai mica fare la bambinaia tutta la vita?».
Ci ho riflettuto per un po', poi le ho dato ragione. A quel punto, che senso aveva lasciar chiudere le strade
che si aprivano? Non avevo più mura intorno a me. Avrei potuto studiare lettere o filosofia o medicina. Tutti
si aspettavano che io facessi una brutta fine, quella di mia madre, tanto per intenderci, invece io sarei
diventata qualcuno di importante. Un grande medico. Un filosofo intervistato da tutti i giornali.
La settimana dopo ho cominciato a frequentare una scuola serale. In classe erano tutti adulti e mi trovavo
perfettamente a mio agio.
Andavo lì con l'autobus e, alla fine delle lezioni, spesso veniva a prendermi l'architetto. Il suo studio era dalla
stessa parte della città e non era
raro che lui vi rimanesse fino a tardi.
Le prime volte ero molto intimidita. Salivo in macchina in silenzio e in silenzio rimanevo per tutto il percorso.
Con lui, non avevo la stessa confidenza che avevo con la moglie. Non c'erano mai stati uomini nella mia
vita, a parte lo
zio che più che un uomo era una larva. Sentivo comunque che accanto a lui succedeva qualcosa di strano.
Se mi chiedeva qualcosa, la mia voce usciva troppo acuta o troppo bassa. Se mi guardava, sudavo come
fossi una fontana.
Si accorgeva della mia timidezza? Non lo so.
Guidava con gesti calmi, la sua concentrazione sembrava essere tutta per la strada. Frena, va' in folle,
cambia marcia, riparti.
Poi una sera, fermi a un semaforo, si è girato e ha detto: «Dai, raccontami un po' di te».
Non ero pronta a quella domanda, così ho balbettato qualche frase stentata. Per mentire avevo bisogno di
tempo. Poi la barriera è caduta e le parole sono uscite con naturalezza. Mio padre era morto in un incidente
sul lavoro, poco
prima della mia nascita. Lavorava nella polizia e un camion impazzito l'aveva travolto mentre stava facendo
dei rilievi in mezzo a un raccordo.
Mia madre, invece, era una professoressa di latino. Un giorno, tornando da scuola, aveva avuto un malore
ed era finita fuori strada. Così, a poCo più di sette anni, ero rimasta completamente orfana. Avevo due zii,
persone buone e laboriose, ma erano molto anziani e non potevano tenermi con loro. Per questo ero
cresciuta in un collegio.

Ogni tanto, durante il racconto, lui faceva dei brevi commenti. «Davvero?» «Ma va'!»
«Che sfortuna!» Alla fine mi ha chiesto: «E come ti trovavi in collegio?».
«Era un posto bellissimo», ho risposto.
«Avevo una camera con il bagno tutta per me, che si affacciava su un parco curatissimo. C'erano il tennis e
la piscina coperta. Solo che... »
«Che cosa...?»
«Non sono mai riuscita a credere a quelle loro storie. »
« Quali storie? »
«Le storie delle suore. Gesù e tutto il resto.
Il paradiso e l'inferno... Quelle cose che si inventano per tenerci buoni. Ci ho creduto un po' all'inizio, finché
ero piccola. Appena sono cresciuta, ho capito che era tutta una truffa.»
L'architetto si è voltato a guardarmi.
«Una truffa... » ha ripetuto, ridendo. «Senti che tipetto! »
La settimana seguente, mentre aspettavo l'autobus per andare a scuola, è passato davanti alla fermata. Ha
spalancato la portiera, dicendo: «Sali?».
Pensavo che mi desse un passaggio, invece appena salita ha esclamato allegro: «Oggi si marina! Facciamo
una gita! ».
Ho tentato di oppormi, mancava poco agli esami, non mi andava di perdere una lezione.
Lui mi ha subito zittita. «Sei così brava. Cosa vuoi che succeda, se manchi una volta! »
Mi ha portata in un ristorante fuori città, sulle colline. Era la fine di aprile, l'aria era ancora troppo umida per
stare all'aperto, così abbiamo mangiato in una specie di veranda. La tovaglia era a quadretti bianchi e rossi,
intorno a noi c'erano pochi tavoli occupati. Ha ordinato del vino. Ne ho bevuto un bicchiere a stomaCo vuoto
e mi è subito andato alla testa.
Lui sorseggiava il suo lentamente fissandomi dritta negli occhi, poi, con voce più bassa del solito ha detto:
«Lo sai che mi affascini? Sei così giovane ma hai tante idee. Raccontami ancora di te, come l'altra sera».
«Che cosa?»
«Non lo so. Della truffa, per esempio. »
Ho bevuto un altro bicchiere e ho ripreso a parlare. Ho cominciato dall'inizio, dal Gesù con il cuore in mano
che non mi aveva protetto e tanto meno aveva protetto mia madre. Avevo continuato poi con il crocifisso del
collegio che ascoltava tutte le suppliche e non rispondeva a nessuna. Quando hanno portato le tagliatelle,
era la volta di don Firmato e della notte di Natale.
L'architetto era così preso dalle mie parole che quasi si scordava di mangiare; appena mi interrompevo per
qualche istante, subito mi incalzava dicendo: «E poi?». Così sono arrivata all'Angelo di Dio e al Padre
Nostro modificati,
mormorati ogni sera nel silenzio della mia stanza. Ho raccontato poi, per filo e per segno, la vicenda del
rosario nel cesso. Il fatto che io fossi ancora viva era la dimostrazione perfetta del mio teorema. Il cielo era
uno spazio vuoto.
Sembrava rapito dalle mie parole, ogni tanto scuoteva la testa, altre volte scoppiava a ridere. «Non ci posso
credere! Davvero hai fatto
questo? » Allora io mi dilungavo, aggiungendo compiaciuta dei dettagli.
Prima che portassero il dolce, mi ha sfiorato con delicatezza la mano. «Sei proprio una persona
straordinaria, sai? Sei così giovane e già così libera dentro. Io ho raggiunto la tua chiarezza poco prima dei
trent'anni. Solo allora ho capito che l'unica vita che vale la pena di essere vissuta è quella in cui non ci si
pone alcun limite. Bisogna aprire la porta e buttare fuori le
remore, i sensi di colpa. Non è così? »
«Certo! » ho risposto con la voce di un professore che finisce la lezione.
Quella sera, nel letto, ho provato nuovamente la sensazione del tepore che veniva da dentro. Per tanti anni
ero rimasta senza padre.
Adesso ero contenta di aver dovuto aspettare così a lungo. Non avrei potuto trovarne uno migliore.
L'architetto, che ormai chiamavo solo Franco, approvava tutto quel che dicevo come io condividevo ogni
cosa che usciva dalla sua
bocca. Sembravamo davvero padre e figlia.
Prima di addormentarmi ho pensato che in fondo anche l'adozione non era ormai più un'idea così pazza.
Probabilmente, in un tempo non troppo lungo, gli zii se ne sarebbero andati all'inferno e io sarei stata libera
di diventare la figlia di qualcun altro. Era vero che loro, di figlia, ne avevano già una, ma non avrebbe mai
dato loro le soddisfazioni che avrei potuto dare io.
Sembrava piuttosto stupida. E poi era troppo capricciosa per riuscire a combinare qualcosa.
Lo sapeva la signora Giulia che, ogni tanto, noi due andavamo a cena da soli? La seconda volta, tornando a
casa, avrei voluto chiederglielo, ma poi, non so perché, la domanda mi è morta in gola. Anche quando stavo
con lei, non sono mai
riuscita a dire: «Sa, ieri sera sono uscita a cena con suo marito». Avevo rapporti intensi e profondi con
entrambi, anche se in modo diverso. Per

questo intuivo che era giusto tenerli distinti.
I primi di maggio Franco è partito. Doveva tenere un corso di due settimane in un'università straniera. In
quel periodo, la signora Giulia non stava quasi mai a casa. Verso le sette di sera telefonava con voce
divertita dicendo: «Rosa, anche stasera resto fuori. Ad Annalisa dai la solita pastina».
Io mi sentivo addosso un'inquietudine completamente nuova. Ancora non sapevo che l'amore non è un
nastro di raso che orna i polsi, ma una catena che li Sega.
Mettevo la bambina a dormire il prima possibile e poi andavo nello studio di Franco ad annusare le sue
cose, le penne, le matite, i fogli di carta. Dall'odore riuscivo a ricostruire il suo volto e il calore della sua voce.
Poi mi sedevo al suo posto, prendevo i libri in mano e li aprivo.
Non erano libri di architettura bensì di filosofia. In alcuni, molte frasi erano sottolineate.
Leggevo e capivo che erano le stesse frasi che avrei sottolineato anch'io.
La sera seguente al suo ritorno, Franco è venuto a prendermi a scuola. Ha fermato la macchina in una
strada laterale e ha tirato fuori due pacchetti.
«Per te» ha detto.
Era il primo regalo che ricevevo dopo le camicie bianche degli zii. Mi sentivo confusa.
«Li apro adesso?»
«Certo. »
Ho scartato per primo il più grande. Dentro c'era una felpa. Era nera e aveva disegnata davanti una Tour
Eiffel colorata, con sotto scritto Paris.
«Oh, grazie», ho detto, baciandolo sulle guance. «E' bellissima. »
Poi ho iniziato a scartare il secondo pacchetto. «Che cosa sarà?»
Lui sorrideva. «Apri e vedrai.»
La carta era rosso bordeaux, leggera come velina. Scivolava sotto le dita con estrema facilità. Ho intravisto
due cose bianche e molli e le ho sollevate con le dita. Si trattava di un reggiseno e un reggicalze, entrambi
di pizzo bianco.
«Ti piacciono? » mi ha chiesto lui, avvicinando il suo volto al mio. «Li ho visti in una vetrina e ho pensato
che forse non avevi mai avuto niente di simile. Non sono una ragazza, ma credo che si provi un certo
piacere a essere belle anche sotto. O no?»
«Credo di sì.»
«Non mi sembri entusiasta.»
«Sì, lo sono. »
«Comunque, se non ti piacciono, non sei costretta a metterli. Puoi lasciarli nel cassetto o regalarli. »
Ha messo in moto la macchina e ha cominciato a guidare in silenzio, guardando fisso davanti a sé.
Forse, senza volerlo, lo avevo offeso. Ho preso nuovamente la biancheria in mano.
«E' veramente bellissima! Non vedo l'ora di indossarla. Cos'è, seta?»
«Sì, seta.»
Dal finestrino aperto entrava l'aria calda e profumata di maggio. Volevo prendere tempo, riparare all'offesa
fatta.
«Perché non andiamo a prendere un gelato?» ho detto.
Poco dopo, eravamo seduti nella gelateria all'aperto di un quartiere residenziale.
Non avevo più voglia di cose fresche e dolci ma di qualcosa di forte, così ho ordinato un whisky.
«Sei sicura di quello che fai? » mi ha chiesto.
E finalmente ha sorriso di nuovo.
Erano molti mesi che non bevevo superalcolici. Non avevo ancora cenato e lo stomaco ha cominciato a
bruciarmi già ai primi sorsi. Il bicchiere mi sembrava piccolo; così, appena finito, ne ho chiesto un altro.
Franco ha preso la mia mano tra le sue, aveva dita affusolate, forti e morbide, calde. Ha avvicinato le sue
labbra al mio orecchio, sussurrando: «Devi dimenticare qualcosa?».
Alle nostre spalle cresceva una pianta di gelsomino. I fiori si erano aperti e l'odore era così forte da dare la
nausea. Davanti a noi c'era un
gruppo di ragazzi in motorino, qualcuno fumava, altri leccavano il gelato seduti a cavalcioni dei sellini.
Prima di parlare sono scivolata con lo sguardo in un punto buio della notte. Poi ho aperto la bocca e ho
cominciato: «Mia madre non era una professoressa dilatino, ma una puttana. E' morta schiacciata vicino ad
un falò sul raccordo anulare...».
Quella notte, avrei dovuto sentire dentro di me la leggerezza che segue le grandi imprese. In fondo, per la
prima volta nella mia vita, mi ero liberata di un peso. Anzi del peso. Avrei dovuto sprofondare subito in un
sonno felicemente
ininterrotto. Invece, appena ho spento la luce, l'angoscia ha cominciato a divorarmi. Perché avevo parlato?
Per sentirmi più protetta? O perché pensavo che sarei stata più protetta? Per quale ragione allora mi sentivo
minacciata?
Anche se non avevo il coraggio di ammetterlo, in qualche luogo di me profondissimo stava già avvenendo il
pentimento. Come mi era venuto in mente di raccontare il mio segreto? Quel segreto era il motore della mia
forza, la volontà furiosa che mi permetteva di non attaccarmi a niente e superare ogni ostacolo.

Adesso quel segreto era una cosa nota, lo sapeva un'altra persona che avrebbe potuto andare in giro a
raccontarlo a tutti. Forse Franco stesso aveva già cominciato a disprezzarmi. Il giorno dopo, incontrandomi
in cucina, non avrebbe neanche alzato lo sguardo per salutarmi.
Nel riquadro dell'abbaino erano apparse nubi gonfie e biancastre. Correvano veloci e in pochi minuti hanno
coperto la luna e le stelle.
Domani piove, ho pensato, e a un tratto ho capito. L'amore è darsi in pasto all'altro senza possibilità di
difendersi.
VII.
Al mio esame di maturità mancava poco più di un mese. A tavola discutevamo su quello che avrei fatto
dopo. La signora Giulia e Franco non erano contrari al proseguimento dei miei studi. Annalisa la mattina
andava a scuola e
dunque ero completamente libera.
A malincuore avevo scartato architettura perché non capivo niente di matematica. L'indecisione era tra
lingue e filosofia.
La signora Giulia insisteva per la prima ipotesi. Se sai le lingue, diceva, puoi lavorare in molti campi
differenti e poi puoi muoverti, viaggiare.
Franco, invece, era favorevole a filosofia.
«Sarebbe un vero peccato sprecare la testa che hai... » Secondo lui, nelle aule di filosofia, avrei trovato la
mia realizzazione perché mi piaceva speculare sui massimi sistemi e lo sapevo fare con una
spregiudicatezza che era raro trovare
in una persona tanto giovane.
Franco amava questo lato del mio carattere. Per farmi amare di più avevo imparato ad accentuarlo. Gli
chiedevo in prestito dei libri
di filosofia. Invece di studiare, passavo il tempo a leggerli e la sera stavamo alzati a discutere fino a tardi.
«Tu hai avuto il grande privilegio», mi ha detto un giorno, «di crescere senza amore. Per questo fin da
subito, hai potuto essere libera.
Guardi le cose e le vedi come sono. Non hai bisogno di costruirci strane teorie.»
«L'amore è una sostanza tossica», ripeteva spesso, «perché ti avvelena dentro costringendoti sempre e
comunque a fare ciò che non vuoi. Invece le persone come te sono libere. Stai lì e vai avanti. Conquisti ogni
cosa come una nave rompighiaccio. »
«Ma tu ti sei sposato», ho ribattuto un giorno.
E' scoppiato a ridere. «L'amore e il matrimonio non sono la stessa cosa! Ci si sposa per i soldi, per la
società, per la biologia, non certo per amore. Perché credi che Giulia ed io andiamo tanto d'accordo?
Perché abbiamo messo in chiaro questo fin dall'inizio. Ci eravamo simpatici e tutti e due volevamo un figlio.
Per il resto siamo completamente liberi. »
Io lo ascoltavo e annuivo. Annuivo e ascoltavo. Non mi stancavo mai di parlare con lui.
Mi sentivo superiore, lontana da tutto, da tutti, protetta dall'affetto di quell'uomo più grande, di quel quasi
padre che mi stava accanto.
Verso la metà di giugno, Annalisa e la signora Giulia sono andate una settimana al mare. La scuola era
finita.
Il giorno della loro partenza, Franco mi ha portato a cena da un suo amico. Era un professore di filosofia e
voleva che parlassi con lui per chiarirmi le idee sul mio futuro. L'ho trovato un pensiero gentile.
Il pomeriggio ero libera, così mi sono preparata con calma. Ho fatto una lunga doccia fresca e poi ho scelto
con cura i vestiti. Non avevo ancora indossato la biancheria di Parigi e mi è sembrata l'occasione migliore
per farlo.
Prima di uscire, Franco mi ha offerto un aperitivo sulla terrazza. L'aria era tiepida, carica dei profumi che
preannunziano l'estate. Sulle nostre teste sfrecciavano, incrociandosi nel- l'aria, decine e decine di
balestrucci.
«Vedrai», mi ha detto, «Aldo è un tipo incredibile. Ti piacerà. Ci conosciamo fin da ragazzi. »
Mezz'ora dopo eravamo dall'amico. Anche lui abitava in un attico, ma senza terrazza.
La prima cosa che mi ha colpito è stata la bruttezza. Basso, grassoccio e calvo, aveva sul viso ancora i
segni di un'acne giovanile. Sembrava uno di quei rospi che d'inverno s'assopiscono sotto le pietre. Però era
simpatico. Mi ha stretto
la mano con calore dicendo: «E' questa dunque la famosa Rosa! » e poi ha continuato a parlare con la
velocità di una mitragliatrice. «Con che vino
vogliamo cominciare? Con il bianco, con il rosso o magari con un Aperol o un Campari? Preferiamo sederci
subito a tavola oppure rilassarci un po' in salotto? »

«Questa è la sera di Rosa», ha detto Franco.
«Sara lei a decidere. »
Ho tentato di protestare debolmente: «Non è mica la mia festa».
Aldo è scoppiato a ridere. La sua risata era uguale al suo modo di parlare.
«In qualche modo lo è. Non è una festa lasciare il mondo dell'adolescenza per diventare grandi? »
«Tra qualche mese sarai una matricola di filosofia», ha precisato Franco, «e dunque tutto cambierà. »
«Allora vino bianco», ho detto e subito dopo abbiamo fatto un brindisi.
«Ai tuoi studi!» hanno detto, alzando i calici. «Alla tua vita!»
Poco dopo ci siamo messi a tavola.
Aldo non era sposato. La cena era stata preparata dalla colf il giorno prima e lui aveva comprato qualcosa in
rosticceria.
«Mi dispiace di essere un cuoco così scadente», ha detto.
«Non ha nessuna importanza», ho risposto io, come se fossi una vecchia amica. «L'importante è stare
insieme. »
Il vino mi aveva sciolto la lingua. Non ricordo di cosa abbiamo cominciato a parlare ma ricordo invece una
sensazione precisa. Mi sentivo brillante, sicura di me. Dov'era finita la Rosa che era vissuta fino ad allora?
La Rosa incerta,
opaca? La Rosa con il suo invisibile zaino di pietre sulle spalle? Era come se una bacchetta magica avesse
cancellato i diciotto anni precedenti.
Quella sera, Rosa era una giovane donna affascinante, capace di intrattenere due uomini più grandi e
intelligenti senza mai annoiarli.
Rosa era una miniera sconosciuta anche a se stessa. Bastava scavare appena un poco per trovare un
tesoro nascosto.
Verso la fine della cena Aldo mi ha chiesto:
«Che cosa saresti disposta a fare per avere un bel po' di soldi?».
Sono scoppiata a ridere. «Dipende quanti.»
«Diciamo un miliardo. »
«Per un miliardo farei qualsiasi cosa.»
«Anche uccidere? »
Sono rimasta in silenzio. Ho visto la zia di fronte a me che mi colpiva con l'attizzatoio. In fondo uccidere
poteva anche essere una forma
di piacere. Che male ne sarebbe venuto al mondo se una come lei fosse scomparsa? Persino lo zio ne
sarebbe stato felice.
«Sì, anche uccidere. »
In quel momento è suonato il telefono ma Aldo non è andato a rispondere.
Adesso era Franco a interrogarrni.
«E che cosa non faresti per nessuna cifra? »
Per prendere tempo mi sono pulita le labbra con il tovagliolo, ho bevuto tutto il vino del bicchiere, ho passato
nuovamente il tovagliolo sulla bocca e poi ho detto: «Non rinuncerei alle
mie idee. Le idee non hanno un prezzo».
Franco e Aldo hanno insistito per sparec chiare senza il mio aiuto. «Altrimenti, che festeggiata saresti? »
hanno detto. «Intanto rilassati un po' in salotto.»
Mi sono lasciata cadere a peso morto sul divano. Le gambe mi reggevano a malapena.
Sentivo le voci dei miei amici in cucina. Erano allegri, ridevano.
Addosso a me, invece, era caduta una terribile tristezza. Mi era venuto in mente il pappagallo che viveva al
bar dei paese degli zii. Era verde e stava su un trespolo vicino al televisore.
Gli ubriachi erano la sua compagnia abituale.
Più gli facevano domande più lui gridava forte.
Tutti ridevano per le sue battute e lui, per la contentezza, sbatacchiava le ali. Poi, quando il bar chiudeva,
infilava la testa sotto l'ala e, tutto solo e spelacchiato, s'assopiva alla luce del neon.
Che tristezza era quella tristezza? La tristezza della cascina? La tristezza del collegio?
La tristezza della mamma che non c'era più da nessuna parte? Ma era proprio vero che era scomparsa
oppure da qualche parte esisteva ancora? Gli occhi mi stavano diventando pericolosamente umidi. Ho
buttato la testa indietro, come quando si mette il collirio e sono rimasta sorpresa vedendomi riflessa sul
soffitto.
Lassù, era tutto uno specchio.
«A cosa serve?» ho chiesto appena sono tornati.
«A vedere meglio la polvere! » ha risposto Franco.
Aldo rideva. «Non dargli retta. Lo specchio mi serve per controllare che la gente non mi porti via le cose. Ho
tanti libri di valore qua dentro e anche oggetti di piccole dimensioni.
Quando c'è una cosa bella, fa gola a tutti... »

Parlando aveva preso delle cartine e aveva cominciato a mescolare una cosa scura con il tabacco su un
grande libro illustrato. Franco si è seduto accanto a me, posando il suo braccio intorno al mio collo. Aveva
dei pantaloni leggeri, la sua coscia aderiva perfettamente alla mia.
«Una bella festa, eh?»
«Bellissima», ho risposto, ma ormai avevo in mente soltanto il pappagallo. Lui almeno, a un certo punto,
restava solo. Dov'era finita la Rosa di poco prima? Non riuscivo più a trovarla.
Adesso c'era soltanto la Rosa che aveva voglia di piangere.
Quando mi hanno passato la sigaretta ho aspirato con avidità. Aldo si è seduto al mio fianco, dall'altra parte.
La testa ha cominciato a girarmi vorticosamente. Non erano più lacrime a voler uscire ma vomito. Sentivo la
cena
ondeggiare tra lo stomaco e la gola come fossi su una barchetta con il mare grosso.
Di chi era quella mano umida e molle? Di chi era quella voce? Sembrava venire da molto lontano. Cosa
stava dicendo? Perché tiravano fuori mia madre? Ho aperto la mano e mi sono ritrovata con una banconota
sul palmo. L'ho stretta forte come se fosse una maniglia a cui aggrapparmi. Ero seduta o ero distesa? Non
ero in grado di dirlo. Qualcosa di pesante mi schiacciava, volevo spingerlo via ma non avevo
forza nelle braccia. Così ho fatto come si fa quando si incontra un orso. Ho finto di essere morta.
Tempo prima, con Annalisa, avevo visto un documentario sull'addestramento dei cani. All'inizio, i cani
correvano felici e disobbedienti.
Al termine del corso, non c'era più nessuna allegria in loro, vivevano soltanto per rispondere agli ordini.
«Alzati! Siediti! Sdraiati! Prendi in bocca! Lascia! Resta li! Voltati! » La voce dell'istruttore era forte. Se la
voce non bastava,
usava il fischietto. Se anche il fischietto era inutile, passava alla scossa. C'era un elettrodo nel collare e
l'animale si dimenava, gridando dal
dolore.
VIII.
Quella notte e le notti seguenti ho fatto sempre lo stesso sogno. Ero in una grande casa vuota, una casa
piena di corridoi e di stanze. Nonostante in giro ci fosse qualche attrezzo da lavoro, dei mattoni, una
cazzuola, un pennello con
un vaso di colore, sembrava ormai abbandonata da tempo. Le assi del pavimento scricchiolavano e dalle
pareti e dagli stipiti pendevano le ragnatele. Perché mi trovo qui? mi domando, ma non so la risposta. Così
vado avanti. Avanzo
piano, con cautela, tastando in continuazione il terreno. Non so dove dirigermi, ma è chiaro che sto
cercando l'uscita. E proprio mentre scendo dalle scale, sento la voce di un bambino. Invece di giocare o
ridere, sta piangendo. «Cosa succede?» grido nel vuoto della casa. «Qualcuno lo cerchi! Qualcuno lo aiuti!
» In quell'istante mi accorgo che da qualche parte, là dentro, è scoppiato un incendio. Le pareti sono di
legno e già il fumo corre lungo i corridoi. La voce del bambino è sempre più disperata. Invece di mettermi in
salvo, corro a cercarlo. Salgo un piano, salgo l'altro, raggiungo la mansarda e poi corro in
cantina. Le porte non sono più decine ma centinaia e sono tutte chiuse. Il pianto si sposta da una all'altra. Le
fiamme mi inseguono come un branco di cani. Poi il pianto si fa più nitido, più preciso, capisco che qualcuno
là dentro sta facendo del male al bambino. Ho davanti tre porte e una voce mi dice: «Ne potrai aprire una
sola, scegli ma fai presto». Decido per quella a sinistra, allungo le mani per aprirla e solo allora mi accorgo
di avere al posto delle braccia dei tentacoli. Non i tentacoli forti della piovra, ma quelli della medusa,
scivolosi e molli. Li lancio ugualmente verso la maniglia, sembrano spaghetti troppo cotti, s'arrotolano per un
po' intorno e poi scivolano giù. Nel corridoio il calore è quasi insopportabile, le meduse non sopportano le
alte temperature. Sento già i tentacoli delle gambe che stanno cedendo. Morirò squagliata, penso, e in
quell'istante mi accorgo che sopra di me c'è un uomo. E' lui forse che mi ha tirata fuori dall'acqua? O è
venuto qui per aiutarmi?
Ormai sono completamente a terra, il bambino piange sempre più forte. Vorrei tapparmi le orecchie ma non
ho orecchie. Guardo l'uomo e vedo che ha due occhi bui e in mano un arpione. Lo solleva e me lo scaglia
addosso. Sento la punta passarmi attraverso e poi inchiodarmi al pavimento. Un attimo prima di morire, mi
accorgo che la voce del bambino era la mia.
Il giorno dopo, mi sono svegliata nella casa vuota. Franco è rientrato nel primo pomeriggio.
«Cos'è quella faccia? » ha chiesto appena mi ha visto.
«Ho mal di testa.»
«Succede, quando si mescolano i vini.»
Mi ha dato una pillola e dopo poco è uscito di nuovo. Sono rimasta tutto il pomeriggio a casa e anche la
sera. Ad un certo punto ha telefonato la signora Giulia.

«C'è qualcosa che non va? » ha detto sentendo la mia voce.
«Un brutto mal di testa.»
«Sarà lo stress per l'esame.»
Dopo la telefonata, ho preso la vodka dal frigo e l'ho bevuta come fosse acqua. Sono rimasta sul divano
davanti al televisore acceso fino a quando ho trovato la forza di trascinarmi a letto. Ero già lì da un po' nel
dormiveglia quando ho sentito il respiro di Franco. Sapeva di vino e di aglio. Stava sopra di me.
«No», ho detto piano.
«Perché no?»
«Sono stanca. »
«L'importante è che non sia stanco io. »
Chi ha detto che le stelle cadono soltanto nella notte di agosto? Stando lì, con gli occhi aperti, ne ho vista
una luminosissima attraversare il cielo. Cosa desidero? mi sono chiesta. Ma era troppo tardi, la stella era già
scomparsa.
Due sere dopo è stato Aldo a venire a cena da noi. Avrei potuto scappare, invece sono rimasta. Dove avrei
potuto nascondermi?
Ho cominciato a bere già nel primo pomeriggio. All'ora di cena mi reggevo a malapena in piedi. Ricordo solo
che abbiamo riso molto. Ad un certo punto mi sono sentita dire: «Per fare questo, di soldi ne voglio almeno il
triplo!».
Per le troppe risate, avevo il volto inondato di lacrime.
Quando è tornata la signora Giulia avevo il viso coperto di pustole, salivano su dal collo fino alle guance.
Per evitare di vedermi, avevo coperto lo specchio del bagno con uno straccio.
«Sei troppo emotiva», mi aveva sgridata con affetto, «non vale la pena ridursi così per un esame che, alla
fine, è una sciocchezza.»
Per lasciarmi studiare in pace, teneva tutto il giorno Annalisa con sé. Io stavo seduta in camera, davanti ai
libri aperti e bevevo vodka.
Poi mi lavavo i denti, mangiavo caramelle di menta perché non se ne accorgessero.
Per evitare di stare sola con Franco, accompagnavo la signora dappertutto. Appena c'era un silenzio troppo
lungo tra noi, io cominciavo
a parlare. Avevo paura che la verità venisse fuori dalla sua bocca. Che all'improvviso potesse dire: «Cos'è
successo tra te e mio marito?».
Comunque, al momento, non sembrava sospettare niente, continuava a trattarmi con il solito affetto. Forse
la cosa migliore sarebbe stata aprirle il mio cuore e raccontarle come erano andate le cose. Ma, di sicuro,
avrei perso
anche lei e non ero in grado di sopportarlo.
Una sera, Franco mi ha bloccata lungo le scale. Ero scesa in cucina a prendere una bottiglia di vino. C'era
gente a cena e stavano tutti fuori a mangiare in terrazza. Mi premeva con forza contro la parete, sentivo il
suo corpo duro contro la fragilità del mio. Le sue labbra erano all'altezza dei miei occhi, le ho viste muoversi
sussurrando: «Non ti vuoi più divertire? ».
«Adesso urlo.»
Il primo luglio, come tutti gli altri studenti, sono uscita con il vocabolario sotto il braccio per affrontare la
prova scritta. Mentre già ero per le scale, la signora Giulia si è affacciata sulla porta e ha gridato: «In bocca
al lupo!». «Crepi!» ho risposto dal fondo.
Seduta davanti al foglio bianco, l'ho riempito da cima a fondo con la stessa frase. «Non so cosa scrivere,
non so cosa scrivere, non so cosa scrivere... » Quando non c'è stata più neanche una riga libera, mi sono
alzata, l'ho
consegnato e sono uscita dall'aula. Era presto, così me ne sono andata un po' in giro per la città, prima di
tornare a casa.
Alla seconda prova, quella di matematica, non sono neppure andata. Sono uscita all'ora giusta, ho preso un
autobus e poi un altro, per
non correre rischi di essere vista. Mi sono seduta in un bar a fare colazione, poi ho passeggiato per le
strade intorno. A un certo punto, in una via isolata, si è affiancata una macchina. Dentro, c'era un uomo
grosso col naso schiacciato.
«Dove vai tutta sola? » ha detto, sporgendosi dal finestrino aperto.
«Non so dove vado», ho risposto con rabbia, «ma tu, intanto, va' all'inferno. »
L'uomo ha imprecato qualcosa ed è ripartito, sgommando.
Mi sentivo gonfia. Ero nervosa. Il ciclo era in ritardo di una settimana. E' colpa degli esami, mi dicevo, ma
ero la prima a non esserne convinta.
La seconda settimana di luglio, la signora Giulia è tornata al mare con Annalisa. Questa volta Franco è
andato con loro. In quei giorni
avrei dovuto affrontare gli orali.
La mattina della prova, sono rimasta a casa a fare il test di gravidanza.
Era positivo.

Quel pomeriggio ha telefonato Aldo. «So che sei sola», ha detto, «vuoi che venga a farti compagnia? »
Ho buttato giù il telefono senza rispondere.
E adesso? Qualcosa stava crescendo dentro di me come un giorno io ero cresciuta dentro mia madre.
Pensavo con nostalgia alla penombra del collegio, a quel mondo dove ogni cosa aveva il suo giusto posto.
E' impossibile tornare indietro.
In fondo alle gallerie, c'è sempre la luce. Ma se la galleria è un cuneo, in fondo c'è soltanto un buio più
profondo.
Stavo lì, brancolando, e sapevo ormai che quel buio non era un buio apparente. Anche spingendo, tirando
calci, gridando parole magiche, non sarei riuscita ad aprire uno spiraglio.
Forse, fin dall'inizio, avevo scelto il destino del topo che sbaglia direzione e, invece di salire verso l'alto,
scende sotto e cozza contro un muro di roccia.
C'era qualcuno che poteva aiutarmi?
Agli zii non avrei mai dato questa soddisfazione. Vedevo già Collo di Tacchino ripetere con aria tronfia:
«L'avevo detto che eri come tua madre, capace solo di...».
Non mi restava che chiamare la superiora.
Ma con che parole le avrei detto che aspettavo un figlio e non sapevo da chi?
Ho trascorso i tre giorni seguenti un po' bevendo e un po' piangendo sui vari divani della casa. Alla fine mi
sono decisa e ho fatto il numero del collegio. Non aveva forse detto che avrebbe accettato qualsiasi cosa le
avessi detto?
«La madre superiora non c'è», ha risposto la centralinista.
«Quando la posso trovare? » ho chiesto alterando la voce per non farmi riconoscere.
«E' in ospedale già da due mesi. Sta molto male. »
Fine della comunicazione.
Nell'attesa che Franco tornasse ho cominciato a fare dei bagni caldissimi, a percuotermi il ventre con
violenza. C'era una specie di ragno
là dentro che stava crescendo. Giorno dopo giorno allungava le sue zampe pelose. Prima mi avrebbe
invaso la vescica e poi l'intestino. Da lì, sarebbe salito allo stomaco e avrebbe colonizzato il fegato. L'avrei
sentito arrivare fino in gola. Forse non era più un ragno ma un pipistrello, una creatura della notte. Come
tutti coloro che vivono nel buio, non aveva bisogno di occhi, sarebbe nato cieco, con i globi oculari
completamente vuoti. Per questo facevo di tutto
perché non venisse al mondo.
Domenica sera sono rientrati in città.
Mentre la signora svuotava le valigie, sono andata da Franco e gli ho detto: «Sono incinta».
E' rimasto un attimo immobile, guardandomi fisso negli occhi.
«Sei sicura?»
« Sì. »
«Non preoccuparti, è solo un incidente di percorso. Chi ha fatto il danno, lo ripara.»
Il giorno dopo la signora mi ha chiesto: «E allora? Promossa?».
«Sì», ho risposto, «con il 48.»
Quella sera ha insistito per festeggiare. Ha comprato una torta gelato e una bottiglia di spumante. Quando
abbiamo fatto il brindisi tutti insieme sono scoppiata a piangere.
«Perché piange? » ha chiesto Annalisa con la sua voce stupida. Franco guardava fuori dalla finestra. La
signora mi ha abbracciata.
«Rosa piange perché è troppo sensibile. »
La settimana seguente, Franco ha preso un appuntamento da un suo amico, in una clinica.
«Vedrai, è meno grave che togliersi un dente. »
Non riuscivo più a chiudere occhio. D'estate, la mansarda era una specie di forno. Anche con l'abbaino
spalancato, mi mancava il respiro. Facevo una doccia e subito dopo un'altra.
La pancia e il seno avevano cominciato a gonfiarsi. «Stai bene più in carne», aveva osservato la signora
Giulia.
Nel silenzio della notte, guardavo le stelle. In fondo il cielo era grande, ci sarebbe anche potuto essere
Qualcuno lassù. Sola, con quella cosa che mi cresceva dentro, mi era tornata voglia di pregare. Un giorno
avevo pensato, solo i deboli e gli stupidi hanno bisogno di Lui. Adesso mi rendevo conto di aver avuto
ragione. Ero stata stupida e ora ero debole, per questo chiedevo a gran voce che Qualcuno si affacciasse
alla soglia dell'universo. Visto che nessuno mi
aiuta, aiutami Tu!
Provavo vergogna per i miei pensieri, per la mia ipocrisia. Lo stavo trattando come fosse una compagnia di
assicurazioni. Dopo quello che avevo detto e fatto, con che parole mai avrei potuto rivolgermi a Lui?
Qualsiasi invocazione sarebbe precipitata giù dal cielo come una palla da tennis che rimbalza contro un
muro.
Forse aveva ragione don Firmato, ero proprio figlia di Satana. Forse la soluzione migliore sarebbe stata
davvero che la zia mi avesse

ammazzato con le sue stesse mani, quella sera.
Aveva sentito l'odore di zolfo e non si era sbagliata. Con chi mi aveva concepita mia madre?
E con chi avevo concepito mio figlio?
Guardavo il cielo e non riuscivo a piangere.
Guardavo il cielo e non riuscivo a pregare.
Non so perché, ma alla bocca mi è venuta una parola. Una parola che non avevo mai pronunciato. Perdono.
Una notte ho fatto un sogno. Nel mio ventre
non c'era più un ragno ma un piccolo punto di luce. Invece di stare fermo, vorticava su se stesso lanciando i
suoi raggi nell'oscurità. Non avevo mai visto una luce così chiara, così intensa e trasparente.
La mattina seguente mi sono svegliata con uno strano rumore nelle orecchie. Facendo la doccia ho
pensato, sarà la pressione bassa. Nel pomeriggio, quel rumore ancora lì. Non era il solito fischio, sembrava
piuttosto il rumore del
mare, quello che si sente in una conchiglia o ascoltando l'infrangersi delle onde su una spiaggia.
Mancavano solo due giorni all'appuntamento in clinica. Cosa dovevo fare di quel figlio che non avevo
desiderato? Come avrei potuto accettare qualcuno con la faccia di Aldo, qualcuno con la faccia di Franco?
L'avrei odiato, avrei
cercato di distruggerlo fin dal primo giorno. Al posto del latte, gli avrei dato da bere veleno.
Forse anche mia madre aveva provato gli stessi sentimenti nei miei confronti, aveva pensato di buttarmi nel
cesso e non l'aveva fatto.
Adesso ero io a rimpiangere il rifiuto di quel gesto. La mia vita era tutto uno sbaglio. Meglio, molto meglio
sarebbe stato non essere mai nata.
La mattina dell'intervento Franco mi ha dato i soldi per il taxi. Dovevano servire per il ritorno. La clinica era
quasi fuori città. Mi sono
mossa con molto anticipo per arrivare in tempo. L'autobus mi ha lasciato lì davanti un'ora prima del previsto.
Non avevo voglia di entrare, così ho passeggiato un po' per le strade intorno. C'era qualche villa di recente
costruzione, dei campi incolti, quattro o cinque capannoni e tra i capannoni, quasi schiacciata, una
chiesetta. Doveva essere stata costruita quando ancora la città era lontana. L'aria era già torrida. La porta
era socchiusa. Ho pensato al fresco, così l'ho spinta e sono entrata. Era piccola e neanche bella, il
pavimento era di piastrelle come quello di
uno studio dentistico.
Alle spalle dell'altare troneggiava un brutto crocefisso. Non sembrava un Cristo morto ma un Cristo nel
pieno dell'agonia. Stava tutto storto, scomposto, come se il dolore gli stesse ancora divorando le ossa. I fiori
nei due vasi sotto, invece, erano già morti. Pendevano afflosciati nell'acqua sporca.
Al lato destro dell'altare, c'era una statua della Vergine. Aveva una corona di lucette in testa come le
gondole e il lungo manto azzurro e bianco. Teneva le braccia aperte come aspettasse qualcuno da
accogliere. Era scalza, ma questo non le impediva di schiacciare con il piede nudo la testa di un serpente.
Davanti a lei, tremolavano due candele accese.
Stanno per spegnersi, ho pensato e in quel mentre da una vetrata rotta hanno fatto irruzione dei passeri.
Cinguettavano forte, inseguendosi nell'aria come se stessero giocando.
Hanno volato per un po' di qua e di là facendo un gran fracasso. Poi si sono posati sui due bracci della
croce.
Non erano compagni di gioco, ma una mamma con i suoi piccoli. I piccoli adesso pigolavano e sbattevano le
ali e la madre li nutriva, ficcando il becco nelle loro piccole gole spalancate. Loro chiedevano e lei dava. Li
nutriva anche se erano già grandi, anche se erano già in grado di volare da soli.
La Vergine, con il suo sorriso mite, mi stava
ancora guardando. Nel mezzo delle guance aveva due pomelli appena un po' più rossi.
Ho alzato lo sguardo verso di lei e le ho detto:
«Non dovresti essere Tu la madre di tutti noi?».
Poi ho allungato una mano per toccarle il piede che schiacciava il serpente. Pensavo fosse freddo, invece
era tiepido.
Mezz'ora dopo ero sul lettino della clinica. Il dottore amico di Franco stava spalmando il gel per l'ecografia. Il
rumore del mare non mi aveva ancora abbandonato. Tum sflusc, tunf sflusc, tum sflusc.
«Dottore», ho chiesto, «è possibile che io senta già il cuore di mio figlio? »
Il medico è scoppiato a ridere. «Che fantasia! » Mi ha indicato un punto sullo schermo.
«Quello che chiami tuo figlio, al momento non è molto diverso da uno sputo.» Poi ha aggiunto: «Rivestiti e
accomodati nella sala accanto.
Tra mezz'ora procediamo».
Mi sono rivestita e ho cominciato ad aspettare. A un certo punto, mentre stavo seduta, ho sentito l'odore di
mia madre. L'odore della sua pelle e dell'acqua di colonia. Quell'odore che non sentivo da anni. L'odore
della tempesta di baci. Mi sono guardata in giro. Nella sala non c'era nessuno, le finestre erano chiuse.
Allora ho capito e ho fatto l'unica cosa che potevo fare. Mi sono alzata e sono andata via.
Vicino al capolinea, c'era una cabina telefonica. Da lì ho chiamato Franco. Era allo studio.

«Come stai?» mi ha chiesto.
«Sto bene perché ho deciso di tenerlo.»
«Sei impazzita? »
«Forse. »
«Vuoi mettere al mondo un altro povero infelice? »
«Forse. »
E' seguito un lungo silenzio, poi ha detto:
«Da te non mi sarei mai aspettato un comportamento così sciocco. Comunque, tu sei libera
di rovinarti la vita. Bisogna vedere se me la voglio rovinare anch'io».
La pancia ancora non si vedeva, ma presto sarebbe successo. Cosa avrei fatto in quel momento?
Pensavo a questo, qualche giorno dopo, quando, entrando in cucina, me li sono trovati
di fronte tutti e due con delle facce immobili e livide.
«Cos'è successo?» ho chiesto con un filo di voce, pronta al peggio.
La voce di Giulia tremava.
«Come hai potuto farmi questo?»
Ho abbassato lo sguardo. Era così che lui si vendicava?
«E vero, avrei dovuto dirlo prima. »
«Dirmi cosa? Che sei una ladra? E io che ti ho trattata come una figlia! Da giorni cerco il mio anello con lo
smeraldo e poi dove lo trovo?
In fondo ad un tuo cassetto! Chissà quante altre cose hai fatto sparire in questi mesi! »
«Abbiamo fatto l'errore di fidarci», ha aggiunto Franco con uno sguardo opaco. «Ma quando la radice è
marcia, prima o poi marcisce anche la pianta. Ti abbiamo voluto comunque bene. Per questo non
chiameremo la polizia. Però ti devo chiedere di lasciare la casa entro domani mattina. E, ovviamente, di
restituirci tutto quello che non ti appartiene.»
L'ennesima notte in bianco. Invece di riposarmi ho passato il tempo a pensare al modo migliore per
vendicarmi. L'assenza di luce favorisce i pensieri più tremendi.
Avrei voluto prendere la sua bambina e soffocarla con un cuscino, spingerla in un canale, vedere i suoi
capelli dorati fluttuare sull'acqua come vecchi stracci. Avrei voluto prendere una tanica di benzina e vuotarla
sul parquet e i mobili di legno e poi lanciare qualche fiammifero e farlo morire come muoiono le
donne indiane, sulla pira del marito. Avrei voluto allentare i freni della sua auto e vederlo schiantarsi contro il
muro. Avrei voluto sputargli in faccia e poi ficcargli un coltello nel ventre. Avrei voluto aprirlo dalla testa al
ventre
come un tonno, tirando fuori le sue viscere calde con le mie mani. Avrei voluto fargli bere una pozione
mortale, un veleno lentissimo, che producesse un'agonia insopportabile.
Poi ho pensato che la morte in fondo era un dono, che sarebbe stato molto meglio farlo vivere
nell'umiliazione e nel tormento. Avrebbe potuto cadere dalle scale e rompersi la spina dorsale, restare per
sempre sU un letto, con il
respiratore a tappargli la bocca. Oppure avrebbe potuto crollare una casa che aveva costruito.
Il crollo avrebbe provocato un bel po' di morti e lui sarebbe andato in galera e avrebbe perso tutto. Quando
fosse uscito, la moglie non sarebbe stata più lì ad aspettarlo, la figlia, ormai adulta, avrebbe fatto finta di non
conoscerlo. E
così lui sarebbe finito in strada, girando per le mense dei barboni con dei sacchetti di plastica in mano.
Avrei potuto anche dire alla moglie che io non avevo rubato niente in casa sua. Odiavo sì, ma il mio odio
non aveva nessun legame con l'avidità. Avrei potuto raccontarle per filo e per segno tutto quello che c'era
sotto la storia del furto. Avrei potuto svelarle cosa faceva suo marito, quando stava a lavorare fino a tardi nel
suo studio. Avrei potuto dirle che quel figlio che mi cresceva dentro probabilmente sarebbe stato il fratello o
la sorella di Annalisa e dunque, in qualche modo, stavamo per diventare parenti.
Avrei potuto dirglielo, ma lei avrebbe potuto non credermi. Anzi, di sicuro non mi avreb be creduto, perché io
ero soltanto una senza famiglia, la figlia della prostituta che rubava e alzava il gomito, mentre l'uomo
accusato era suo marito. L'uomo che la manteneva nel benessere e con il quale aveva messo al mondo una
bambina che era la luce dei suoi occhi. Tacere era meno grave che non essere creduta.
Poco prima dell'alba ho preso la mia sacca sportiva dall'armadio e vi ho messo le poche cose con cui ero
arrivata.
Prima di uscire ho infilato un bigliettino nella borsetta della signora Giulia. C'era scritto "Un giorno capirà. Mi
perdoni" e poi, sotto, il
mio nome.
Erano i primi di agosto e la città era deserta. Un mezzo della nettezza urbana passava lentamente lungo la
strada e irrorava i marciapiedi con l'acqua. I balestrucci stridevano a decine tra i tetti delle case. Un gatto
con un collarino rosso ha attraversato la strada. Non sapevo dove andare, così ho raggiunto il parco lì
vicino. Era il luogo più fresco che conoscevo. C'era qualche anziano che portava a passeggio il cane,
qualche ragazzo che approfittava della temperatura mite per fare jogging.
Mi sono seduta su una panchina appartata.

Poco distante, su una fontanella di ghisa, si erano posati dei colombi. Allungavano a turno il collo verso lo
zampillo. Vedevo il gozzo riempirsi e l'acqua scendere giù nella gola.
Più in là, una vecchia con i piedi avvolti in due sacchetti di plastica stava esaminando il contenuto di un
cestino dei rifiuti. Annusava le cose e poi le buttava via. Aveva un volto sereno, quasi divertito. Forse un
giorno era stata una persona importante, aveva avuto dei figli e degli uomini si erano innamorati di lei.
Mi ero sempre chiesta che cos'è l'amore, ma mai che cos'è la vita. Veniamo al mondo e siamo l'inno stesso
della precarietà. Basta un virus appena un po' arrogante, un colpo leggero sulla nuca per farci scivolare
subito dall'altra
parte.
Siamo un inno alla precarietà e un invito al male, a compierlo vicendevolmente gli uni sugli altri. Un invito
che abbiamo accolto dal primo giorno in cui il mondo è stato creato. L'abbiamo accolto per obbedienza, per
passione, per
pigrizia, per distrazione. Ti uccido per vivere.
Ti uccido per possedere. Ti uccido per liberarmi di te. Ti uccido perché amo il potere. Ti uccido perché non
vali niente. Ti uccido perché voglio vendicarmi. Ti uccido perché uccidere mi dà piacere. Ti uccido perché mi
dai fastidio. Ti uccido perché mi ricordi che anch'io posso essere ucciso.
Ogni cosa nel mondo ha il suo opposto. Il nord e il sud. L'alto e il basso. Il freddo e il caldo. Il maschio e la
femmina. La luce e il buio.
Il bene e il male. Ma allora, se davvero è così, perché è possibile dire: "Ti uccido" e non è possibile dire: "Ti
restituisco la vita"? La vita è nata prima dell'uomo e nessun uomo è in grado, con la sua sola volontà, di
creare la vita. "Muori!" possiamo gridare, ma non "Vivi! ". Perché?
Cosa si nasconde in questo mistero?
Mentre pensavo queste cose, mi è venuto accanto un cane. Sembrava piuttosto anziano, aveva il pelo
biancastro a ciocche, il ventre gonfio della malnutrizione, lo sguardo coperto da un velo opaco. Con fatica mi
si è seduto vicino.
Aveva la bocca aperta e respirava rumorosamente.
«Non ho niente da mangiare» gli ho detto ma lui è rimasto lì lo stesso.
Il sole cominciava a picchiare così mi sono spostata sotto un grande ippocastano. La chioma faceva
un'ombra morbida, sotto le sue foglie ronzavano decine di insetti.
Il cane mi ha seguito. Non c'era una panchina e così mi sono seduta per terra. Lui mi si è disteso accanto. Il
suo respiro sembrava un
mantice.
«Vuoi una carezza?» gli ho chiesto, posandogli la mano sulla testa. Ha socchiuso gli occhi con
un'espressione che sembrava di felicità.
Il cielo sopra di noi era azzurro come il fondo di una tazza di smalto. Non c'erano più balestrucci ma soltanto
qualche colombo che volava pesante. Più in alto, il ventre argenteo di un aereo brillava come un'aringa. Poi
è scomparso, lasciando dietro di sé una striscia bianca, lunga e precisa come una strada di campagna.
Ci sono sentieri nel cielo?, mi sono chiesta allora. E dove portano? E chi li traccia?
In quel momento il cane mi ha dato la zampa.
«Ci guida Qualcuno o siamo soli?» gli ho domandato.
Aveva gli occhi socchiusi, la lingua penzoloni. Sembrava sorridesse.
«Rispondimi. »
L'inferno non esiste.
I.
Sono tornata alla casa dei miei genitori,
quella casa che per tanto tempo tu hai detestato. Ho fatto fatica ad aprire la porta, c'era ruggine nel cilindro
della serratura e il legno era
gonfio per le molte piogge.
Quando finalmente ha ceduto, ho avuto
l'impressione di trovarmi in un museo. O in una
cella mortuaria. Ogni cosa era al suo posto. L'aria era fredda e umida, di quella fredda umidità

che preserva le cose non più vive dall'insulto
del tempo. Sul tavolo, in cucina, c'era ancora la
tovaglia. Sopra, una brocca e un bicchiere. Nel
camino era rimasta della cenere. Sul bracciolo
della poltrona erano posati gli occhiali spessi di
mia madre, accanto a un gomitolo di lana infilzato da due ferri. Sul televisore troneggiava la
foto del nostro matrimonio. Uscivamo dalla
chiesa a braccetto, tu con il tight, io con un lungo abito bianco. In quel momento, qualcuno
doveva aver lanciato del riso, perché tu sorridevi e lo facevo anch'io. Ma sorridevo con gli occhi chiusi.
Era stata mia madre a scegliere quella foto.
Ce ne erano di molto più belle. Gliele avevo mostrate varie volte, ma lei si era intestardita.
«Voglio questa», diceva, puntandoci sopra il dito storto dall'artrosi. Io insistevo. «Non è meglio questa? O
quest'altra?» «No, no, voglio
questa. » «Ma perché proprio questa? » «Perché,
in questa, sei proprio tu. » Con la manica, ho
spolverato la foto. Dagli angoli della cornice, i
ragni avevano cominciato a tessere la loro tela.
Allora mi ero chiesta che cosa rendesse quella foto tanto diversa dalle altre. Me lo ero chiesto, e non avevo
saputo rispondere. Nel silenzio
innaturale della casa, adesso lo sapevo. Ero io,
per gli occhi chiusi. Pur non vedendo, scendevo
la scalinata lo stesso, affidandomi al tuo braccio. Non avevo dubbi sulla sicurezza della tua
guida.
«Vedi solo ciò che vuoi vedere», mi aveva
detto mio padre, poco prima di morire. Era il
crepuscolo e stava davanti alla stalla. Due mesi
dopo è morto. Una sera il cane è tornato solo.
All'alba del giorno dopo, l'hanno trovato riverso sul muschio. Qualche animale aveva già cominciato a
rosicchiargli le orecchie.
Erano i primi di settembre. Noi stavamo veleggiando verso la Costa Smeralda. «E' morto
tuo padre», mi hai detto, emergendo da sotto
coperta. «Il funerale sarà domani o dopo. Non
farai in tempo ad arrivare. »
Mia madre, invece, se ne è andata mentre
eravamo a Singapore, per un tuo impegno di lavoro. Al paese, nessuno sapeva dov'ero, così
nessuno è riuscito ad avvisarmi. L'ho saputo al
ritorno.
Quando sono stata al cimitero, sulla terra
smossa era già cresciuta l'erba. Era maggio e i
canaloni erano ancora pieni di neve. I ruscelli
saltavano tra una pietra e l'altra, gonfi di acqua. I rami dei larici erano già coperti di morbidi aghi verde
chiaro. Lo stesso verde luminoso dei prati. Quella volta, non ero riuscita a
provare grandi sentimenti. Forse ero ancora
anestetizzata dalla tua presenza. Più che vivere,
mi guardavo vivere.
Poi, per fortuna, sei morto anche tu.
La mattina in cui ti ho trovato disteso sul
pavimento del bagno, non è stato molto diverso
dal vedere un insetto.
Quando ancora eravamo fidanzati, mi avevi
fatto leggere La metamorfosi di Kafka. Era un
racconto che ti esaltava. «Qui dentro», ripetevi
sempre, «c'è tutta l'essenza dell'uomo moderno. » Per compiacerti, avevo finto che esaltasse
anche me. «Mi dà i brividi», ti avevo detto. Era
una menzogna solo parziale, perché i brividi li
provavo davvero. Ma erano brividi di disgusto.
Nel momento in cui ti ho visto per terra, nudo, con le gambe spalancate, quando ho visto la
mollezza sfatta degli anni trasformarsi in rigidità, mi è tornato in mente proprio lui, Gregor
Samsa. Non ti ho toccato, ma sono certa che, se
l'avessi fatto, sotto il mio piede avrei sentito,
non la carne, ma l'involucro chitinoso di uno
scarafaggio.

La settimana seguente è stata la più dura.
Ho dovuto indossare il volto affranto della vedova. Eri stato un uomo importante e tutti volevano
manifestarmi il loro cordoglio. Quando
non ne potevo più di quelle frasi di circostanza,
mi ritiravo in bagno e sai cosa facevo? Scoppiavo a ridere. Ridevo fino alle lacrime, ridevo
con l'allegra sguaiatezza dell'adolescenza. Ridevo come uno che ha vinto la lotteria e non
può comunicarlo a nessuno.
Nella cronaca cittadina, ti avevano dedicato
un articolo di due colonne. "Lascia la moglie e
una figlia", avevano scritto verso la fine. Dell'altro figlio, neppure un cenno. Quando uno muore,
ogni cosa rimasta alle spalle diventa buona. Non
è questo l'ultimo insulto per chi deve ancora andare avanti, trascinandosi il peso della memoria?
Passata la farsa, pensavo a una sola cosa, a
quanto sarebbe stata felice la mia vita da vedova. Mi avevi lasciato un buon conto in banca e
le curiosità e gli interessi della mia giovinezza
erano ancora intatti. Mi sarebbe piaciuto viaggiare e imparare le lingue, mi sarei iscritta a un
corso di acquerello, a un circolo letterario. Non
avrei più sopportato alcuna imposizione. Dovevo guadagnare tempo per essere certa di morire con il volto
sereno di chi non ha rimpianti.
Come ho potuto essere così ingenua? Il male
ha molte facce e si insinua ovunque con abilità
mimetica. Sembra che muoia ma rinasce sempre. Il tuo cuore aveva ceduto, ma il tuo spirito
era ancora vivo. Spirito di vendetta, spirito di
distruzione, spirito di odio per ogni cosa in grado di sfuggire al tuo regime di umiliazione.
A cinquantacinque anni non ci si può più illudere che la vita sia soltanto davanti, che si
possa godere di essa come se si fosse appena nati. C'è stato un prima, ed è quel prima a indicare la
direzione dei giorni a venire.
Prendendo in mano il lavoro a maglia di mia
madre, i suoi grossi occhiali da vecchia coperti di
polvere, ho capito una cosa. Gli eserciti in fuga
di solito distruggono i ponti. Tu, con la mia vita,
hai fatto lo stesso: con ossessiva meticolosità hai
distrutto tutto ciò che mi stava alle spalle. Poi,
per evitare che un giorno potessi rialzare la testa,
hai minato anche tutto ciò che stava davanti.
Questa casa abbandonata ed io siamo ormai
la stessa cosa. L'umidità ha mangiato le pareti.
Se piove, l'acqua filtra in più punti. I picchi
hanno ridotto gli scuri a colabrodi, mentre i topi hanno rosicchiato tutto ciò che era possibile
rosicchiare: i fili elettrici e le scorte di candele,
la Bibbia sul comodino e le copie di vecchie riviste conservate per accendere il fuoco, gli strofinacci e le
federe ordinatamente riposti nella
cassapanca dell'ingresso.
La prima sera mi è venuto lo sconforto. Giravo da una stanza all'altra con una candela in
mano e il cappotto indosso. Tutto era in tale
stato di degrado che mi pareva impossibile porvi rimedio in pochi giorni e con le mie sole forze. Per
affrontare le prime notti, mi ero portata
un sacco a pelo che era stato dei ragazzi. Sono
andata in camera di mio padre e mia madre,
ma non ho avuto il coraggio di sdraiarmi sul loro letto. La mamma l'avevano trovata lì, distesa a faccia in giù
sul pavimento, un braccio
avanti e uno dietro, come se stesse nuotando.
«E' morta subito? » avevo chiesto al medico
condotto della zona.
«Chi lo può dire? » mi aveva risposto alzando le spalle. «Potrei tranquillizzarla dicendo: sì
dopo tre minuti ha perso coscienza, ma che senso avrebbe? Il tempo dei moribondi è molto diverso dal
nostro. Quello che per noi è un attimo, per loro è l'eternità.»
Adesso che sono sola nella casa, è proprio
quell'eternità a farmi paura. Se non è morta subito, cosa avrà pensato negli ultimi istanti? Forse
avrà cercato di raggiungere il telefono, per questo
stava li, con il braccio teso in avanti. Forse ha
pensato di chiamarmi ma non ce l'ha fatta. O forse era convinta che sarebbe stato perfettamente

inutile.
Quando ero andata a trovarla l'ultima volta? Era rimasta vedova da poco, dunque due
anni prima. Quanto distava casa loro dalla no-
stra? Tre ore e mezzo di macchina, quattro, se
c'era traffico.
Finché i bambini erano piccoli li avevo portati lassù almeno un mese ogni estate e un paio
di settimane durante l'inverno. C'era ancora la
vecchia slitta costruita dal nonno, ci salivamo
tutti sopra per andare a fare la spesa. Frenando, la neve arrivava in faccia, trasformandoci
tutti in pupazzi.
Poi i bambini erano cresciuti, Laura ha cominciato a voler essere come tutti gli altri, le
vacanze sulla neve dai nonni non le bastavano
più. Voleva le scuole di sci e gli impianti di risalita, le discoteche per passare la serata. Michele no, Michele
è sempre stato diverso. Lui
adorava la casa in montagna. Già da piccolissimo, con la sua testa tonda e chiara, seguiva il
nonno dappertutto. Quando aveva cinque anni,
mio padre aveva intagliato una canna per farne
un piccolo flauto. All'improvviso, dai posti più
impensati, sentivo salire quelle note. Erano
noiosissime ma a Michele dovevano sembrare
meravigliose, non faceva altro che ripeterle. A
volte, lo scorgevo seduto su una balla di fieno o
sotto l'arco della scala, Teneva le sopracciglia
aggrottate come se stesse pensando a qualcosa
di molto serio.
A te non erano mai piaciuti i suoi occhi,
«Non sono azzurri», dicevi, «e neanche verdi. Sono occhi color confusione.»
Ti irritavano le ciglia e le sopracciglia, troppo scure, troppo marcate. «Sembrano dipinte»,
dicevi, indicandolo come fosse un animale in
vendita nella pubblica piazza.
Quando aveva sette, Otto anni gli ripetevi
spesso: «Mi sembri quella sciacquetta di Bambi».
Quando poi, nell'adolescenza, il suo corpo si
è allungato e ha perso la grazia, il tuo ritornello preferito era: «Così dipinto sembri proprio
una baldracca».
Poco prima di venire quassù, ho sentito dire
da un prete alla televisione che l'inferno non
esiste. Stavo facendo qualcos'altro e non vi avevo prestato molta attenzione ma, un paio di
giorni dopo, su un importante quotidiano, ho
letto la stessa affermazione.
L'inferno non esiste, diceva l'articolo, corroborato dalla tesi di un teologo molto in vista. O
se anche esiste è comunque vuoto. Ero sola a
casa e ho cominciato a camminare per le stanze sbattendo qua e là il giornale. «Vigliacchi!
Bugiardi!», gridavo. «E allora, Hitler dov'è? E
Stalin? Suonano la cetra nel più alto dei cieli?
Oppure spazzolano i boccoli dei cherubini? Se
l'inferno è vuoto, ci voglio andare almeno io.
Stare in pace laggiù tra il tepore delle fiamme,
tutta sola come in un grande albergo fuori stagione! »
Quando mi sono calmata ho pensato, ecco,
stanno raschiando il fondo del barile. Nessuno
li ascolta, nessuno più li segue. Per essere popolari hanno tolto l'ultimo limite. Agite pure
come vi pare, compite ogni nefandezza, tanto
poi il banchetto sarà democratico. Gioia, amore ed eternità per tutti. Seduti uno accanto all'altro, il medico
missionario e lo stupratore di
bambini. Che bella festa!
Se l'inferno non esiste, niente esiste. E non
solo esiste, ma anche deve essere completamente separato dagli spazi superiori. Ci devono essere
reticolati e fiamme e guglie di vetro spezzato e fili elettrici ad alta tensione e compartimenti stagni e assenza
di atmosfera e di pressione e il gorgo di un buco nero che inghiotte
tutti coloro che provano a uscirne. Mia madre e
mio padre non potranno mai stare accanto a te,

non dovranno neppure immaginare che esisti
ancora in qualche luogo dell'universo. Per questo è necessario che, tra il sotto e il sopra, ci siano tutte quelle
barriere.
La prima notte, ho dormito nel mio letto da
ragazza, nella piccola stanza ricavata sotto il
tetto. Più che dormire, ho atteso l'alba in posizione sdraiata. Non ho perso coscienza neppure
per un istante. La casa era piena di vita. Alcuni rumori li riconoscevo, i passi dei topi sul pavimento, quelli
delle donnole e delle faine che,
per cercare i nidi, ribaltavano i coppi del tetto,
il legno dei mobili che si gonfiava e sgonfiava,
producendo piccoli schiocchi, scricchiolii di assestamento. A un certo punto della notte, ha cominciato a
soffiare il vento. Era vento di tramontana perché colpiva il lato nord della casa.
Da fuori, giungeva il tintinnio di qualche anel
lo di metallo, come di sartie contro l'albero di
una barca a vela. Ho sentito spalancarsi di colpo la finestra della cucina. Non sono scesa, ma
ho visto ugualmente la raffica entrare dentro e
travolgere le cose. Il gomitolo è rotolato dalla
sedia e, per la stanza, hanno cominciato a volare i fogli di giornale raccolti per il fuoco. Volava la tendina
sotto l'acquaio e traballava la
gondola souvenir sulla mensola accanto all'orologio. Ogni cosa, all'improvviso, aveva una sua
vita. La foto della nonna sulla credenza e la sua
voce che diceva: «Chi muore solo, resta quaggiù
a cercare compagnia. Va avanti e indietro tutto
il tempo come un animale in gabbia».
Quando la raffica si è esaurita, mi è parso di
udire dei passi. Che passi erano? Sembravano
pantofole ai piedi di una persona anziana.
II.
L'albergo dove ci siamo incontrati non esiste
più. I vecchi proprietari sono morti, avevano
soltanto un nipote in Australia che non si è mai
curato di rilevarlo. C'è ancora l'insegna, o meglio soltanto una parte di essa. Al .. . chio .. .rpone è rimasto
scritto sull'angolo della strada
principale. Al vecchio scarpone.
Eri venuto li ad accompagnare una tua sorella, reduce da una malattia ai polmoni. Eravate rimasti tutta
l'estate e tu ti annoiavi a morte. Ogni
tanto, con la corriera delle undici, arrivavano dei
pacchi per te. Contenevano libri. Quando pioveva, passavi il tempo in camera a leggere. Quando
il tempo era bello, facevi la stessa cosa fuori, seduto su una panchina o disteso su un prato.
Non avevo potuto fare a meno di notarti.
Frequentavo l'ultimo anno delle magistrali.
Durante l'estate, per guadagnare qualche spicciolo, davo una mano all'albergo. Mi sembravi
diverso da tutti i ragazzi che conoscevo. Alla sagra di Ferragosto, avevo ballato con un caporale degli alpini,
ma dentro di me non era succes
so niente. L'unico maschio della nostra classe
era lo zimbello di noi ragazze. Quando, invece,
incontravo il tuo sguardo, diventavo rossa senza una ragione.
Ero convinta che non ti saresti mai accorto
della mia esistenza. Poi, una sera, mentre passavo davanti al dondolo cigolante, mi hai invitata a sedermi.
Mi hai parlato a lungo e di tante cose, come una persona che si sente molto sola. Non ero riuscita a seguirti
in tutto. Più che
conversazioni, le tue erano elucubrazioni filosofiche, la mia preparazione da aspirante maestra
non mi permetteva di starti dietro.
Al primo incontro, ti ero stata grata per l'attenzione. Al terzo, la gratitudine si è trasformata in orgoglio. Mi
day sempre del "lei", come se
fossi una persona importante.
Dopo una settimana, scostandomi i capelli

dalla spalla, hai mormorato: «Occhi azzurri e Capelli neri, labbra rosa e pelle bianca come neve
appena caduta. Nessuno le ha mai detto che è
molto bella?».
No, nessuno me l'aveva detto.
Come nessuno mi aveva detto la frase che
avevi usato come commiato, davanti alla corriera pronta a partire.
«Starà tutta la vita quassù a insegnare a
quattro bambini con il gozzo?»
Invece di rispondere, ho balbettato qualcosa
di confuso.
«Non ha mai pensato che potrebbe avere
molto di più dalla vita?»
«Di più, cosa?»
Eri arrampicato sull'ultimo gradino, le porte a soffietto stavano per chiudersi.
«Tutto! Se lei volesse, potrebbe avere tutto! »
L'estate dopo, sei tornato per un paio di
settimane e senza tua sorella. Abbiamo passeggiato a lungo mano nella mano. Cercavamo
sempre dei posti solitari e romantici, lontani
dagli sguardi indiscreti. Ci sedevamo sotto il
grande salice vicino al torrente o in fondo al
bosco di larici, nella radura. Lì, invece di tentare di baciarmi come facevano gli altri,
estraevi dalla tasca un libro e mi leggevi qualche poesia.
Al tuo fianco, avevo imparato a sentirmi
diversa. Avevo imparato a capire di più, a ragionare più profondamente. Ti ero grata per
avermi concesso l'arditezza della tua intelligenza.
Quell'arditezza, alla fine, aveva reso inquieta anche me. Non mi bastava più la vita che
avevo sempre fatto. Quella che mi si apriva davanti, nella valle, mi sembrava ormai una variante
dell'ergastolo.
Nel settembre di quell'anno ci siamo fidanzati e nel settembre dell'anno dopo, ci siamo
sposati.
A mio padre non piacevi. Mia madre, inve
ce, si sforzava di difenderti. «Che cosa ti ha fatto di male, povero ragazzo? Non ti è simpatico
soltanto perché viene dalla città! » Allora il
papà ingobbiva le spalle. «Non è questo», diceva, continuando a intagliare nervosamente un
pezzetto di legno. «E allora? » incalzava lei.
«Non so», borbottava, «non mi va», e diventava ancora più piccolo.
Il giorno del nostro matrimonio avevo già
imparato a vergognarmi di loro. Il rinfresco era
stato servito nel parco della villa dei tuoi genitori. C'erano dei grandi padiglioni a proteggere
le tavole imbandite. C'erano dappertutto camerieri che giravano con i vassoi e i guanti bianchi. Là in mezzo,
mio padre e mia madre vagavano smarriti, sembravano comparse che hanno sbagliato film.
Al taglio della torta, mio padre aveva alzato
la mano come a chiedere un po' di silenzio. Invece di fare un discorso, ha tirato fuori dalla tasca della giacca
la sua vecchia armonica a bocca e ha cominciato a suonare una canzone tristissima. In quel momento, ho
sentito il mio odio
nei suoi confronti diventare una vera e propria
forza fisica. «Papà, basta! » gli ho sibilato dopo
un paio di minuti di quello strazio. Ma lui non
mi ha ascoltata, ha continuato per un tempo che
mi era sembrato infinito.
In sala qualcuno sospirava, qualcun altro
tratteneva a stento una risata. Quella risata che
poi è esplosa fragorosa quando sono arrivati i
cani da caccia di tuo padre e, ululando, hanno
cominciato a fargli l'accompagnamento.
Viaggio di nozze a Vienna, cena con un violinista zigano che suonava solo per noi e poi, la
camera da letto. Durante il fidanzamento, ci
eravamo dati solo un bacio, sfiorandoci appena
le labbra. La tua delicatezza mi aveva commosso.
Hai chiuso la porta della stanza e mi hai afferrata per i polsi. Le tue pupille erano immobili, sembravano un
pozzo profondo che da anni non viene scoperto.
«Sai cos'è il matrimonio?» mi hai chiesto,

rinforzando la stretta.
"Volersi bene", volevo dire, invece ho mormorato: «Lascia, mi fai male».
«Il matrimonio è un contratto. Adesso, e per
sempre, sarai una cosa mia.»
Chi era l'uomo che avevo sposato?
III.
Ho aperto le finestre per far uscire l'umidità.
Nel ripostiglio dietro la stalla c'era tanta legna
tagliata. La gerla era ancora solida, l'ho riempita e ho fatto un paio di viaggi.
Al paese sono rimasti soltanto i vecchi.
Qualcuno mi ha salutata, qualcun altro ha fatto finta di non vedermi.
La chiesa è abbandonata da anni. Soltanto a
Ferragosto viene un prete dalla valle, la apre,
celebra la funzione dell'Assunta e poi riparte
con la sua utilitaria prima che l'umidità gli penetri nelle ossa.
Il cimitero comincia a essere invaso dalle erbacce, i genitori muoiono e i figli sono in città o
addirittura all'estero. Una gita a novembre è
sufficiente per la coscienza, ma non per limitare il vigore della vegetazione.
Luigi era stato mio compagno di banco nella pluriclasse delle elementari. Quando eravamo già sposati da
anni, l'avevo incontrato in
città, dietro lo sportello di un ufficio postale
non lontano da casa. Era il mese di maggio. Per
raccontarci un po' di cose eravamo andati a
prendere un caffè insieme.
Passando in automobile, ci hai visti seduti
uno accanto all'altra.
Nelle notti seguenti non mi hai lasciato dormire. «Chi era? A me non hai mai sorriso a quel
modo», continuavi a gridare, scaraventando a
terra ogni cosa che ti capitava per le mani. Poi
ti chiudevi a chiave in salotto e ti assordavi con
la tua musica di Mahler.
Aspettavo già Michele ma tu ancora non lo
sapevi.
Negli anni avevo imparato a conoscerti. Ero
diventata abile come un meteorologo che sa
prevedere i tifoni. Riuscivo a prevedere quasi
sempre quando si sarebbero scatenati e in che
forma. Di solito, prendevo ogni precauzione per
evitare l'impatto più violento.
Ma anche gli scienziati più esperti alle volte
sbagliano. Credevo che tu ti fossi calmato
quando ti ho detto: «Aspetto un altro figlio». Tu
mi hai guardato per un tempo interminabile.
Poi hai sibilato: «Ah, sì? E di chi è? » e mi hai
tirato un pugno dritto nel ventre.
Naturalmente nessuno sospettava quale fosse la realtà del nostro matrimonio. In pubblico,
nelle occasioni sociali, eri un marito ineccepibile, galante, generoso, innamorato della bellezza
della moglie. Davanti agli altri mi guardavi con
occhi stellanti, dicendo: «Non è un gioiello?».
Quando eravamo soli a casa e avevi bisogno
di qualcosa, mi chiamavi "Biancaneve". Da
quando hai saputo che aspettavo Michele,
Biancaneve è diventato Biancatroia.
Il giorno delle doglie, tu eri in Estremo
Oriente per un viaggio d'affari. Sono andata all'ospedale da sola, in taxi, lasciando Laura con
la baby sitter. Il travaglio è stato lunghissimo.
Quando ho visto accorrere il primario, ho capito che non tutto andava per il verso giusto.

«Che cosa fa? » domandava, tastandomi il
ventre, «che cosa sta facendo?» C'era allarme
nella sua voce. «Si è voltato», ha risposto un assistente. «Si dev'essere avvolto il cordone intorno al collo.»
All'ultimo minuto, Michele aveva deciso di
non nascere. Invece della testa, alla vita ha offerto i piedi. Con ciò che ci legava, ha tentato di
strozzarsi. L'hanno tirato fuori in extremis.
Quando l'hanno posato sul tavolo era violaceo, morbido e abbandonato come un vecchio
straccio. «Non ce la fa» ha detto un'infermiera.
Mentre il dottore stava cercando il battito del
cuore, Michele ha emesso una specie di sospiro e
il suo piccolo torace ha cominciato a muoversi.
E' difficile immaginare cosa voglia dire per
una donna avere un figlio perché ogni figlio è
qualcosa di assolutamente diverso. Per alcune
può essere gioia, per altre soltanto disperazione.
A quel punto della mia vita ero certa che se
Michele fosse nato morto, sarei morta anch'io
poco dopo. Quanto, nei matrimoni felici, i figli
sono il prolungamento naturale del rapporto,
tanto, nelle unioni minate dalle avversità, diventano una sorta di gomena a cui aggrapparsi
con tutte le forze, una piccola cosa indifesa di
cui aver cura e che, in cambio di questa cura,
restituisce giorno dopo giorno tutto l'amore che
ci è stato tolto.
Avevo già Laura, è vero, ma Laura era una
femmina e crescendo aveva dimostrato di assomigliarti sempre più. Caparbia nel profondo,
morbosamente gentile quando voleva ottenere
qualcosa, soggetta a improvvisi scoppi d'ira,
Laura era la tua cocca. Ancor prima che nascesse, sapevo che Michele non avrebbe mai
avuto un trattamento del genere.
E' rimasto in incubatrice quasi un mese.
Quando finalmente me l'hanno portato, ho
avuto l'impressione di prendere in braccio un
animale di pezza. Stava lì, ruotando i suoi occhietti acquosi verso il soffitto, senza alcuna
tensione nel corpo, senza alcuna volontà di movimento. Prendeva il latte fermandosi spesso,
con distrazione, quasi fosse preda di un'antica
stanchezza.
Dopo otto giorni, sei arrivato tu. Prima di te,
ha fatto l'ingresso nella stanza un grande mazzo di rose rosse. Quando siamo rimasti soli, hai
accostato la sedia al letto e mi hai preso una
mano tra le tue. «Mi dispiace», hai detto, «il
bambino non sarà mai normale.» I medici avevano svelato a te ciò che a me avevano tenuto
nascosto. «Il cervello», hai aggiunto, «è rimasto
troppo a lungo senza ossigeno. »
«E allora?» ho gridato.
Tu hai sollevato le spalle. «Allora niente. Ne
faremo un altro. »
Quel giorno ho capito che dentro ogni madre
vive una piccola tigre. Quando aveva tre mesi,
ho portato Michele a Milano da un famoso neurologo. Ha esaminato a lungo il bambino, lo
toccava con circospezione girandolo da una
parte e dall'altra, come fosse un fungo del cui
veleno ancora non si conosce la potenza.
Poi ci siamo seduti uno di fronte all'altro. Si
è tolto gli occhiali e mi ha detto: «A me non piace illudere la gente. Di sicuro sarebbe più facile ma sarebbe
anche più ingiusto. Così le dirò la
verità. Il bambino non sarà mai in grado di fare niente. Quasi di sicuro non sente e la sua vista è ridotta al
minimo».
«Mi può dire qualcosa di più? »
«Una pianta. Se la si nutre, cresce, si allunga verso la luce, respira e sintetizza la clorofilla, ma non le si può
chiedere di parlare o di fare un salto.»
Per la prima volta, ero riuscita ad oppormi

alla tua volontà. Tu volevi chiuderlo in una specie di Cottolengo, andando solo a Natale a fargli qualche
carezza sulla testa. Io volevo tenerlo accanto a me come fanno i canguri, i koala,
le mamme degli opossum. Gli parlavo tutto il
tempo, lo accarezzavo, annusavo la sua pelle
tiepida da cucciolo. Intanto tu ed io litigavamo
selvaggiamente.
Il giorno in cui l'hai chiamato "il piccolo bastardo" ho messo poche cose in una borsa e sono
tornata da mia madre. Loro non sapevano niente e lo trattavano come un bambino normale.
E' stato qui che ha sorriso la prima volta, la
nonna gli ha cantato una filastrocca e lui è
scoppiato a ridere.
La settimana dopo sei venuto a prendermi.
In una mano avevi un mazzo di fiori, nell'altra
la busta di una gioielleria. Hai pianto davanti a
mia madre come un uomo distrutto. «Alle volte
sono un po' nervoso», le hai detto, «ma non mi
merito tanto. E poi Laura non dorme più, ha gli
incubi, non fa altro che chiedere della mamma. »
Quella sera, rimaste sole, mia madre mi ha
parlato. «Nel matrimonio ogni tanto ci sono degli enormi scalini di pietra, li guardi e pensi che
non ce la farai mai a superarli. Tuttavia per te,
per i bambini e per l'impegno che hai preso, devi trovare la forza per farlo. E poi, quando sarai vecchia come
me, ti guarderai indietro e non
vedrai più gradini ma soltanto prati pieni di
fiori. »
Il giorno dopo siamo ripartiti insieme, Michele sul seggiolino dietro e noi due davanti: salutavamo i miei
sorridendo e con la mano aperta. Ero ancora giovane, volevo che mia madre
avesse ragione.
IV.
Una volta, da qualche parte, ho letto una
storia. Parlava di una scimmia e di uno scorpione. Arrivata sulla sponda di un grande fiume, la scimmia
decide di attraversarlo a nuoto.
Ha appena messo una zampa in acqua, quando
sente una vocina che la chiama. Si guarda intorno e, poco distante, vede uno scorpione.
«Senti», le dice lo scorpione, «saresti così gentile da darmi un passaggio? » La scimmia lo fissa
dritto negli occhi. «Non ci penso neppure. Con
quel pungiglione, potresti attaccarmi mentre
nuoto e farmi annegare. » «Perché mai dovrei
farlo?», risponde lo scorpione. «Se annegassi
tu, morirei anch'io. Che senso avrebbe? » La
scimmia ci pensa un po', poi gli dice: «Mi puoi
giurare che non lo farai?». «Te lo giuro! » Allora lo scorpione sale sulla testa della scimmia e
la scimmia comincia a nuotare verso l'altra
sponda. Quando è pressappoco a metà, sente
all'improvviso una fitta nel collo. Lo scorpione
l'ha colpita. «Perché l'hai fatto?» grida la scim-
mia. «Adesso moriremo tutti e due!» «Scusa»,
risponde lo scorpione, «non ho potuto farne a
meno. E' nella mia natura.»
Qual'era la tua natura?
Per tanti anni ho cercato di capirlo. Ho pensato dapprima a una sorta di trauma, uno stato di sofferenza
psichica latente che ti spingeva
a comportarti in quel modo. Ero convinta che,
con il tempo e la dedizione, sarei riuscita a lenirlo e un giorno saremmo stati anche noi una
famiglia banalmente normale come quelle della
pubblicità.
Poi, con gli anni le forze hanno cominciato a

indebolirsi, le poche rimaste le ho usate per difendermi, non ho più cercato di capire. Sapevo
ormai che ogni frase, ogni gesto era un campo
minato. Un aggettivo di troppo, un avverbio
fuori posto e sarebbe scoppiata la tempesta.
Camminavo cauta, mi muovevo con la studiata
lentezza di chi sa di aver un malato grave in casa e non vuole fare rumore. Anche i bambini
avevano imparato a muoversi allo stesso modo.
Sembravano due lemuri che, prima di lanciarsi
nel vuoto, tastano la solidità del ramo.
Per settimane, dopo la tua morte, ho avuto
l'impressione di non essere sola a casa. Se stavo
seduta sul divano o attraversavo una stanza, all'improvviso sentivo una corrente gelida che mi
assaliva. Pur essendo in piena estate, dovevo
mettermi una maglia di lana.
Una sera poi, poco prima di addormentarmi, ho avuto la certezza di vedere un'ombra attraversare lo spazio
che dalla stanza da bagno
porta alletto, come per tanti anni avevi fatto
tu. Il giorno dopo mi sono trasferita a dormire
da un'amica.
«Neppure all'inferno lo vogliono», le ho detto, con un whisky in mano.
Non avevo più bisogno di difendermi. Tu
non c'eri più.
Lentamente in me è tornato il desiderio di
comprendere. Davanti ai miei occhi scorrevano
quarant'anni della tua vita, quarant'anni di cui
conoscevo, o credevo di conoscere, ogni piega,
ogni respiro. In tutti quegli anni eri sempre riuscito a stupirmi per la tua abilità di mistificare,
la tua costante capacità di essere spietato, subdolo, di non provare alcun sentimento che non
fosse il piacere di umiliare, il gusto di distruggere l'intimità più profonda delle persone. Più
che a un essere umano, somigliavi a una divinità distruttrice, a Shiva o a una medusa dai
tentacoli prepotenti. Spargevi veleno intorno, e
inchiostro. Veleno, per uccidere. Inchiostro, per
far perdere le tracce, per godere in segreto della disperazione che avevi seminato dietro di te.
Eri un uomo di successo. Mandavi avanti la
ditta ereditata da tuo padre come pochi altri
avrebbero saputo fare. I tuoi dipendenti ti stimavano, per i collaboratori più stretti eri un
mito. A volte dovevo persino difendermi dall'invidia delle altre mogli; avrebbero fatto
qualsiasi cosa per avere un marito come te.
Non hai mai tradito l'apparenza. A pranzo firmavi un importante contratto con i tuoi partner americani, all'ora
di cena, se non correvo
ad aprirti la porta, gridavi: «Dov'è finita la
vacca alpina?».
Per il mio compleanno, l'ultimo che abbiamo festeggiato insieme, mi hai regalato un
ciondolo con una grossa perla nera.
«Ormai siamo quasi vecchi», hai detto. Poi,
sollevando il calice hai voluto fare un brindisi.
«Alla tua morte, che spero più atroce della
mia.»
Ancora non lo sapevo, ma il tuo pungiglione
aveva già colpito, inoculando nel mio corpo il
veleno di cui volevi liberarti.
A quattro, cinque anni, Michele era un bambino come tutti gli altri. Nei test dello sviluppo
non risultava neppure un giorno in ritardo sui
tempi. Gli unici segni rimasti della sofferenza
neonatale erano la gracilità del fisico e una certa attitudine alla quiete e al silenzio. Forse, dietro il drastico
responso dei medici c'era stato un
tuo suggerimento.
Tanto tu sottilmente lo detestavi, altrettanto
lui, a quell'età, ti adorava. L'amore che non si
riceve è quello che si desidera maggiormente.
La sera, all'ora in cui di solito tu rientravi, si
metteva ad aspettarti in piedi, vicino alla porta.
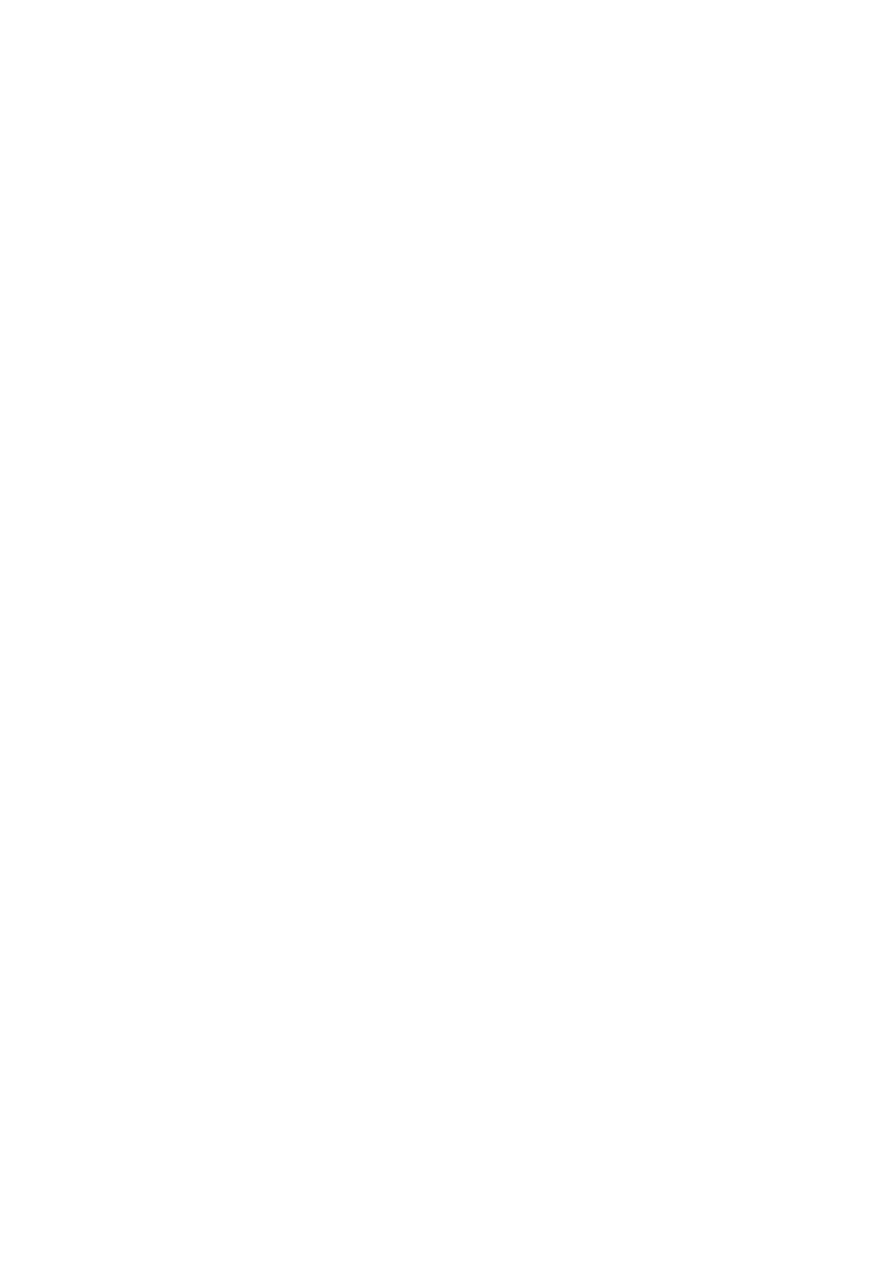
Che tu arrivassi dopo dieci minuti o dopo un'ora, non gli importava, lui non lasciava comun
que il posto. Le volte in cui tu restavi fuori a cena, dovevo usare tutta la mia diplomazia per
riuscire a distrarlo dalla sua inutile attesa.
Un giorno aveva voluto a tutti i costi che gli
comprassi una piccola cravatta. Non si usavano
più da tempo cravatte per bambini e avevo faticato a trovarla. Alla fine, era saltata fuori dal
cassetto di una vecchia merceria. Era blu, con
delle righe trasversali rosse. Un piccolo elastico
bianco serviva a tenerla legata al collo. Gli occhi di Michele brillavano per la felicità. A casa,
vestito come un piccolo uomo, stava immobile
davanti allo specchio, si guardava e mi chiedeva: «Quanti bottoni tiene chiusi papà nella
giacca, uno solo oppure tre?».
Voleva essere in tutto e per tutto uguale all'oggetto del suo amore. Fino ad allora ero riuscita a proteggere la
sua fragilità, facevo il possibile per non irritarti, per non provocare i tuoi
scoppi di ira. Se proprio succedeva qualcosa,
chiudevo le porte, accendevo la radio a tutto
volume. Mi illudevo di riuscire a conservare il
suo amore nei tuoi riguardi, speravo che quella
devota dedizione, con il tempo, ti avrebbe spinto a provare nei suoi confronti un sentimento
diverso.
Ma tu non ti accorgevi di lui, della sua tensione. O se te ne accorgevi, lo facevi con un senso di fastidio. Per
te la verità era rimasta quella del neurologo. Michele era un ritardato, un
non adatto a vivere. E, prima ancora di questo,
nel tuo morboso immaginario, era anche una
creatura che non portava in sé traccia del tuo
patrimonio genetico.
I pilastri del tuo mondo educativo erano
molto diversi dai miei, io a scuola avevo studiato con il metodo Montessori, mentre i tuoi libri
di formazione erano Hobbes e Darwin.
«La vita è una grande forza», ripetevi spesso, «e questa forza si manifesta in due modi, nel
sesso e nella lotta.» Senza sopraffazione, senza
diffusione dei patrimoni genetici, sostenevi, la
vita si sarebbe estinta poco dopo la sua comparsa. Il fatto che gli individui nascessero con
una diversa capacità di imporsi era la conferma
del principio. C'era chi veniva al mondo per
dominare e chi per essere dominato. Per rendersene conto, bastava guardare le scimmie: in
ogni branco c'era un maschio che veniva riconosciuto da tutti come il più forte, il capobranco, e possedeva
tutte le femmine. Gli altri maschi, per suggellare la loro palese sottomissione,
oltre a non sfiorare le femmine, quando gli passavano accanto, gli offrivano il sedere.
E noi, ripetevi spesso quando eri in vena di
pacata filosofia, cosa abbiamo di diverso da loro? Sappiamo parlare, sappiamo usare gli oggetti e le
macchine e questo è tutto. Nel profondo, nei nostri desideri, nei nostri sentimenti,
siamo identici a loro. O fotti o sei fottuto.
Che follia chiederti di capire la delicata sensibilità di Michele! Per te era soltanto una scimmietta incapace di
lanciarsi dalle liane. Non
avendo potuto scaraventarlo tu giù dall'albero
- nel branco si faceva così con gli imperfetti aspettavi semplicemente che, in qualche tentativo di volo,
mancasse la presa. Mentre la madre strillava disperata, tu, con le braccia conserte, l'avresti guardato
cadere.
La cecità di Michele nei tuoi confronti si è infranta al tempo della prima elementare. Per San
Giuseppe, la maestra aveva invitato i bambini a
fare un disegno da regalare ai loro papà e aveva
chiesto di commentarlo con una bella frase. Michele era agitatissimo all'idea di consegnartelo.
Appena ti sei seduto a tavola, ti è venuto vicino e
te l'ha offerto con tutte e due le mani, gli occhi luminosi dalla gioia. Sul foglio c'erano delle macchie irregolari
color pastello che sfumavano armonicamente una nell'altra. Sotto il disegno, a
matita e in stampatello, c'era scritto: "W IL PAPA".
«Oh, grazie! » hai detto afferrandolo. Poi
l'hai girato e rigirato più volte per osservarlo da
tutti i punti di vista.
«E che cos'è? Una casetta, un paesaggio? Non
si capisce niente. Sembra solo un gran pasticcio.»

L'hai appoggiato sul tavolo e hai cominciato
a mangiare con il solito appetito. Michele si è
seduto al suo posto, gli spaghetti stavano davanti a lui e due piccole lacrime gli scendevano
lungo le guance. Quando hai finito il tuo piatto, ti sei accorto che il suo era pieno.
«Mangia! » gli hai gridato. «Non vedi che sei
già una mezzasega? »
Lui, con lo sguardo basso, ha scosso la testa.
Hai ripetuto "mangia" tre o quattro volte.
Alla quinta, ti sei alzato bruscamente, il tuo
bicchiere si è ribaltato e il vino rosso ha coperto gran parte del disegno. Con una mano hai
preso la forchetta, con l'altra gli hai stretto il
collo. Cercando l'aria, il bambino ha spalancato la bocca e tu ne hai approfittato per infilargli gli spaghetti in
gola.
Da quel giorno non ti ha più aspettato dietro la porta. Invece di chiedermi quando tornavi, appena sentiva i
tuoi passi correva a nascondersi. Più lo vedevi debole, più lo vedevi
pauroso, più cresceva in te il livore. «Un ectoplasma», gridavi. «Mi devo tenere in casa un
ectoplasma.» Quando lo incontravi in giro per
la casa, gli dicevi: «Non ti vergogni? Cammini
proprio come una femmina».
Una volta Laura ha cercato di difenderlo.
«Cosa c'è di male a camminare come una femmina? »
«Non ti permetto di intrometterti», le hai
gridato, sbattendo un pugno contro la porta.
Povera Laura! Non aveva un mondo interiore grande come quello di Michele, ma aveva
lo stesso tipo di insicurezza. Si sentiva sospesa
tra una madre incapace di difenderla e un padre che urlava quasi sempre.
Man mano che cresceva, il tuo atteggiamento
si modificava. Prima era soltanto uno stupido
cucciolo, Poi ha cominciato a trasformarsi in un
oggetto di un certo interesse. A undici, a dodici
anni, la lodavi spesso. Non per i suoi voti o per il
suo carattere, ma per le sue gambe o per la forma dei glutei sempre più morbida. Nei primi
tempi, alle tue osservazioni arrossiva violentemente. Si copriva con dei maglioni fuori misura
come un sopravvissuto a una catastrofe. Appena
la guardavi con insistenza, si allontanava dalla
stanza. Poi, però, una parte di lei doveva aver
capito. Si trattava di vivere con l'amore - non
importa di che tipo fosse - o senza, di stare dalla parte del più debole o da quella del più forte.
Così a tredici, quattordici anni, Laura ha
scelto. Ha scelto di essere diversa da me e da
suo fratello e di piacerti. Ha scelto di truccarsi
e di indossare le minigonne, quando ancora il
suo volto e il suo corpo portavano le tracce
acerbe dell'infanzia. Ti parlava come parlano le
donne e tu la trattavi come una donna. La sera, dopo cena, vi sedevate insieme in salotto, tu
sulla poltrona e lei sulle tue ginocchia. Parlavate fitto fitto. Ogni tanto sentivo le vostre risate.
Quando tu volevi fumare, ti accendeva una sigaretta. Quando volevi bere, ti accostava alle
labbra il bicchiere del whisky.
Spesso mi è capitato di vedere, nei talk
show, delle donne piangere sui loro matrimoni
infelici e delle ragazze più giovani commentare
con acidità la loro debolezza. «La colpa è sua»,
dicevano, «perché non lo lascia perdere? » Nei
momenti di maggiore crisi, anch'io mi sono detta, basta, me ne vado, metto in salvo la mia vita! Poi, passata
la rabbia, passata l'umiliazione, mi guardavo intorno e dicevo, dove vado?
Non avevo un mestiere in mano, né una rendita, né una casa di proprietà in cui trasferirmi. I
miei genitori erano soltanto dei poveri contadini di montagna e avevo due figli ancora da crescere. La legge
avrebbe dovuto proteggermi ma
sapevo che la legge, nella maggior parte dei casi, è soltanto un'apparenza. Parla del più debole e protegge
il più forte, il più astuto, chi ha i
soldi per pagare un avvocato migliore.
Per compiere un gesto del genere, ci sarebbe

voluto un coraggio di molto superiore al mio.
Quei quindici, sedici anni di matrimonio erano
riusciti a spezzarmi dentro, a lasciarmi una forza
di reazione pressoché nulla. E poi avevo paura.
Sapevo che non avresti mai tollerato la sconfitta
di un abbandono, che saresti stato capace di qualsiasi gesto pur di tornare nuovamente vittorioso.
Così ho assistito, quasi impotente, alla rovina
di mia figlia. Solo una volta le ho detto: «Laura,
vorrei parlarti...». Lei si è girata dall'altra parte,
di scatto. «Non ho niente da dirti», mi ha risposto e si è allontanata dalla stanza prima che potessi
aggiungere altro. Ormai aveva scelto il tuo
mondo e non poteva tradirti. Viveva la fedeltà
della figlia prediletta.
Anche Michele cresceva, e cresceva sempre
più solitario, sempre più pensieroso. Andava
bene a scuola ma non aveva un amico, passava
pomeriggi interi senza uscire dalla stanza.
Amava leggere, amava disegnare. Sopportava i
tuoi soprusi quasi come fossero una cosa naturale, senza mai ribellarsi, senza mai alzare la
testa.
Spesso le madri amano illudersi, e così nutrivo qualche forma di speranza nei suoi confronti. E' così assorto
nei suoi pensieri, mi dicevo, da non accorgersi di come lo tratta il padre.
Neppure con me si apriva molto, ma era sempre gentile e affettuoso. Ogni tanto, quando
eravamo soli in casa, mi sedevo sul suo letto e
gli chiedevo: «A cosa stavi pensando?».
Invariabilmente mi rispondeva: «A niente di
speciale».
«A niente cosa?»
«A niente. Alla vita. Alla morte. »
Nei suoi disegni, aveva passato delle fasi di
intensa passione. Nei primi anni gli piaceva
molto dipingere il cielo oppure il mare, prendeva il pennello e faceva il foglio tutto azzurro
poi, sopra, metteva delle macchie di colore.
Ogni volta che provavo a indovinare, lui aveva
un gesto di impazienza: «Non lo vedi, sono stelle!». Oppure: «Guarda bene! Sono tutti pesci».
Al periodo degli elementi, era seguito quello
degli animali. Non dipingeva passerotti o
scoiattoli ma soltanto animali feroci. Grandi felini, giaguari, tigri, leopardi. Li coglieva sempre
nell'istante che precede l'assalto alla preda.
C'era concentrazione in quegli occhi giallo-verdi, in quei corpi raccolti, una concentrazione
che da lì a poco sarebbe esplosa con una forza
inaudita. Sembrava impossibile che fossero disegni di Un bambino di appena dieci anni.
Una volta gli ho chiesto se potevo incorniciarne uno e appenderlo in salotto, ma lui ha
avuto un moto di terrore. «No! no!» ha ripetuto con un'insolita determinazione, chiudendo i
fogli in una cartella con l'elastico.
Poi, la fase dei felini era stata sostituita da
quella delle croci. Ne faceva di piccole e di
grandi, sparse in disordine oppure ripetute geometricamente. Tutte comunque nere. Di rado,
intorno, c'era qualche elemento del paesaggio.
Un albero senza più foglie, una casa abbandonata in mezzo alla campagna.
Un giorno, mentre era a scuola, ho raccolto
tutti i suoi disegni e li ho portati ad una psicologa. Lei li ha esaminati a lungo. Teneva una
mano sul mento e ogni tanto mi faceva qualche
domanda. A me non importava niente dei felini o del mare, volevo sapere delle croci. Cosa
volevano dire? Era normale che le disegnasse
un ragazzo in buona salute di dodici anni?
La psicologa ha imputato tutto alla sofferenza neonatale. Quegli istanti trascorsi tra la
vita e la morte dovevano aver lasciato un segno
indelebile nella sua personalità. Probabilmente
il bambino non se ne rendeva conto, ripeteva
acriticamente dei moduli religiosi appresi in famiglia. Ho obiettato che nessuno di noi era credente e che, a
parte il battesimo, i miei figli non

avevano avuto alcuna forma di educazione religiosa. E' sembrata indecisa. Ha osservato ancora per un po' i
disegni, poi ha azzardato: «Forse allora è proprio questo che le vuole dire. Gli
manca qualcosa...».
Qualche mese più tardi, per la prima volta,
Michele ha reagito a una tua sfuriata. L'ha fat-
to a modo suo, naturalmente. Conoscevamo ormai tutti l'escalation della tua rabbia, ne prevedevamo ogni
tappa. Così, un attimo prima
della scena finale - i piatti rotti o i calci nelle
gambe - Michele ha piegato il tovagliolo, ha
mormorato: «Scusate», si è alzato e se ne è andato. Tu sei rimasto impietrito per lo stupore.
Poi mi hai guardato e sei corso a cercarlo.
Nella sua stanza non c'era, e in nessuna altra stanza. Era uscito da solo. Dove poteva essere? Per non darti
soddisfazione, ho finto una
tranquillità che non provavo, ma appena sei
andato in ufficio, mi sono precipitata a cercarlo. Ho girato per il quartiere, tutto il pomeriggio. Più lo cercavo,
più mi assalivano pensieri neri. Pensavo alla sua ingenuità, al suo
dolore, a tutti i rischi a cui poteva andare incontro.
Sono tornata a casa poco prima di cena. La
casa era al buio. Ho acceso la luce in corridoio,
pronta per chiamare gli ospedali, e l'ho visto lì,
rarmicchiato in un angolo. Era gracile, ossuto, si
teneva la testa tra le mani, singhiozzando. Mi sono inginocchiata accanto a lui: «Cosa ti è successo,
Michele?» ripetevo. «Cosa ti hanno fatto?»
«Niente» diceva, senza scoprirsi il volto.
«Niente... »
«E allora perché piangi?»
«Piango per Gesù», mi ha risposto guardandomi finalmente negli occhi. «Piango perché
Lui è morto per i nostri peccati e nessuno lo capisce. »
V.
Sulla credenza, qui in cucina, c'è ancora una
foto di Michele. Deve essere stata scattata nell'età del grande cambiamento. E' su un prato
insieme al nonno e, con una falce più grande di
lui in mano, lo sta aiutando a fare il fieno.
In quel periodo, questa casa era diventata il
suo porto sicuro, l'ancora di salvezza. Sapeva
che con i nonni poteva essere com'era, non trovava giudizio o disprezzo, soltanto l'affetto di
persone quiete. Tu non ti eri mai preoccupato di
quelle vacanze dai miei. In fondo era un modo
come un altro per toglierselo di torno. Ma quando ti sei accorto che per lui quei giorni erano
giorni felici, hai cominciato a osteggiarlo. Ogni
volta che programmava di andare a trovarli, inventavi qualcosa o lo mettevi in castigo. La felicità per te era
come un veleno, non sopportavi
di vederla brillare negli occhi degli altri.
Di nascosto da te e da me, Michele aveva cominciato a frequentare la parrocchia. C'era un
prete giovane con cui andava molto d'accordo.
Al compimento dei quattordici anni, senza dire
niente in casa, aveva fatto la comunione. Ero
stata la prima a scoprirlo e avevo cercato di tenertelo nascosto il più a lungo possibile. Un
giorno, però, tornando dal lavoro, l'hai visto
entrare all'oratorio.
«Da quando in qua frequenti quei posti?»
gli hai detto, a cena. «Ti ho forse autorizzato a
farlo?»
Allora lui, con l'improvvisa sfrontatezza dell'adolescenza, ti ha guardato dritto negli occhi.
«Ho fatto la comunione. Presto farò anche la
cresima. »
Per un istante ho temuto il peggio. Invece sei

rimasto immobile, perfettamente padrone delle
parole e dei tuoi gesti.
«Ah sì? Non mi stupisci. Che cos'altro dovevo aspettarmi da un decerebrato come te?
Vai pure a strusciarti sui banchi, consumati
pure le ginocchia, tanto non saresti capace di
fare altro. »
Non so se per l'età o per le nuove frequenta-
zioni, ma Michele stava diventando più forte.
Per la prima volta da quando era nato, aveva
degli amici. Ogni tanto andava a fare delle gite
in montagna oppure passava i pomeriggi a raccogliere gli stracci e la carta. Invece di disegnare, adesso
cantava. Ormai aveva le chiavi di casa e sentivo la sua voce ancor prima che aprisse la porta. Il timbro
stava cambiando. Un momento era baritonale, il momento dopo sembrava che due cocci di vetro stridessero
insieme. A me non dava alcun fastidio, temevo che
l'avrebbe dato a te. Ti avrebbero irritato le stecche, le parole, ti avrebbe irritato la luce pura
che si irradiava dal suo sguardo. Così, con ogni
cautela, fingendo di scherzare gli ho detto:
«Forse, finché non migliori il tono, è meglio che
non ti fai sentire da tuo padre! ».
Ormai Michele era alto quasi quanto me.
Stava davanti al frigo aperto. Ha sollevato le
spalle: «Pazienza», mi ha risposto, «nessuno è
mai morto per una stecca di troppo».
Davanti al suo cambiamento, mi accorgevo
di reagire anch'io in modo ambivalente. Da una
parte, ero felice di vederlo aprirsi e, dall'altra,
avevo paura che qualcuno potesse approfittare
della sua fragilità, che potesse plagiarlo. Così,
ogni tanto gli domandavo: «Chi vedi, cosa fate
quando siete tutti insieme?». Lui mi rispondeva sempre in modo scarno. Se insistevo, diceva:
«Seguimi, se ti interessa tanto».
Una volta, mentre tu eri in viaggio all'estero, per farlo contento l'ho accompagnato a
messa. Voleva a tutti i costi che sentissi un'omelia del suo amico. Lungo la strada non faceva altro che
ripetermi: «Non si può ascoltarlo e
restare indifferenti. Vedrai, è come trovarsi davanti a un muro. Se vuoi continuare a muoverti, devi per forza
cambiar direzione».
Ci siamo messi nei primi banchi. Erano talmente tanti anni che non entravo in una chiesa
che non mi ricordavo neppure una parola. Per
non deludere Michele muovevo le labbra, fingendo di pregare. Il brano del Vangelo riguardava la storia di un
tesoro nascosto in mezzo a
un campo. Michele era totalmente assorto, io invece avevo tanti pensieri in mente. Non riuscivo
a farmi una ragione chiara del suo cambiamento. La psicologa mi aveva messa in guardia. In
qualche modo cercherà di compensare la sua
fragilità. Ero vissuta per mesi con lo spettro della droga, dell'alcool, della depressione e invece
era diventato un ragazzo devoto. Ognuno, mi
dicevo, trova come può la sua forma di felicità,
c'è chi diventa tifoso di una squadra e chi va in
chiesa tutti i giorni. Tuttavia non riuscivo a liberarmi da una sottile inquietudine. Cos'era?
Paura di perderlo? Paura che imboccasse una
strada che non ero in grado di comprendere? O
forse un'inconsapevole forma di invidia, invidia
per la sua credulità, perché nel suo universo ormai ogni cosa aveva il suo giusto posto?
Anch'io, negli anni di maggiore difficoltà,
avevo cercato di aggrapparmi agli altari. Passando davanti a una chiesa, spesso entravo e mi
mettevo in ginocchio ai piedi di una statua. Ma
quella statua restava sempre una statua. Le chiedevo: «Chi sei? Parlami. Aiutami» e non ottenevo nessuna
risposta. Se mi fossi inginocchiata
davanti a una pila di barattoli di pomodoro al
supermercato, sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Mi avevi sempre detto che la religione
non è molto diversa da una carrozzina. Ci si siede sopra soltanto chi non è capace di camminare con le
proprie gambe. Con una carrozzina, i
movimenti sono limitati, puoi andare avanti e indietro, a destra e a sinistra, non puoi certo salire

le scale o lanciarti di corsa giù per un prato.
Naturalmente a Michele tenevo nascosti
questi pensieri.
Usciti dalla chiesa, mi ha chiesto: «Come ti
è sembrato?». Ho risposto nel modo più banale: «Molto interessante».
Ogni tanto mi faceva partecipe delle sue riflessioni. Non dovevo essere molto abile nel fingere perché, una
volta, mi ha detto: «Non sembri entusiasta».
«Ti ascolto volentieri», ho risposto, «però, come sai, ho le mie idee ed è difficile cambiarle.»
Si è alzato di scatto gridando con rabbia:
«Perché sei così cieca? Gesù non è un'idea, è il
Salvatore. Gesù è l'inizio e la fine di tutto. E la
vita è la chiave per capirlo».
Prima che io potessi replicare, è uscito dalla
stanza.
Era la prima volta che si comportava con
me in quel modo. Il bozzolo affettuoso dentro al
quale avevamo convissuto per quindici anni ormai si era rotto.
Nello stesso periodo mi hanno chiamato a
scuola. Volevano sapere perché frequentava così poco. Io sono caduta dalle nuvole. Lo vedevo
uscire tutte le mattine con lo zaino sulle spalle.
Non avevo mai immaginato che potesse andare
in un luogo diverso.
Sono tornata dalla psicologa. Un'infatuazione mistica, mi ha detto, a quest'età è piuttosto
normale, gli ormoni si mettono in moto e la libido comincia a farla da padrona. In chi si reprime, può
prendere una direzione diversa da quella abituale. E poi forse, aveva aggiunto, la frequentazione della
chiesa gli permette di vivere
una forma latente di omosessualità senza mai lasciarla esplodere. Mi aveva consigliato di non dare molto
peso alla cosa. Se non fosse divenuta
motivo di opposizione, in breve tempo, come si
era gonfiata, così si sarebbe smontata.
Ho seguito i suoi consigli. Per non rendere
tutto più grave, ti ho tenuto all'oscuro, però ho
affrontato Michele.
«Perché non vai a scuola? »
«Perché mi annoio.»
Alla fine di giugno è venuto tutto a galla. E'
stato bocciato.
«Te l'avevo sempre detto che era un cretino», hai commentato, scorrendo la pagella. Anche se ne avessi
avuto il coraggio, quella volta
non avevo saputo cosa risponderti. Poi ti sei rivolto a lui. «Per quanto tempo ancora credi che
ti manterrò senza fare niente? »
Michele ha sostenuto il tuo sguardo. «Puoi
smettere anche adesso. »
«Ah sì? E come pensi di vivere. Facendo
marchette? »
«Vivo come i gigli dei campi. »
«Non dire stronzate. »
«Non sono stronzate, è la mia fede.»
«La tua cosa?»
«Credo in Gesù.»
Sei scoppiato a ridere fragorosamente e poi
ti sei bloccato di colpo. Con la voce in falsetto
hai cantilenato: «Credo in Gesù! Credo in Gesù! Soltanto una mezza checca come te ci può
cascare ».
«Non sono omosessuale. »
«Se tu scopassi come tutti gli altri non avresti queste fisime. Chi ha le palle non crede in
uno così sfigato che si è fatto ammazzare. »
«Non bestemmiare! »
«Non bestemmio, tesoro, dico la verità. Gesù era un mitomane e anche piuttosto digiuno
di diplomazia politica. Per questo si è fatto ammazzare. Si è sopravvalutato e ha sbagliato i
calcoli. »
«Gesù è il figlio di Dio.»

«Se fosse stato il figlio di Dio, sarebbe sceso
dalla croce e avrebbe incenerito tutti gli astanti, lo dice pure la Bibbia. Non è sceso perché
non era in grado di scendere.»
«Non è sceso perché non ha voluto scendere. »
«Non è sceso perché era soltanto un poveraccio che si era raccontato una bella storia. La
storia è finita male e lui è rimasto inchiodato
lassù. »
Michele si è alzato, sembrava persino più alto della sua statura.
«Sei tu il poveraccio! » ti ha gridato in faccia.
«Michele, basta! » ho detto, alzando la voce.
Ma era troppo tardi, con uno schiaffo gli hai
fatto volare via gli occhiali, con un altro gli hai
riportato la testa nella giusta posizione.
«Cos'hai detto?» ripetevi, scuotendolo come
un fuscello. «Cos'hai detto? »
E' rimasto zitto, però continuava a fissarti
dritto negli occhi.
«Qui il padrone sono io, abbassa lo sguardo», hai cominciato ad urlare. Più lo scuotevi,
più sosteneva il tuo sguardo. Così l'hai trascinato nella sua stanza. Non so cosa sia successo
là dentro. Ti sentivo gridare sempre più forte.
Lui stava zitto.
Dopo un tempo che mi è apparso interminabile, sei uscito chiudendolo dentro.
«E' in castigo», mi hai detto infilando la chiave in tasca, «e ci rimane finché lo decido io.»
VI.
Quanto è durata la sua prigionia? Dieci
giorni, forse quindici. Avevo il tuo permesso di
aprire la porta tre volte al giorno. «Se fai la furba, me ne accorgo.»
Ti eri illuso in quel modo di piegarlo. Ogni
giorno speravi che ti supplicasse di farlo uscire,
invece lui stava lì nella sua stanza senza alcuna
apparente forma di turbamento. Leggeva, scriveva il suo diario. Quando tu non eri in casa,
cantava. Era il mese di giugno.
I primi di luglio sei partito per seguire la tua
fabbrica in Thailandia, non avevi lasciato nessuna disposizione in merito e così l'ho fatto
uscire. Volevo rimanere vicino a Laura, che stava affrontando le prove scritte dell'esame di
maturità. Quando Michele ha chiesto se poteva
andare dai nonni a fare il fieno, gli ho risposto:
«Vai pure».
Ormai non era più il mio bambino sognante
ma un ragazzo con le idee piuttosto chiare. Dimostrava una determinazione davanti alla quale spesso mi
sentivo in imbarazzo.
Da lassù mi ha scritto una lettera. La prima
e l'ultima della sua breve vita. L'ho letta così
tante volte da saperla a memoria.
Cara mamma, oggi sono andato a fare una
passeggiata fino ai ghiaioni dei Comeglians.
L'aria era fresca e non c'era neppure una nuvola in cielo. La nonna non voleva lasciarmi
andare, ma l'ho tranquillizzata. Conosco meglio i sentieri di quassù che le strade del mio
quartiere.
Quando vengo qui, mi rendo conto che tutti i
giorni vissuti in città sono giorni vissuti in apnea.
Tutto è così brutto intorno, così triste. Se apro il
naso, sento la puzza dei tubi di scappamento, se
apro le orecchie, sento il loro rumore. Se apro il
cuore, vedo la miseria e la solitudine degli altri

cuori. Vivere lontano dalla natura, vuol dire vivere lontano dalla bellezza. E vivere lontano dalla bellezza,
vuol dire vivere lontani dal pensiero
di Dio. Lo so che a questo punto sbufferai. Pensi che io sia come quelle cuoche che mettono
troppo sale dappertutto.
Invece del sale, metto Dio e tu non lo sopporti. Pensi che Dio dovrebbe stare nelle chiese
e nelle teste dei preti. Me l'hai detto tu stessa,
ricordi? Dio è un 'idea. Un 'idea uguale a tutte le
altre. Posso credere in Dio o in Che Guevara.
Posso anche credere soltanto nelle vittorie della Ferrari.
E' per questo che ti senti così sola, sai? Ogni
tanto ti guardi intorno come se fossi una bambina smarrita. Forse puoi ingannare gli altri e
te stessa, ma non puoi ingannare me. Nei tuoi
occhi c'è timore, hai troppe idee in testa e in
fondo non sai qual è quella giusta.
Ma Dio non è un'idea! E' il luogo da cui veniamo e il luogo in cui un giorno ci riuniremo.
E' la misericordia amorosa che ci guida nel
cammino. Oh mamma, quanto mi piacerebbe
che tu aprissi il tuo cuore, che tu ti abbandonassi come un neonato tra le Sue braccia.
Mi sento sempre tanto impotente davanti a
te. Quando provo a parlarti, afferri le mie parole con una pinza e le esamini a lungo controluce, come
cercassi qualcosa di nascosto. C'è la
filigrana? O non c'è? Sono vere? Sono false?
In fondo sei convinta che la mia fede, sotto
la sua apparente serenità, celi qualcos 'altro.
Una paura, un problema non risolto. Qualcosa
che temo o che non voglio guardare in faccia.
Anche se non mi crederai, ti posso assicurare
che non è così. Fin da quando ero molto piccolo, sentivo dentro una grande inquietudine. Era
questa, forse, la ragione per cui non volevo stare con gli altri bambini. Che inquietudine era?
Un'inquietudine di sospensione, di incompletezza. Percepivo ancora l'oscurità densa che da
poco avevo lasciato alle spalle. Intuivo che una
non diversa un giorno mi si sarebbe spalancata davanti. Cosa ci stavo afare lì in mezzo? Era
come Se, dentro, avessi una sfera di cristallo simile a quella che hanno i maghi. Soltanto che
non era limpida ma torbida, opaca. Suonare,
dipingere, stare sempre solo erano tentativi per
renderla più chiara. Stavo lì in ginocchio e la
strofinavo come Aladino strofinava la lampada.
Illuminati, sfera! E un giorno la sfera si è illuminata.
Solo allora mi sono reso conto che non si
trattava di una sfera, chiusa in tutte le sue parti, bensì di un bocciolo. I raggi del sole l'avevano sfiorato e i
petali si erano aperti. Asp ettava
soltanto la loro carezza per farsi invadere dalla luce.
Quel giorno ho capito che dentro ognuno di
noi c'è questo bocciolo. Può essere più piccolo o
più grande, più avanti o più indietro nel suo
percorso di fioritura, ma c'è. Basta lasciarfiltrare dentro un po' di luce perché cominci a
schiudersi.
Per questo mi permetto di dirti: perché, invece di pensare alle idee, non pensi alla Luce?
Non devi più difendere, giudicare, scartare o
approvare. Devi soltanto abbandonarti, accettare senza riserve di essere figlia non del caos o
del caso, ma della Luce.
Povera mamma! A questo punto sarai morta di noia. Ti tocca sentire i predicozzi da tuo
figlio. E' colpa mia, perché non riesco a trattenermi dal voler condividere ciò che è bello con
gli altri.
Non sai cosa mi è successo quando sono arrivato alle pendici dei ghiaioni! Ho scoperto una
marmotta che allattava i suoi piccoli. Stava na
scosta sotto una grande roccia. Quando mi ha
visto, invece di fuggire, è rimasta ferma al suo
posto, i cuccioli continuavano a prendere il latte
e lei mi guardava dritta negli occhi. Era la prima volta che vedevo una marmotta così da vicino. Di solito
sentivo i fischi e poi intravedevo le
loro piccole sagome precipitarsi nelle tane. Vedi,

anche su questo papà si sbaglia. Lui dice che gli
animali temono di guardare una creatura superiore negli occhi e invece si sbaglia. Forse sarà
vero per i babbuini, ma non per le marmotte.
Dopo aver mangiato accanto a un cespuglio
di pino mugo, mi sono sdraiato a guardare il
cielo. Come sarebbe bello se le nostre vite potessero essere altrettanto limpide, altrettanto
serene!
Ho ripensato spesso allo scontro dell'ultima
volta. Papà non mi sopporta, non mi ha mai
sopportato perché sono diverso da lui e non riesce a capirmi. Anch'io alle volte sono esasperato, perché
cerco di dare il minor fastidio possibile, eppure lui mi attacca sempre e comunque.
Sto cominciando a pensare che la soluzione migliore sarebbe quella che io me ne andassi presto da casa.
Intanto potrei restare l'intera estate dai nonni. Che cosa ne dici? Credo che in autunno dovrò comunicarvi
una decisione importante e devo sentirmi abbastanza forte per farlo. Anche se vi do dei dispiaceri nella vita
di
tutti i giorni, prego sempre per voi, per le vostre
gemme, perché, prima o poi, accettino la luce e
si trasformino in fiori. E vi ringrazio con una
gratitudine immensa perché è stata la vostra
generosità a farmi esistere in questo mondo.
Un abbraccio forte quasi quanto quello di
un pitone dal tuo purtroppo ex docile bambino
Michele.
La lettera è arrivata il giorno stesso in cui tu
sei tornato dalla Thailandia.
«Dov'è tuo figlio?» mi hai chiesto. Ti ho detto la verità: «E' andato ad aiutare il nonno a fare il fieno».
Tu hai voluto a tutti i costi che tornasse a casa. «Non si è meritato nessun tipo di vacanza.»
Ho dovuto fare delle lunghe trattative al telefono. Michele non voleva saperne di tornare
indietro. Soltanto quando, con una voce prossima al pianto, gli ho detto: «Pensa almeno a me,
a quanto mi tormenterà tuo padre» con un sospiro, aveva detto: «Va bene, vengo».
Nei mesi, negli anni che sono seguiti non ho
fatto altro che pensare a quella telefonata. L'ho
sentita, risentita, smontata e rimontata. Ho cercato di immaginare tutti i punti cardine, il momento esatto in
cui il destino, invece di andare
dritto, aveva invertito la marcia. Alla fine, per
quanto mescolassi le carte, la risposta era sempre la stessa. Alla base di tutto c'era solo e soltanto la mia
mancanza di coraggio. Avrei dovu
to credere di più in Michele, farmi avanti, difenderlo, aver meno timore della violenza delle
tue reazioni.
Quando Michele è tornato, era la fine di luglio. La città era già incandescente, le strade
erano quasi deserte e l'asfalto filava sotto i piedi. Laura aveva finito l'esame di maturità, a
scuola non era mai stata molto brillante e anche in quell'occasione non si era smentita, il suo
voto era stato appena un po' superiore alla sufficienza. Tu non ti eri scandalizzato. «Il tesoro
di una donna», amavi ripetere, «non è certo nel
suo cervello. » Con generosità le avevi offerto
una grande festa nella villa. Per i diciotto anni
e per la maturità. Visto che la ditta era già in
ferie, anche tu eri rimasto a festeggiarla. Mentre andavo avanti e indietro con i vassoi delle
tartine, ti ho visto sempre in mezzo a capannelli di sue amiche. Ridevano tutte per le tue battute e tu intanto
ti aggrappavi ai loro fianchi.
Michele è arrivato quella sera. C'era la musica a tutto volume e dei fari illuminavano la
casa come fosse una discoteca. E' andato subito
ad abbracciare sua sorella. «Ce l'hai fatta, eh? »
Sono rimasti per un po' così stretti, senza dirsi
niente. Poi lei è tornata a ballare e lui si è lasciato cadere a peso morto su una poltrona.
Si guardava intorno sorridendo. Per un attimo l'ho osservato ed ho provato una sensazione
di lontananza. Dov'era mio figlio in quel momento? Era lì presente o era da un'altra parte?
Non riuscivo a capirlo. A un certo punto un'amica di Laura si è seduta accanto a lui, su un
bracciolo. Hanno cominciato a ridere e a scherzare. Tu sei piombato come un falco, l'hai afferrato per un
braccio e l'hai costretto ad alzarsi.
«E' la tua festa?»

«E allora vattene. Non hai niente da festeggiare. »
Ho avuto paura della possibile reazione di
Michele. Invece si è alzato e in silenzio ha lasciato la stanza.
Non so perché, ma vederlo così docile mi ha
stretto il cuore. Avrei voluto seguirlo, parlargli,
ma in quel momento non potevo lasciare la cucina. Ho pensato che l'avrei raggiunto in camera sua appena
tu ti fossi addormentato. Le parole della sua lettera mi avevano colpita, mi
sembravano una specie di passerella lanciata
sul baratro, qualcosa che avrebbe permesso di
ricomporre il doloroso percorso delle nostre due
vite. Volevo andare da lui e farlo accoccolare su
di me come quando era bambino e si lasciava
cadere a peso morto tra le mie braccia. Saremmo rimasti così, a parlare tutta la notte anche
se ormai era lui a potermi prendere in braccio.
Ma poi la stanchezza mi ha sopraffatta. Tu
continuavi ad essere sveglio, giravi per la stanza, aprivi e chiudevi i cassetti come cercassi
qualcosa. A me, invece, si chiudevano gli occhi.
"Pazienza", ho pensato, "farò domani quello che volevo fare oggi" e sono andata incontro
al mio ultimo sonno di madre.
VII.
Adesso so che quel giorno è stato per me come il lampo di un fotografo. Non ero ancora in
posa e quel lampo mi ha accecata. La mia esistenza si è fermata in quel preciso istante. Gli
anni che ho vissuto dopo sono rimasti compressi in una frazione di secondo.
Molte volte nei romanzi o nella cronaca sì
sente parlare del presentimento. A un tratto,
una persona intuisce che sta per accadere qualcosa di grave e quella cosa, poi, accade per davvero. Io
quella mattina non mi sono accorta di
niente. Anzi, al risveglio, ero insolitamente di
buon umore. Il giorno dopo saremmo partiti
per il solito viaggio in barca con gli amici, in
Sardegna. Dovevo fare le valigie, occuparmi degli ultimi dettagli. Michele sarebbe rimasto a
casa in castigo e avrebbe bagnato le piante.
Questa era la decisione di suo padre. Mi era
sembrato molto contento. Per lui, andare al
mare era sempre stata una tortura. Ero uscita
prima del grande caldo, poco dopo di te. Laura
invece era rimasta a casa. Dormiva.
Non ho visto Michele, quella mattina, ma
non me ne sono preoccupata. Aveva sempre
avuto i suoi movimenti segreti. A pranzo abbiamo mangiato tutti insieme gli avanzi della
sera prima. Il pomeriggio tu sei andato alla
ditta a sistemare alcune cose e io sono uscita
per delle commissioni.
Ci siamo ritrovati soltanto all'ora di cena.
Faceva molto caldo, per far circolare l'aria
avevo aperto tutte le finestre. Zanzare e moscerini giravano in gran numero intorno alla lampada alogena.
Ogni tanto la stanza veniva invasa dall'odore acre di un insetto che arrostiva,
fumando, sulla lampada.
Per sederci, come sempre ti avevamo aspettato. Farlo prima di te sarebbe stata una mancanza di rispetto
che non avresti tollerato. Invece che alle Otto, come sempre, sei arrivato alle
otto e dieci. Avevi il viso molto tirato.
Ti sei lasciato cadere sulla sedia e hai detto:
«Qualcuno ha rubato i miei soldi».
«Cosa dici?»
«Stavano nel cassetto e non ci sono più. »
Stavo per dire: «Sarà entrato qualche zingarello» quando Michele ha detto: «Sono stato io.
Ma non li ho rubati, li ho solo presi in prestito.

Non eri in casa e non ho potuto avvisarti».
Tu sei rimasto perfettamente immobile. Vedevo solo le vene del tuo collo pulsare con insolita velocità.
Ho spezzato il silenzio dicendo: «Michele,
come ti è venuto in mente?».
«Ho incontrato una persona che ne aveva
bisogno. »
Quando hai parlato tu, la tua voce veniva
dal profondo, sembrava quasi un rantolo. «Chi
sei adesso, eh? Chi sei? Sei Robin Hood? Rubi
ai ricchi per dare ai poveri? »
«Ti ho detto che te li restituirò. »
«Ah sì? E come li guadagni?»
«Lavorerò. »
«Lavorerai... E come credi che li abbia guadagnati, io?»
«Non certo con il sudore della tua fronte. »
Le tue braccia cominciavano a tremare in
maniera visibile.
«E con il sudore di chi allora? »
Michele è rimasto un po' soprappensiero. Mi
sono chiesta se avesse paura. Io avevo paura
per lui. Ha fatto un respiro profondo prima di
dire: «Con il sudore dei bambini che sfrutti in
Oriente».
A quel punto è successo il finimondo.
Laura è fuggita fuori dalla stanza, io goffamente ho cercato di dividervi. «Mollusco! » hai
gridato, colpendolo, «anche tu mangi grazie a
loro e ti compri i tuoi vestiti da finocchio e vai
a scuola. Cosa credi di essere, molto diverso da
me? Credi di essere meglio? Rispondi!»
«Diverso, si. Io credo in qualche cosa. »
Mi sentivo dire con voce debole: «Basta, lo
ucciderai!». Con uno spintone mi hai rimandato indietro.
«Ah sì, e in cosa credi? Nel furto?»
Ormai Michele era per terra in un angolo.
«Credo nell'amore. »
«Allora vai a battere.»
«Nell'amore dello Spirito.»
L'hai sollevato da terra, afferrandolo per la
maglietta. Davanti al suo corpo esile sembravi
davvero un orco.
«Allora», gli hai ringhiato in faccia, «porgi
l'altra guancia! »
Con un sorriso da bambino, ti aveva risposto: «Eccola!».
Per mettere a fuoco una scena, le macchine
da proiezione antiche ci impiegavano un bel po'
di tempo. Prima, tutto era confuso, non c'erano
volti o paesaggi ma soltanto macchie di luce e
di colore in continuo movimento. Così ricordo
le ore prima del lampo di magnesio. Ricordo
Michele sbattuto fuori. Ricordo che mi sono avventata contro di te. «Ucciderai nostro figlio»,
ho gridato, mentre tu mi afferravi il polso. Dentro di me c'era una tigre, qualcuno aveva appiccato il fuoco
alla sua coda ed era impazzita.
«Lui ha un'anima grande! »
«Della sua anima me ne sbatto! »
Non so per quanto tempo siamo andati
avanti a quel modo, urlandoci di tutto. Mi sentivo come se fossi uscita fuori dal corpo. Potevano essere
minuti o forse ore. A un certo punto, mi hai scaraventato contro la credenza dell'ingresso e sei uscito
sbattendo la porta.
Ti ho sentito avviare la macchina in garage
e percorrere il viale di ghiaia. Facevi rombare
l'acceleratore come fanno i ragazzini ubriachi.
Hai rallentato per un istante davanti al cancello automatico. Quando si è aperto, sei partito
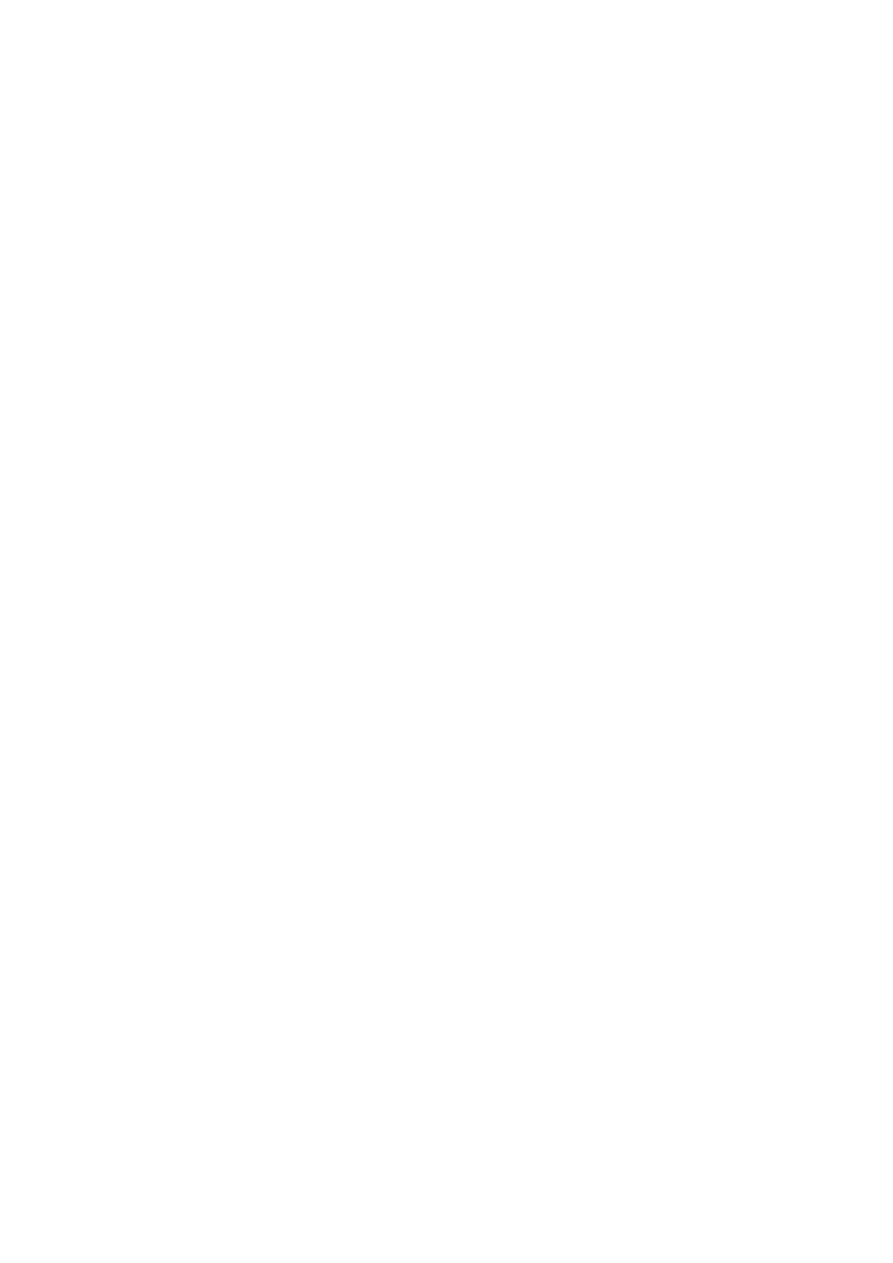
sgommando a tutta velocità.
C'è stata un'improvvisa frenata. E poi un
tonfo.
Temevo che avessi preso un cane, per questo
mi sono affacciata. Michele sembrava dormire,
disteso sull'asfalto. Teneva un braccio abbandonato lungo il fianco e l'altro sopra la testa,
come faceva quando aveva troppo caldo nel suo
letto da bambino.
VIII.
L'odio è l'unico sentimento che con il tempo
non svapora. Anzi, con la forza di un uragano,
continua ad accumularsi come un'energia viva
e potente. E' l'odio che, in tutti questi anni, mi
ha tenuta in vita, mi ha resa asciutta e caparbia, assetata di vendetta.
Avrei potuto dire: vivo soltanto per il ricordo di mio figlio. Invece sono sincera e dico: vivo soltanto per
vendicarlo.
O meglio, ho vissuto con questa attesa.
Quest'attesa si è vanificata il giorno stesso
in cui ti ho trovato disteso sul pavimento del
bagno. Avevo sperato, per te, in una morte
atroce. Un cancro al cervello, qualche malattia
immunodepressiva che ti riducesse a una larva
con i pannoloni addosso. Invece, per la felice
sorte che in questo mondo protegge sempre i
malvagi, hai preso per te la morte migliore un fulmineo arresto cardiaco - e hai lasciato
l'altra a me.
Speravo che l'essere tornata nella casa dei
miei genitori avrebbe reso la mia pena meno
grave, ma non avevo fatto i conti con il silenzio,
e con la memoria dei morti.
Non avevo fatto i conti con l'ossigeno della
montagna che nutre meglio il cervello e il cuore, rendendo ogni sentire più forte. Come nei
tempi antichi si dava fuoco alla moglie sulla pira del marito, così io ho raccolto per la casa gli
oggetti più cari e li ho messi sul mio letto. La
sera mi infilo là sotto e mi sento meno sola,
quelle cose hanno ancora una vita, respirano,
emanano calore. Anche il pigiama che indosso
non è mio, ma di Michele.
L'altra notte, camminando per la casa, sono
passata davanti a uno specchio e mi sono accorta
di irradiare luce. Ero io o era qualcuno che mi
stava accanto? Era la luce dell'amore o la luce
dell'odio? «Chi sei?» ho chiesto piano. Sul soffitto sopra di me stava camminando un topo o forse un ghiro.
«Chi è? » ho ripetuto più forte. Un'asse del pavimento ha scricchiolato, ho avuto l'impressione che fuori
stesse per levarsi il vento.
Tragica fatalità, aveva scritto il giorno dopo
il quotidiano cittadino.
Michele è morto sul colpo. Tu sei sceso dalla macchina e ti sei messo le mani nei capelli.
Non l'avevi visto, non potevi immaginare che
mentre tu uscivi a una velocità folle, lui ti stesse correndo incontro.
Io non avevo fatto niente, ero rimasta lì sul
balcone, immobile, come nel palco di un teatro.
Ho visto arrivare l'ambulanza e il medico scuotere la testa.
Accanto al medico era comparso un vecchio
cane bianco. Ho notato che ti guardava con la
bocca spalancata e la lingua fuori, come se volesse dirti qualcosa.
Ti ho visto prendere il medico per il bavero,

l'ho sentito gridare: «Non è più compito nostro». Allora hai tirato un calcio al cane. Invece
di guaire e andarsene, si è seduto a fatica accanto al corpo, sull'asfalto.
Ho visto arrivare la polizia e poi il carro
mortuario. Hanno chiuso Michele prima in una
sacca di plastica e poi in un contenitore di metallo. Quando lo hanno fatto scivolare dentro,
ho sentito un tonfo sordo. Deve essere la testa,
ho pensato, fin da bambino l'ha avuta troppo
grande.
Mi sono ricordata del primo maglione che gli
ha fatto mia madre, azzurro tenue con dei gattini ricamati sul davanti. Il modello era per un
bambino di sei mesi ma la testa non entrava,
avevo dovuto aggiungere due bottoni per riuscire ad infilarglielo. Ho rivisto la sommità della sua testa chiara,
la fontanella ancora aperta.
Io tentavo di tirare giù la maglia e lui protestava. Era maggio ed eravamo a casa dei miei. Da
poco aveva fatto il bagnetto, dal suo corpo
emanava tepore, odore di borotalco.
Quando i necrofori hanno sbattuto i portelloni del furgone, l'incantesimo si è rotto. Ho urlato: «Noooo! »
come fosse l'unica parola al
mondo. Poi ho perso conoscenza.
Per tutta la durata del funerale mi hai tenu
ta stretta sotto il tuo braccio. Io piangevo, tu eri
impietrito. Ricordo una gran folla di volti e dei
ragazzi che suonavano la chitarra. Su di noi
picchiava il sole di agosto.
Il suo amico prete sudava sotto i paramenti.
«Per una ragione nascosta alla nostra piccola mente di uomini, spesso il Cielo chiama a sé
i suoi figli più luminosi, interrompendo bruscamente il loro cammino terreno. »
Due lacrime gli rigavano il volto e non si curava di nasconderlo.
«E' facile ribellarsi, facile indignarsi davanti
a un arbitrio così grande. Michele portava luce
nelle nostre vite e tutti noi, egoisticamente,
avremmo voluto che quella luce durasse più a
lungo. »
Davanti c'erano i nonni. Poco prima che calassero il feretro si sono inginocchiati accanto a
lui. La nonna ha posato un bacio leggero sul coperchio. Ho visto le sue labbra muoversi dicendo piano:
«Ciao pulcino». Il nonno aveva in
mano il piccolo flauto, l'ha lasciato là sopra,
con una timida carezza.
Poi c'è stato solo buio. Buio, buio, buio.
Buio con bagliori. Buio con fulmini, con tuoni.
Buio con grandine. Buio con terremoti e tifoni.
A lampi, ho visto delle facce, ho sentito delle
voci. La tua faccia che diceva: «Vado in barca
lo stesso». La faccia di un medico: «Con queste,
risolveremo il problema». La faccia di un prete.
«Vada via! » ho urlato. La faccia di mia madre:
«Michele è ancora con noi». «Stupida bugiarda. » Gridavo sempre. Ogni tanto c'erano delle
termiti sul mio corpo, raggiungevano gli interstizi più intimi e da lì mi divoravano a minuscoli morsi. Altre
volte erano ragni, tantissimi
ragni, pelosi, neri, con le zampe corte e grosse.
Correvano dappertutto cercando il luogo migliore in cui inoculare il loro veleno. Altre volte
ancora serpenti sottili, si attorcigliavano intorno alle mie caviglie, saettando le loro lingue letali. Quando ho
visto nuovamente il mio volto
nello specchio era quello di una vecchia. Ci sono rughe da nonna e rughe da strega. Le mie
erano tutte rughe da strega.
Dopo la tragedia, Laura se n'è andata a studiare all'estero. Mi telefonava una volta al mese per non dire
niente.
Tu ti sei buttato tutto nel lavoro.
«E' stata una disgrazia», continuavi a ripetere. «L'hai ucciso», rispondevo. E questo era tutto il nostro
rapporto.
Ti restavo accanto per poterti odiare fino all'ultimo giorno. Ma non era la sola ragione. Ti restavo accanto
anche perché non avrei potuto sopravvivere neppure un'ora sola con il mio dolore.

Quanto sono stata ingenua a pensare di batterti sul tuo stesso terreno! Ho parlato di termiti, di ragni, di
aspidi mortali, ma non di scorpioni. Lo scorpione eri tu.
Ricordo ancora l'indignazione di Laura, una
sera, davanti alla TV. Stavano trasmettendo un
filmato sulle bambine prostitute del terzo mondo. La tua risposta era stata pacata, da uomo
adulto del mondo civile.
«Non devi farti prendere da sentimentalismi», le avevi detto. «La loro vita non è come la
nostra. Non studiano, non leggono, non hanno
da mangiare. A cinque anni se le scopa lo zio, a
sei, se ne vanno per la strada. Le incontri, le
guardi negli occhi e capisci al volo che non sanno fare altro. E' quello il loro destino. E, in più,
mantengono i genitori e i fratellini. »
«Vuoi dire che è una cosa giusta? »
«No, solo che è da ipocriti scandalizzarsi più
di tanto.»
Perché non ti avevo dato uno schiaffo? Perché non te l'avevo dato un numero infinito di
altre volte? Non lo so perché. O forse lo so trop-
po bene. Perché avevo paura, perché ero succube, perché forse, in fondo, pensavo che avessi
ragione. Perché milioni di persone avevano seguito ciecamente Stalin e Hitler e tutti gli altri
dittatori senza mai essere sfiorati da un dubbio
sulla giustizia delle loro azioni. Una volta me
l'hai anche detto: «Ti ho sposata per riprodurmi, perché eri bella e perché eri sana. Ti ho sposata perché eri
povera e non potevi fuggire da
nessun'altra parte». Non hai detto "perché eri
stupida" ma sicuramente lo hai pensato.
Alla fine del miei giorni, minata dal virus
devastante che mi ha lasciato come una baita
rosa dai tarli, ho capito che avrei potuto prendere delle decisioni diverse in ogni giorno della
mia vita. In ogni ora. In ogni minuto. In ogni
secondo.
Non ci voleva molto. Sarebbe bastata un po'
più di fiducia. Sarebbe bastato tenere lo sguardo appena un po' più alto.
IX.
Il vento soffia da tre giorni e ha portato le
nuvole. L'estate sta volgendo al termine, le cime
dei monti sono già imbiancate di neve. Con l'avvicinarsi dell'autunno, cambia l'odore della terra. Il sole non
asciuga più l'umidità della notte,
i campi restano bagnati. Cominciano a ingiallire le foglie dei meli, diventano rosse quelle degli
aceri, gli aghi dei larici si infiammano. Le legnaie vengono riempite per l'inverno. A giorni le
mucche scenderanno dall'alpeggio.
La settimana scorsa finalmente hanno portato quassù Michele. Non volevo lasciarlo giù in
città, accanto a te. Un piccolo tumulo accanto a
quello dei nonni, vicino a quello che presto sarà
il mio. Ho piantato sopra delle calendule dell'orto, gialle e arancio, come tanti piccoli soli. Speriamo che
resistano, che il gelo tardi a venire.
Alcune mamme, ho sentito dire, riescono a
sentire la voce dei loro figli sul nastro del registratore. Lo lasciano acceso durante la notte e il
mattino trovano incise delle frasi dolci. Altre
giurano di averli visti, mescolati tra la folla o
comparsi all'improvviso, luminosi, accanto a
loro. A me non è mai successo. Michele è svanito nel nulla, non mi ha parlato, non l'ho più visto. Forse sono
stata troppo dubbiosa. Ho avuto, ancora una volta, troppa paura.
La casa è pronta per l'inverno, ho sostituito
le finestre, pulito il caminetto e le stufe. Al posto del vecchio scaldabagno a legna, ora ce n'è
uno elettrico.
La casa è pronta ma il mio cuore no. C'è più
calma dentro, ma non pace, a tratti l'odio trabocca fuori come pasta troppo lievitata.

Non ti perdono e non mi perdonerò mai.
La terra non mi è lieve sotto i piedi e ancora meno lieve mi sarà sopra. Diventerò un'anima errante, un
fantasma che gira in catene, la
prima abitante dell'inferno. O l'ultima. O non
diventerò niente.
Tutto sbatte, questa notte. E' terribile. Non
mi ricordavo di quanto la tramontana potesse
somigliare a un uragano.
Da vent'anni non dormo più una notte intera. Qualche volta sto quieta a letto, qualche altra mi alzo e vado in
giro per la casa, bevo del
latte, ascolto la radio di paesi lontani. Così ho
fatto questa notte, mi sono alzata, ho infilato
un grosso maglione di lana e sono andata in cucina. Non ho fatto altro che pensare all'inferno,
a quella cretinata che ho sentito un giorno da
quel teologo. Così ho preso carta e penna e mi
sono messa a scrivere una lettera:
Caro amico teologo di cui non ricordo il nome...
All'improvviso è mancata la luce, così ho
dovuto alzarmi e accendere una candela. Poi ho
continuato:
Tempo fa ho visto un suo programma e ne sono rimasta indignata. Su un punto potrei venirle incontro.
L'inferno è attualmente vuoto perché
tutti i diavoli, di ogni gerarchia, ormai scorrazzano sulla terra. Non sono ignorante né medievale. Lo dico
soltanto perché ho diviso la mia vita con uno di loro. Ogni giorno guardo come si è
ridotto l'uomo e capisco che non può aver fatto
tutto da solo. Il diavolo non è puzzolente né primitivo. La sua dote primaria è l'abilità. Conosce
come pochi l'animo umano e può insinuarsi in
qualsiasi persona. Non dice lordure, porcherie,
usa argomenti ragionevoli, raffinati. «Non credi
di meritarti di più dalla vita, molto di più?» ha
detto a me, tanti anni fa e io ho pensato che aveva ragione. Non dovevo più accontentarmi di
niente. Non mostra i genitali e non scorreggia, ci
accompagna invece nel labirinto della vita con
l'aggraziata leggerezza di un ballerino di valzer.
L'inferno è vuoto soltanto perché il padrone
di casa è andato a riempire le sue reti nel mondo dei viventi. Presto tornerà laggiù letteralmente piegato dal
peso delle sue prede. Tutti
urleranno, strepiteranno, cercheranno di ribellarsi. «Era questa la fine del gioco? Perché nessuno ce l'ha
detto?» Ma sarà troppo tardi.
Da qualche parte ho letto che nei tempi antichi, gli uomini vicini a Dio erano raffigurati
con grandi orecchie perché ascoltavano direttamente la Sua parola. Adesso invece viviamo in
un mondo di talpe. Siamo ciechi, con padiglioni
auricolari praticamente invisibili. Io ho provato
tante volte a tendere le orecchie verso l'alto ma,
purtroppo, non ho mai sentito niente.
Ho sempre sentito salire, invece, un forte rumore da sotto.
Mi piacerebbe avere la fede, appianare ogni
cosa prima di andarmene, ma non ci riesco. Ho
visto il male spandersi a piene mani. Ha invaso la
mia vita e quelle di chi mi stava accanto come
una macchia d'inchiostro. L'ingiustizia, la diseguaglianza, la violenza. Queste e non altre sono
le leggi che dominano il mondo. Così dico: ci lasci
almeno la gioia dell'inferno. Un inferno affollato
e rumoroso come una spiaggia d'agosto. Non vedo l'ora di sprofondarci dentro e soffrire per sempre.
Perché, nella mia vita, ho provocato solo dolore ed è giusto che, nel dolore, io viva per sempre.
Un 'ultima cosa. Lei ha detto anche che bisogna amare il diavolo perché il diavolo è solo
con la sua disperazione.
Allora le dico questo, che delle lacrime del
diavolo possiamo fregarcene come ce ne freghiamo di quelle del coccodrillo.
Distinti saluti.
E avevo scarabocchiato la mia firma illeggibile sotto.
Erano quasi le cinque e il cielo era ancora

buio. L'elettricità non era tornata. Con la candela in mano sono andata a cercare una busta.
Nel cassetto sotto il telefono ce ne erano diverse. Ne ho presa una bianca che nascondeva un
vecchio foglio piegato, ormai ingiallito. La
scrittura era quella di Michele.
Notte nella malga. Le stelle vegliano sulle
rocce e sui boschi. Ma il loro sguardo è freddo.
Senso di solitudine. Dove sto andando? L'oscurità dilata le domande, le rende inavvicinabili.
Riprendo a respirare soltanto quando compare
il tenue bagliore dell'aurora.
Signore, quant'è grande il Tuo mistero! Per
darci la luce, hai creato le tenebre. Per darci la
vita, hai creato la morte.
Mentre leggevo quelle parole, una raffica di
vento ha quasi divelto una finestra. E' entrata
con violenza, facendo volare i fogli, la cenere, ribaltando il cestino da lavoro di mia madre. Lì
stavano raccolti tutti gli avanzi dei maglioni che
ci aveva regalato nel corso della vita. C'erano le
maglie di Laura, di Michele, le mie, quelle del
nonno. Distinguevo ancora perfettamente i colori di ognuno. Spinti da quella mano invisibile,
hanno cominciato a correre dappertutto. Mi sono messa in ginocchio per cercare di raccoglierli.
Il primo che ho afferrato era azzurro.
In quell'istante la candela si è spenta e una
sciabolata di luce bianca ha attraversato la stanza.
Il bosco in fiamme.
I.
Conosco la sua età, ma non il suo volto. E'
questo che non mi fa dormire la notte. E' venuta al mondo il tre di marzo, alle tre di notte. Alle tre di notte, il
tre di marzo del 1983.
Un amico esperto di esoterismo si era complimentato. Non capita a tutti, mi aveva detto,
di nascere con cifre così perfette. Io non ci avevo fatto molto caso. Giulia era leggermente
sotto peso e piuttosto bruttina, come tutti i
neonati.
I primi dieci giorni li ha passati in incubatrice. Un po' di ittero, niente di più, ma è bastato per scatenare
l'ansia della madre.
«Mi nascondono qualcosa», continuava a
dire con sguardo spiritato. «C'è qualcosa che
non devo sapere. »
Allora io mi sedevo sul letto e passavo ore a
rassicurarla, anche se era del tutto inutile.
Quando finalmente le depositavano la bambina in braccio, la guardava come si guarda
una merce che sospetti ti sia stata venduta avariata.
«Non succhia abbastanza», diceva. «Respira o non respira? Non lo capisco.»
Alla fine, è riuscita a far venire dei dubbi
anche a me. Un pomeriggio, ho bloccato il primario in corridoio.
«Cos'ha mia figlia che non va?»
Eravamo davanti al vetro della nursery.
Giulia dormiva sotto la lampada con il sedere verso l'alto. Probabilmente stava sognando perché faceva
delle smorfie.
«Perché dovrebbe avere qualcosa? La guardi», ha detto sorridendo, «è un piccolo fiore che
non vede l'ora di crescere.»

Il giorno dopo, eravamo tornati a casa. Apparentemente, Anna era tranquilla. A Giulia, invece, il
cambiamento d'aria non aveva giovato.
Confondeva il giorno con la notte. Urlava come
se avesse fame ma, appena Anna le offriva il seno, girava il capo dall'altra parte. Soltanto dopo
molte insistenze, si riusciva a farle prendere
qualche poppata. Erano lotte estenuanti. Quando Giulia era di nuovo in culla, Anna scoppiava
in singhiozzi.
Non mi vuole», gridava, «non ne vuole sapere di me.»
D'accordo con il pediatra, dopo una settimana siamo passati all'allattamento artificiale.
Il miglioramento è stato subito evidente per
Giulia, ma non per Anna. Il parto aveva scatenato in lei una depressione da tempo latente.
Non si lavava più, non faceva la spesa, non cucinava. Quando tornavo la sera dal lavoro, tro
vavo la bambina urlante per la fame e sporca
fino al collo.
In pochissimo tempo, ho dovuto imparare a
fare la mamma. Cambiare i pannolini, metterle
il borotalco, assaggiare con le labbra la giusta
temperatura del latte.
Quando andavo al liceo, le ragazze dicevano
sempre: tu sei il migliore di tutti. I compagni insinuavano che fossi omosessuale ma non era vero. Preferivo
leggere piuttosto che giocare a calcio. Se uscivo con un'amica, mi piaceva parlare con lei piuttosto che
metterle subito le mani
addosso.
Per questo forse, quando mi sono trovato a
fare da mamma, non mi sono turbato più di
tanto. Invece di andare al bar a bere con gli
amici, ho accettato le mie responsabilità. I figli
si fanno in due, mi ripetevo spesso. Se uno sta
male, è giusto che il peso se lo carichi l'altro. Un
giorno guarirà, mi dicevo, e il mio sacrificio
sarà servito a costruire una famiglia felice.
Amavo Anna più di ogni altra cosa al mondo. Amavo la sua fragilità, la sua imprevedibilità. Amavo
soprattutto il fatto che non potesse
vivere senza il mio amore.
L'avevo conosciuta a scuola, era arrivata nella mia classe al penultimo anno, la sua famiglia
si era appena trasferita da un'altra città. Stava al
terzo banco ed era molto silenziosa. Mentre le altre ragazze facevano di tutto per mettersi in mo
stra, lei faceva di tutto per nascondersi. Silenziosa, vestita con sobrietà, se veniva interrogata arrossiva
prima di rispondere. Naturalmente, era
diventata lo zimbello della classe. Le ragazze dicevano: o è scema o nasconde qualcosa. I ragazzi alzavano
le spalle: lasciamola perdere, è proprio una suora, e poi è piatta come una sogliola.
Un pomeriggio l'ho incontrata per caso al
parco. Era maggio, nel laghetto i cigni nuotavano tendendo il collo in avanti, i passeri si rotolavano nella
polvere. Avevamo parlato della
scuola, dei professori simpatici e di quelli antipatici, dell'esame di maturità, delle vacanze, di
ciò che avremmo fatto dopo.
«Non hai qualche passione?» le ho chiesto,
a un certo punto.
«Passioni?», ha ripetuto, abbassando lo
sguardo. «Sì, mi piace leggere. Leggere poesie,
romanzi... cioè, vorrei iscrivermi a lettere. Ma
sono indecisa perché mi piacerebbe anche studiare psicologia. Ci sono tante cose nella testa,
sarebbe bello capirci qualcosa, non trovi? »
«Oh, certo», ho risposto, poi le ho parlato
della mia passione per gli alberi. Avrei studiato
biologia o agraria.
E' sembrata meravigliata. Probabilmente si
è chiesta come si fa ad appassionarsi a cose così poco interessanti come gli alberi?
«Anche gli alberi», le ho detto, «possono essere simpatici o antipatici, ci hai mai pensato?
Ad esempio, guarda quello, un cipresso dell'Arizona, com'è? »
Anna lo ha fissato per un po', poi ha storto
la bocca. «Antipatico. »

«E quello?» ho proseguito, indicando un salice piangente.
«Simpatico. Molto simpatico. »
In quel momento, ho pensato che di una ragazza così avrei potuto anche innamorarmi.
Poi c'è stato il panico prolungato dell'esame di maturità, il sollievo di averlo superato,
le brevi vacanze prima di iniziare le pratiche
di iscrizione all'università. Così l'ho persa di
vista.
L'ho incontrata di nuovo pochi mesi prima
della laurea. Ero nell'atrio della stazione quando si è avvicinata e mi ha chiesto: «Ti ricordi di
me? ».
Siamo andati in un bar a bere qualcosa.
«E quello com'è?» mi ha chiesto, indicando
delle fronde in alto.
«E' un bagolaro», le ho risposto, «antipatico,
molto antipatico. »
L'anno dopo ci siamo sposati.
In questo lungo periodo, ho scritto a Giulia
molte lettere. Ho iniziato quattro anni fa, con
gli auguri di Natale e poi quelli per il compleanno. La prima volta sono rimasto con la
penna a lungo sospesa in aria. Come dovevo firmare? Il tuo papà? Tuo padre? Saverio? O forse Saverio, il
tuo papà? Non riuscivo a decidermi. Ho aperto e chiuso quella busta talmente
tante volte che, quando finalmente l'ho spedita,
era già vecchia e consunta.
L'anno dopo, ho preso coraggio e le ho scritto la prima lettera. Ho scelto della carta che
pensavo fosse adatta a lei, alla sua età. C'erano
dei gattini che correvano dietro a una farfalla.
Per scriverla ho impiegato più di un mese, era
come scolpire le lettere nella pietra. Poi, l'ho lasciata li sul tavolo per un altro mese. Dopo
averla spedita, sono rimasto in attesa della risposta. I giorni si distinguevano solo per l'ansia.
Arriverà o non arriverà?
Alla fine una lettera è arrivata. Ma era la
mia, rimandata indietro. Il timbro viola diceva
"destinatario sconosciuto". Gli auguri li avevo
spediti allo stesso indirizzo. Cos'era successo?
Forse era capitato qualcosa ai nonni. Stavano
male oppure erano morti. O era lei che stava
male. Non riuscivo a darmi pace. Vivevano da
generazioni nella stessa casa, possibile che
avessero cambiato improvvisamente indirizzo?
O forse erano stati proprio i nonni a non volere
che quei biglietti finissero nelle sue mani. Li ributtavano nella cassetta rossa, come si ributta
in acqua un pesce troppo piccolo.
Ritorna indietro. Ritorna all'origine.
La maggior parte del tempo la passo a guardare la televisione. Vedo soprattutto programmi
per adolescenti e mi domando: le piacerà più
questo o quello? Sarà fan di qualche cantante
oppure preferirà stare in giardino a curare le
piante? Sarà la gioia dei nonni o la loro spina
nel cuore?
Spesso la notte mi succede di sognarla. Mi
trovo per la strada di una grande città, New
York o Los Angeles. Mi sembra di scorgerla in
mezzo alla folla. Cammina davanti a me, la
chiamo ma non mi sente. Allora la rincorro e
quando finalmente le tocco la spalla, lei si volta e non la riconosco. «Mi scusi», balbetto. Un
sogno banale. Il sogno banale di una persona
banale.
All'epoca del fatto sono andati a cercare
qualche mio vecchio compagno di scuola o di
università. Volevano sapere che tipo fossi. Alcuni avevano fatto persino fatica a ricordarsi di me.
«Saverio? » ripetevano, come cercando una
cosa di poco conto in fondo a un baule, e poi:

«Ah sì, un tipo normale, normalissimo. Chi l'avrebbe mai detto?».
Provo a pensare ad altro ma non ci riesco. Il
viso che ricordo è quello dei suoi quattro anni.
Stava perdendo la rotondità della primissima
infanzia, Anna le faceva due treccine prima di
andare all'asilo. Usciva di casa canticchiando
con in mano il suo cestino di plastica rosa. E'
una parte di me che ancora va in giro per il
mondo, che guarda, si stupisce. Conosce la verità? Non la conosce? Non lo so e non mi viene
concesso di saperlo. Per molti anni anch'io ho
pensato di sparire dalla sua vita. Per molti anni ho pensato di uccidermi.
Penso a Giulia e non a Anna. Perché? Perché Anna vive di nuovo con me.
A un certo punto è tornata e, invece di respingerla, l'ho accolta. Non è stato facile. Non
subito. Prima non la volevo vedere, poi ho avuto paura. Mi parlava e non potevo credere a
quello che mi diceva. Mi sentivo incerto, confuso. Così ho chiesto un colloquio con lo psicologo. Dopo averlo
incontrato, avevo le idee ancora meno chiare. Sono passato allo psichiatra.
Mi ha dato dei farmaci. Mi si gonfiava la lingua
e lei era sempre qui.
«Ascoltami, Saverio», diceva parlando piano, con delicatezza. Allora io urlavo, correvo,
sbattendo contro le quattro pareti. Era come se
qualcuno mi avesse appiccato del fuoco addosso, come se dentro di me ci fosse un registratore che andava
avanti da solo.
«Anche tu vuoi uccidermi! » le ho gridato
una notte, svegliandomi nel buio.
Soffiava un forte maestrale. L'alba non doveva essere lontana perché sentivo i pescherecci tornare al porto.
La sua voce era come un
fruscio.
«No», mi ha risposto, «voglio che cominci a
vivere.
II.
I gabbiani rispettano orari regolari. All'alba,
in piccoli gruppi, sorvolano il mare diretti verso terra. Poco prima del crepuscolo, compiono
il percorso inverso. Trascorrono le ore di luce in
qualche discarica, a nutrirsi delle cose più immonde.
Quando vivevamo in città, li vedevo spesso
litigare per qualche boccone di spazzatura. Più
che gabbiani, sembravano galline in un pollaio.
Dov'erano finite quelle nobili creature che da
sempre avevano ispirato i poeti? Erano stupidi,
sgraziati, avidi. Impossibile immaginare che
fossero gli stessi animali maestosi e solenni che
verso sera sorvolano la terra per raggiungere il
mare aperto.
Qual è il vero gabbiano? La creatura candida e solitaria o il volatile prepotente che si rotola nella lordura?
E se è così per loro, che non hanno coscienza, come può essere per noi?
Come può essere che noi siamo così arroganti da dire: ecco, questo sono io. Chi sono?
Non lo so, al massimo posso sapere come appaio. Come appaio a me stesso, come appaio
agli altri.
A molti basta questo. Siamo comparse, bisogna accontentarsi.
A un certo punto, però, anche una comparsa può ribellarsi. Ci si può stufare di ripetere
tutte le sere la stessa parte, lo stesso inchino, la
stessa battuta. Così, all'improvviso, qualcuno o
qualcosa ci suggerisce di strapparci le vesti, di
rotolarci negli escrementi, di dire cose sconvenienti.
Chi ha parlato? Ho preso ordini da qualcuno, oppure ho agito di mia volontà?
Non ho mai creduto all'anima, ma al DNA sì.

E' invisibile a occhio nudo eppure è lungo decine di chilometri e dura secoli, anzi millenni, milioni di anni.
Basterebbe questo per rendere ridicola qualsiasi affermazione di conoscenza.
Senza saperlo, si può avere un quadrisavolo
tagliatore di gole. Uno che non lo faceva per
mestiere ma per piacere, appena qualcuno non
gli andava a genio, gli saltava addosso e gli
apriva un grande sorriso sotto il mento. Così il
lontano nipote si rade tutti i giorni e quando vede un pedone sulle strisce, rallenta, si ferma e lo
fa passare con un gesto di cortesia. E quando a
scuola c'è una riunione dei genitori, modera i
pareri più taglienti, con la sua ragionevolezza
aiuta tutti a scegliere la soluzione migliore.
Poi, però, all'improvviso quel gene che dormiva da secoli si sveglia e, invece di sedare una
lite, il nipote taglia la gola ai contendenti. E allora, ecco, urla di meraviglia, di orrore. Come è
stato possibile? Chi l'avrebbe mai detto! Una
persona tanto a modo, tanto cara.
La notte passa ed è lunghissima. Una notte
interminabile come quella dei malati. Uno chiama l'alba, l'aspetta, e l'alba non arriva. E allora
si chiede, da dove viene quel gene? Era proprio
necessario per l'evoluzione? L'omicidio all'interno della stessa specie nel mondo animale è rarissimo, tra gli
uomini è quasi la norma. Si mangia,
si beve, ci si riproduce e si uccide il proprio prossimo. E' questa la partitura di ogni vita. E allora,
chiedo, da dove viene? Abele era buono e Caino
no. Ma, in principio, anche Caino sembrava buono. Arava la terra e nutriva gli animali, esattamente come il
fratello. A un tratto, è successo
qualcosa e non lo è più stato. Perché?
Se non si può definire l'odio, come si può definire l'amore? Qualsiasi parola rischia di essere
patetica. Posso dire solo questo. Non c'è stato un
giorno, un'ora, un minuto in cui il mio pensiero
non sia stato concentrato su Anna. Mi svegliavo e
pensavo a lei. Andavo in macchina e pensavo a
lei. Lavoravo e pensavo a lei. Pensavo e mi chiedevo: come posso aiutarla, in che modo posso renderle la
vita meno pesante? Sapevo che senza di
me non ce l'avrebbe fatta. La sua vita illuminava
la mia, dandole un senso.
Quando Giulia ha compiuto un anno, la situazione ha cominciato a migliorare. Giulia era
precoce, aveva un carattere allegro e questo, in
qualche modo, aveva rassicurato sua madre.
Andavano per strada, con la carrozzina, e tutti
la fermavano, le dicevano: com'è simpatica,
com'è carina! Anna si sentiva orgogliosa di
averla messa al mondo. L'ansia la divorava ancora, ma riusciva a tenerla sotto controllo con i
farmaci.
E poi io, con gli anni, avevo imparato a conoscerla come un cane da gara conosce il campo ad ostacoli. Lì ci
sono tre paletti, a destra
uno scivolo, più in là, un tunnel a soffietto e poi
il copertone nel quale saltare. Cinque minuti di
ritardo nel tornare a casa voleva dire trovarla
sul divano in lacrime, convinta che io fossi già
riverso sull'asfalto. Dimenticare una commissione significava per lei il cupo silenzio dell'abbandono.
Quando stavo fuori per lavoro tutto il giorno, mi facevo vivo da ogni bar tabacchi, da ogni
posto telefonico, da ogni cabina abbandonata a
un incrocio. Quando mi capitava di dover portare con me un assistente, inventavo delle scuse
per telefonare ogni momento. Mia madre sta
male, dicevo, o qualcosa del genere.
Ero geloso della nostra reciproca dipendenza.
Sapevo che, vista da fuori, avrebbe potuto scatenare commenti non certo benevoli. Poche persone, mi
dicevo, hanno la fortuna di vivere un
amore così intenso. Per questo è meglio tenerlo
nascosto. Sentivo le storie dei miei colleghi, liti
continue, rivendicazioni, mogli inquiete che
aspettavano soltanto che la porta si chiudesse

dietro al marito per scappare fuori di casa.
Una volta, avevo avuto anche un mezzo litigio con uno di loro. «Ma non ti annoi con tua
moglie? » mi aveva chiesto beffardo.
«Parli così perché non sai cos'è l'amore», gli
avevo risposto, seccato.
Sapevo che i conoscenti ci chiamavano "i
pappagalli inseparabili", ma non me la prendevo più di tanto. Parlano con la bocca amara,
mi dicevo, perché vorrebbero essere al nostro
posto.
A quel tempo, lavoravo in una società per la
protezione ambientale, mi occupavo delle malattie degli alberi, avevo modo di applicare le
mie conoscenze ed ero contento.
A volte, di notte, chiudo gli occhi e non dormo. Vedo il fuoco. E' il fuoco ma non è il fuoco.
E' una foresta di larici. Sembra autunno ma intorno l'erba dei pascoli è alta e dunque non è
autunno. Ancora una volta, ciò che sembra non
è ciò che è realmente. Qualcuno cammina là
sotto e quel qualcuno sono io. Il bosco è il bosco che mi è stato affidato. Quando tutto comincia, è ancora
verde. C'è solo il sospetto che
sia stato attaccato da lepidotteri devastatori.
Raccolgo un po' di foglie, un po' di corteccia,
spargo qua e là delle trappole ai feromoni, per
vedere se l'insetto è già arrivato.
Intanto Giulia, a casa, è caduta dal seggiolone e si è fatta un grande bernoccolo. Non ci sono telefoni nel
bosco, non posso saperlo. Lo vengo a sapere soltanto sulla via del ritorno. Quando entro a casa, Giulia è
sul divano e Anna la
stringe a sé. Piange.
«E' colpa mia, non vede più da un occhio. »
Paletti, tunnel. Inutile rassicurarla, dirle che
tutti, prima o poi, siamo caduti dal seggiolone.
Il giorno dopo, di buon mattino, le porto in
ospedale. Da lì, telefono ai colleghi dicendo: arrivo un po' più tardi. Invece il medico esce dal
Pronto Soccorso. Accanto a lui, Anna sembra
uno spettro. Lo sento dire: «E' meglio ricoverarla subito».
Lo stesso giorno, i lepidotteri arrivano nel
bosco,
Un bosco di solito muore più lentamente di
Un uomo. Per andarsene, ci mette mesi o anche
anni. Ma quando è andato, è andato per sempre. E, con lui, sono andate anche tutte le altre
forme di vita. I licheni e i muschi, i coleotteri e
le formiche rosse, i curculionidi e i crocieri, i lucherini e i codibugnoli. Chi può, fugge via. Chi
non ce la fa, si spegne con lui.
La morte mia e quella del bosco sono iniziate con curiosa sincronia.
Giulia aveva qualcosa nella testa ma non si
sapeva ancora bene cosa. Bisognava aprirla per
saperlo. Camminavo sui primi aghi caduti e
non ero preoccupato per Giulia ma per Anna.
Se Giulia muore, mi dicevo, vuol dire che era il
suo destino, ma come farà Anna a sopravviverle? Camminavo e improvvisamente sentivo le
spalle fragili. Quanti pesi si stavano accumulando là sopra?
Passando i giorni in ospedale, Anna diventava sempre più trasparente, la voce si era ridotta a un filo. Ogni
volta che era possibile, la
stringevo forte tra le mie braccia, le parlavo
piano all'orecchio.
A Giulia avevano rasato i capelli. Così i suoi
occhi erano enormi e ormai privi di allegria.
L'operazione è andata bene, così come il decorso. In quei giorni avrei dovuto sentirmi abbattuto, disperato,
e invece mi sentivo un leone.
Avevo un'energia dentro di me straordinaria. Io
ero il cardine, non potevo cedere.
Dovevamo aspettare la biopsia.
Qualche giorno prima del responso, Anna e
Giulia sono tornate a casa.

Nel bosco, i primi due alberi erano diventati
gialli. Bastava sfiorare un ramo perché gli aghi
cadessero come una pioggia. Gli aghi che cadono
fuori stagione fanno più impressione delle foglie.
Cadono e sembrano denti. La foglia plana, l'ago
precipita. Il ramo nero è come una gengiva nuda.
Intorno tutto è vita e li è morte. O preludio della
morte.
In ospedale, Anna aveva fatto amicizia con
un'infermiera. Le avevo viste varie volte parlare fitto insieme.
Una sera, al ritorno dal bosco, ho trovato la
casa vuota. Mancava un giorno al responso, per
questo mi sono preoccupato.
Ho girato in macchina tutta la notte. Sono
passato e ripassato più volte vicino al fiume, sui
ponti. Anna avrebbe potuto fare una pazzia.
Quello che per noi è una pazzia, a lei sarebbe
sembrata una cosa naturale.
Alle prime luci dell'alba sono andato dai carabinieri a denunciarne la scomparsa.
Poco prima di mezzogiorno, ho sentito la
sua chiave nella toppa. Aveva Giulia in braccio
e sorrideva. Mi ha baciato come tornasse da
una gita e poi è andata verso il telefono.
«Cosa fai?» le ho chiesto.
E lei: «Chiamo il primario».
«Lo faccio io!»
Ho visto le sue spalle scuotersi. «Non inporta.»
Dopo un minuto, è arrivato il responso. Anna è caduta direttamente in ginocchio, con la
cornetta ancora in mano.
«Papà, voio bumba!» gridava Giulia.
«E allora?» ho gridato io. La bambina si è
spaventata ed è scoppiata a piangere.
«E allora? »
Anna tremava, si copriva il volto con le mani e ripeteva: «Dio ti ringrazio! Dio ti ringrazio...».
Alla fine, l'ho afferrata per la spalla.
«Parli con Dio», le ho gridato in faccia, «o ti
degni di parlare con tuo marito?»
III.
Sull'isola non scoppiano mai incendi. Troppa pietra, troppo poca vegetazione. Non scoppiano incendi,
eppure io sento sempre l'odore
del fuoco. Ma che odore ha il fuoco se dentro
non c'è niente che brucia? Il fuoco di un bosco
è diverso dal fuoco di vecchi copertoni. Il fuoco
che brucia le penne o le ossa è diverso da quello che divora le foglie.
Di notte sogno i larici trasformarsi in fiamme. Ogni larice è una vampata solitaria. Se Osservo meglio, mi
accorgo che non sono larici
ma persone. O meglio, larici con la testa di persone. C'è il volto di Anna, là sopra, e quello di
Giulia, e c'è anche il mio volto. Bruciamo tutti
senza un grido, senza un'imprecazione. C'è solo il crepitio secco dei rami morti. Ed io che mi
aggiro sotto con le mani nei capelli ripetendo:
«Erano lepidotteri, non fiamme! Perché adesso
brucia tutto? Non ho mai creduto all'inferno!».
La prima volta, lei è venuta di notte. Ho
sentito qualcosa di fresco sulle guance, ho aperto gli occhi e ho visto brillare il suo sguardo.
C'era una tristezza tremenda là dentro. Qualcuno, qualcosa, non so chi mi ha detto in un
soffio: «Cos'hai fatto?».
Non ho mai creduto all'inferno, ai diavoli e

neanche ai fantasmi, di conseguenza non ho mai
creduto neppure in Dio. Anzi, l'idea stessa di Dio
mi ha sempre dato fastidio. Che bisogno c'era di
scomodarlo per spiegare l'universo? C'erano le
leggi della fisica, le leggi della chimica. La loro interazione dava la possibilità di spiegare ogni cosa.
Dopo la malattia di Giulia, Anna era diventata un'altra persona.
Usciva spesso con la sua nuova amica infermiera e tornava a casa piena di pacchetti. Ha
iniziato a curarsi nell'abbigliamento, a truccarsi
leggermente, a indossare vestiti allegri e colorati.
Un giorno sono tornato a casa e ho trovato
su ogni finestra dei vasi pieni di primule. Invece di salutarla, l'ho aggredita.
«Come ti viene in mente?»
«Credevo ti facesse piacere. In fondo è primavera. »
«Già, ma questi fiori devono stare nei boschi, non lo sapevi? Potevi dirmi, voglio vedere
le primule e io ti ci portavo. Ma metterle quassù, in mezzo al cemento, come piccole testoline
decapitate... questo no. Mi danno il voltastomaco.» Così dicendo ho cominciato a strapparli e a buttarli sul
pavimento.
Anche i gabbiani agiscono allo stesso modo.
Quando hanno qualche contenzioso con un loro simile, strappano dell'erba con il becco e la
scaraventano poco distante, come a dire, stai
attento, la prossima volta potresti esserci tu al
posto dell'erba.
Ormai io la chiamavo ogni mezz'ora e lei
non era mai a casa. La sera, con indifferenza,
dicevo: «Alle quattro ho provato a chiamarti
ma non c'eri...». Lei era sempre serena. Rispondeva: «Sono uscita con Silvia, con Giulia.
Siamo andate al parco...».
Andavano spesso a trovare un certo monaco
in un convento poco fuori città. Quando parlava di lui, ad Anna brillavano gli occhi. «Dovresti venire a
conoscerlo», mi diceva sempre, «è
un uomo davvero straordinario. »
«Come sai», le rispondevo, «non sono molto
incline a queste cose. Che cosa cambia che Dio
ci sia o meno? »
«Cambia tutto! »
Non avevo mai visto Anna discutere con una
foga simile.
«Pensa a un fiore», mi diceva. «Una cosa è
vederlo come un fiore. E' blu o giallo o rosso o
lillà. Ha i petali e i sepali, l'ovario, il gambo, il
pistillo. Può vivere nei prati o abbarbicato sulle rocce. Un'altra cosa è vederlo come la realizzazione di un
sogno. Qualcuno ha immaginato
la bellezza per noi e, per realizzarla, ha creato
il fiore. Prima di ogni altra cosa, un fiore è un
dono per il nostro sguardo. »
«Chi ti ha insegnato a ragionare in modo così confuso?»
«A me sembra tutto chiaro», rispondeva,
abbassando lo sguardo.
La mattina, mentre preparava la colazione,
la sentivo cantare. Allora, dal bagno, le gridavo: «Spegni la radio!»,
Dov'era finita la mia Anna? Dov'era la fragile creatura che, per anni, aveva dominato i
miei pensieri? Ormai capitava che ci vedessimo
la mattina e poi di nuovo solo la sera. Durante
il giorno eravamo due estranei.
Non dovendo più vivere tra paletti e tunnel,
anch'io avevo cominciato ad avere la mia vita.
Finivo il lavoro e mi attardavo un po' più a lungo con i colleghi, facevo un giro fino in centro
per andare a bere un aperitivo. A volte tornavo
a casa e la tavola non era ancora apparecchiata.
Un collega, un giorno, mi ha detto: «Perché
non apri gli occhi? Quando una donna cambia,
c'è una sola ragione. Un'altra persona è entrata nella sua vita. Si veste, si trucca, canta. Non

sarai così sciocco da credere che lo faccia per le
parole di un vecchio monaco?».
Nel Vangelo, il diavolo sale sulla montagna
e dice a Gesù: «Tutto questo sarà tuo, se mi ub
bidirai». Il diavolo potrebbe somigliare a un
agente immobiliare o a un tarlo. Oppure al seme di un'erba che si infila dappertutto, al forasacco, per
esempio, che si posa sulla superficie
di un corpo e poi va avanti, cammina sotto la
pelle come una freccia silenziosa. Nessuno lo
vede, nessuno lo sente e lui scava il suo solco.
Conosce benissimo la sua direzione. Sale fino al
cervello o scende fino al cuore. E li esplode.
Così quelle parole erano state parole tarlo.
Io stavo fermo e loro grattavano sempre più a
fondo. Come avevo fatto a non pensarci prima?
L'amica, il monaco, le continue uscite... Era
evidente che si trattava sempre e soltanto di
una scusa. In tutti gli anni in cui era stato vivo
il nostro amore, i suoi occhi non avevano mai
brillato a quel modo.
Con il filo del sospetto si riesce a cucire ogni
tipo di vestito. Così, piano piano, ero riuscito a
ricostruire lo svolgimento degli eventi. E a mettere a fuoco un nome e un volto. Chi altro poteva essere, se
non il primario? In quei giorni di
paura e sospensione, le era stato molto vicino. Il
destino di Giulia era nelle sue mani. Avrebbero
potuto esserci negligenza, trascuratezza nell'operazione, invece tutto si era svolto nel modo
migliore.
Non l'aveva fatto per la bambina, era chiaro, ma per aumentare il flusso di ammirazione.
Aveva visto quella giovane madre disperata,
una preda offerta su un vassoio di argento. Per
servirsene, bastava allungare la mano. Non c'è
niente di meglio di una donna da consolare, da
rassicurare. Anzi, il porco aveva scelto apposta
quel mestiere. Le madri affrante cadevano una
dopo l'altra tra le sue braccia. Ed era evidente
che anche l'infermiera, quella Silvia, in qualche
modo gli reggeva il moccolo. Era lei a circuire
per prima le prede. Le portava in giro, parlava
soltanto di lui per accrescere l'idolatria nei suoi
confronti.
La prova del nove era stata la telefonata per
il responso. Anna aveva afferrato il telefono e
aveva composto il numero a memoria. Lo conosceva a memoria. In ogni suo gesto, c'era dimestichezza.
Lei, che di solito aveva paura anche soltanto a chiamare la latteria sotto casa!
E cos'altro era il monaco, se non un nome in
codice per indicare qualche motel di periferia?
Camminavo per il bosco e non pensavo ad
altro. Non avevo nessuno con cui sfogarmi, così la rabbia e i pensieri crescevano a dismisura.
Camminavo parlando a voce alta. Se qualcosa
mi capitava a tiro, sferravo un calcio. Sulla mia
testa, sulle mie spalle, cadeva una pioggia di
aghi morti. Soltanto l'idea della vendetta mi
dava una sorta di temporanea quiete. Immaginavo tutti i modi in cui avrei potuto far loro del
male. Immaginandoli, sentivo il cranio scricchiolare. Stringevo i denti così forte come Se,
tra un'arcata e l'altra, ci fosse stato un OSSO.
Avrei potuto raccontare tutto alla moglie, mandarle un biglietto anonimo, ritagliando le lettere da un giornale.
Avrei potuto coprire la sua
elegante macchina di frasi ingiuriose. Avrei potuto aspettarlo sotto casa e dargli una lezione.
Davanti a Anna, non riuscivo più a nascondere il mio turbamento. Di notte, accanto a lei,
mi giravo e rigiravo nel letto.
Una sera non ce l'ho fatta più. Quando lei

mi ha chiesto: «Cosa c'è? perché non dormi?»,
le ho risposto: «Hai un odore che non conosco».
Lei è scoppiata a ridere. Sembrava una risata leggera. «Ho cambiato crema idratante! »
«Potresti inventare una scusa migliore», ho sibilato, prima di alzarmi e andare a dormire in salotto.
Lei mi ha raggiunto sul divano. Mi guardava preoccupata.
«Non toccarmi», le ho detto, «mi fai schifo. »
Mi ha toccato lo stesso.
«Saverio, cosa succede?»
« Succede che sei cambiata. »
«E' vero, ma perché ti fa arrabbiare?»
«Perché quando una donna cambia, c'è una
sola ragione. »
«E qual è?»
«Vuoi proprio che te lo dica in faccia? »
«E' innamorata di un altro. »
Anna ha fatto un profondo sospiro. «E' vero.
Sono innamorata, ma non di un'altra persona. »
«E di chi allora?»
«Sono innamorata della vita. »
«Non dire stronzate da fotoromanzo. »
«Non sono stronzate. E' quello che provo.»
« Senti gli uccellini cantare? »
«No, ho trovato un senso.»
«Ma un senso ce l'avevi già. Ero io. Eravamo noi, la tua famiglia. »
«Lo siete ancora. Lo siete più di prima.»
Dalla gola mi è uscita una risata come un latrato.
«Non si direbbe! "Caro, stasera arrivo tardi.
Caro, guarda che bella messa in piega. Senti come profumo. Guarda come sculetto bene con i
nuovi tacchi. Guarda caro, guarda. Non sembro
proprio una puttana?"»
Anna si è alzata. Io continuavo a darle la
schiena.
«Perché mi devi addolorare in questo modo? »
«Perché vedo la verità.»
«Tu ormai vedi soltanto i tuoi fantasmi.»
«Già che siamo in tema. Perché non mi porti a conoscere quel tuo famoso monaco? »
«Non credevo ti interessasse. »
«Invece mi interessa moltissimo. »
Quella sera, sul divano mi ero addormentato ridendo. L'avevo messa in difficoltà. Le bugie hanno le gambe
corte, c'era un detto più vero di questo?
Per organizzare bene la messa in scena, le ci
è voluto del tempo. Soltanto una settimana dopo mi ha detto: «Questo pomeriggio, alle quattro, siamo attesi
al convento».
Abbiamo portato Giulia al compleanno di
una compagna di asilo, poi ci siamo avviati verso il raccordo. Guidava Anna e per tutto il tragitto siamo
rimasti in silenzio. Ogni tanto avevo l'impressione di sentirla deglutire come un
animale che percepisce l'imminente pericolo.
Il convento era composto da una serie di
brutti edifici a una ventina di chilometri dalla
città. Intorno, c'era la piattezza esasperata della monocoltura interrotta da qualche filare di
pioppi ancora senza foglie.
L'ingresso era freddo e squallido. Il frate
guardiano ci ha fatti accomodare su due poltroncine di similpelle color nocciola chiaro.
Quando si è aperta la porta in fondo al corridoio ed è comparso un uomo anziano, Anna si
è alzata e gli è andata incontro.
Li ho visti abbracciarsi e poi lui prenderle
una mano tra le sue con un gesto di affettuosa
intimità. Sono rimasto seduto. Davanti a me
Anna ha detto: «Saverio, mio marito».
Il monaco mi ha stretto la mano e poi mi ha
fatto cenno di accomodarmi in una stanzetta laterale.
Ci siamo seduti uno di fronte all'altro. Io

stavo guardando la sua barba chiedendomi, è
vera o finta?, quando lui ha detto: «Sua moglie
mi ha parlato molto di lei».
«Ah sì? E cosa le ha detto?»
«E' molto preoccupata. »
«Perché? »
«Perché dice che è cambiato e non ne capisce la ragione. »
«E' lei ad essere cambiata.»
Il monaco ha sorriso. «Questo è vero. Anna
negli ultimi mesi ha vissuto una vera e propria
rivoluzione. »
«E allora perché non posso cambiare anch'io? »
«Ci sono tanti tipi di cambiamenti.»
«Perché il suo le piace e il mio no? »
«Dipende dalla luce dello sguardo. »
Da qualche parte nei corridoi è suonata una
campanella.
Cominciavo ad irritarmi.
«Il solito armamentario decrepito! "L'occhio è la tua lanterna, eccetera, eccetera." I
computer pensano ormai quasi come gli uomini e lei crede ancora a queste cose. O peggio,
vorrebbe che io ci credessi.»
Quell'uomo mi fissava con due occhi scuri e
immobili. Avevo la sensazione di essere un animale esotico in gabbia. Mi stava scrutando e
non avevo alcun modo per difendermi. Gli ho
dato fin troppo spago, ho pensato. Ora bisogna
tagliare corto, smascherarlo.
Mi sono alzato in piedi di colpo. La sedia si
è ribaltata.
«Perché non smette di recitare? » ho gridato
con più voce di quanta avrei voluto.
Il monaco è rimasto immobile, con lo stesso
sguardo, senza abbassare le palpebre. «Adesso
ho capito», ha detto piano, mentre stavo sulla
porta.
«Capito, cosa?» gli ho gridato in risposta.
Al ritorno ho guidato io.
«E' bravo a recitare, il tuo amico», ho detto.
«Incute quasi soggezione. Quasi. »
«A volte ho l'impressione che tu sia impazzito. »
«Allora siamo impazziti in due. Io sono Napoleone, tu chi sei?»
Parlando premevo l'acceleratore con rabbia.
Sembrava dovessi schiacciare qualcosa sotto i
piedi.
«Saverio, so che ti sembra strano ma la mia
vita è cambiata. E' cambiata per qualcosa che
non si può vedere. »
«Non credo a ciò che non si può vedere. »
«Però credi nelle leggi della chimica. »
«Tutto ciò che esiste è chimica. Chimica e fisica. Io, te, questa macchina, il motore, la benzina, l'asfalto, gli
alberi. Sono loro a costruire la
vita. »
«Ma chi ha costruito loro? Chi ha costruito
le leggi che ci permettono di essere qui? »
«Le leggi sono sempre esistite.»
«Non è vero. Le leggi le hacreate Dio.»
«Certamente. E l'uomo discende dalla scimmia e presto sulla terra cadrà un'altra pioggia
di fuoco. Non è così?»
«Non prendermi in giro.»
«Non ti sto prendendo in giro. Dov'è l'indirizzo di quel neurologo da cui andavi dopo il
parto?»
«Parli così perché sei invidioso.»
«E di cosa sarei invidioso? Delle tue favolette? Grazie, no. Ho creduto a Babbo Natale fino

ai sei anni e questo è tutto.»
«Io credo in Dio, non in Babbo Natale. »
«Se Giulia fosse morta, non ci crederesti. »
«Dio ci salva in ogni caso. »
«Ah sì? Vediamo», ho detto, premendo ancora di più l'acceleratore.
«Rallenta! » ha gridato Anna. «Pensa a nostra figlia!»
«Ci pensa Dio, o no? Vediamo.»
A quel punto ho imboccato a tutta velocità
il senso di marcia opposto. Dopo qualche secondo ci siamo trovati di fronte una macchina.
Ho sterzato una frazione di secondo prima dell'impatto.
Tornati nella nostra corsia sono scoppiato in
una risata nervosa.
«Allora, chi ti ha salvato? Chi ha girato il
volante? Dio oppure io?»
Anna piangeva coprendosi il volto, ripiegata
su se stessa. «Sei un uomo cattivo», ripeteva.
«Sei un uomo cattivo. »
Ho fatto finta di consolarla. «Non dire così.
Stavo scherzando. »
Le sue lacrime mi davano una gioia profonda.
IV.
Il bosco era ormai quasi completamente
bruciato. Soltanto una trentina di larici sembravano ancora in buona salute. Bastava però
avvicinarsi per accorgersi che i primi segni della distruzione avevano iniziato a colpire anche
loro. Da quasi un anno stavo tentando di risolvere quel problema e tutte le soluzioni che avevo trovato si
erano dimostrate vane. Dopo le
muffe e i marciumi, avevo cercato di incolpare
diversi tipi di lepidotteri ma neppure di uno ho
trovato le tracce. Avevo allora pensato alle
piogge acide. Nel Nord America, vicino ai grandi laghi, avevo visto intere foreste di conifere ridotte a quel
modo. C'erano troppe industrie
nella pianura Padana, troppi scarichi e quando
si invertiva la corrente del vento, finivano tutti
ad incunearsi su nelle valli.
Ero abbastanza convinto di quest'ipotesi, ma
le analisi dell'acqua degli ultimi mesi ancora una
volta mi avevano smentito. Il bosco moriva e non
riuscivo a capirne la ragione. Il cliente che aveva
commissionato il lavoro voleva una risposta e io
tiravo avanti tergiversando. Stavo facendo dei rilievi, ancora non erano pronti. Il sospetto che dietro a tutto ci
fosse un virus diventava ogni giorno
più grande. Ma dire un virus è come dire tutto e
niente. Gli insetti hanno le loro leggi, per combatterli basta pensare come loro e trovare un nemico che li
divori. L'unica legge che conosce il virus, invece, è l'anarchia. Vive ovunque, come gli
pare e con leggi solo sue. Vive ma il suo scopo non
è la vita bensì la devastazione e la morte dell'organismo che lo ospita. Non ha un volto ma molti. Ogni volta
che si riesce ad identificarne uno,
lui cambia maschera e parola d'ordine e subito
varca un confine tornando inafferrabile.
Passavo giornate intere sotto quegli alberi
agonizzanti. Un albero che muore è qualcosa
che dà un disagio estremo. Soprattutto a chi sarebbe incaricato di salvarlo. Un albero muore
senza parole e il suo tronco resta li per tanto,
troppo tempo, come un dito puntato contro il
cielo. Un dito che grida la tua impotenza. Sapevi tutto del suo ciclo vitale e malgrado questo,
non sei riuscito a fare niente.
Spesso in questi anni, riandando con il pensiero a quei giorni, mi sono detto che anche il

bosco in qualche modo ha dato il suo contributo alla rovina. Nel bosco c'era un virus e un altro virus era nel
mio corpo. Sfiorandosi, sono
riusciti a innescare una miscela mortale.
Se in quei giorni avessi curato un giardino
rigoglioso, ad esempio, forse tutto sarebbe andato in modo diverso. Sarei arrivato nel giardi
no pieno di pensieri cupi e il giardino, con la
sua quiete, con la sua armonia, me li avrebbe
fatti svanire. Nella grande serra gli agrumi sarebbero stati in fiore e le aiuole, un trionfo di
colore. Con il suo canto di bellezza, la vita
avrebbe dissolto ogni ombra.
Invece ogni mattina arrivavo nell'agonia del
bosco. Stavo lì tutto il giorno con gli aghi che
mi cadevano addosso. Perdevo il controllo di
mia moglie e perdevo il controllo dei larici. Era
davvero troppo per un uomo solo.
Quando stavo lassù, pensavo solo ad Anna,
al modo per vendicarmi. Quando ero a casa,
pensavo invece al bosco, alla soluzione migliore. Un giorno o l'altro, sarei andato su e gli
avrei dato davvero fuoco.
Dormivo e stringevo i denti così forte che una
notte Anna mi ha svegliato, dicendo: «Ascolta!
Da qualche parte ci deve essere un topo...».
Sarà stato il tre o il quattro di maggio. C'era già l'ora legale ed ero rimasto più a lungo nel
bosco. Sono arrivato a casa che erano passate
da un po' le nove. Le finestre spente e nell'appartamento non c'era nessuno. Ero stanco, avvilito. Mi
aspettavo di mangiare un piatto caldo, di ricevere un gesto d'affetto. In fondo era
per loro che mi dannavo tutto il santo giorno.
La rabbia è esplosa all'improvviso. Ho cominciato a prendere a calci tutto ciò che potevo, a buttare giù gli
oggetti dalle mensole. Ho
preso la foto del nostro matrimonio e l'ho scaraventata a terra, ho rotto il vetro e la cornice e
poi ho strappato la foto in tanti pezzetti piccoli
come coriandoli. Quando la porta si è aperta li
ho raccolti nel palmo della mano.
Anna sembrava stanca.
«Giornata nera», ha detto. «Ho bucato la
gomma, ed era bucata anche quella di scorta.»
Sono andato davanti a lei e glieli ho soffiati
in faccia. «Il nostro matrimonio», ho detto, «ecco quello che ne resta. »
«Perché dici così? »
«Perché?! Perché? » ho cominciato a urlare. «Perché??? Io lavoro tutto il giorno per la
mia famiglia e torno e sono un uomo solo. Non
ho più una moglie né una figlia. Il povero cretino serve solo a portare i soldi a casa. Ma il povero cretino è
stufo, tremendamente stufooo! »
Giulia si è nascosta dietro le sue gambe.
«Calmati, Saverio, calmati. Te l'ho detto, si
è trattato di un contrattempo. »
Mi sentivo come una caffettiera che stava da
troppo tempo sul fuoco, la pressione saliva e saliva e saliva ancora.
«Non sai dire altro! » ho gridato e poi ho fatto una cosa che non avrei mai creduto possibile fare. Le ho
mollato uno schiaffo.
C'è stato un momento di silenzio. Il telefono
ha squillato ma nessuno ha risposto. Giulia ha
detto: «Papà tattivo».
Anna l'ha sollevata in braccio, le ha dato un
bacio sulla fronte.
«No. Papà non è cattivo. E' solo molto stanco. Guarda, noi gli facciamo una carezza.»
Giulia esitava con la manina a mezz'aria.
C'era sorpresa, paura nei suoi occhi. Allora Anna l'ha guidata fino alla mia guancia.
«Caro papà, caro.»
I suoi polpastrelli erano incerti e freschi sulla mia faccia incandescente.
«Ti odio», ho bisbigliato nell'orecchio di
Anna prima di uscire dalla porta.

Non avevo le chiavi della macchina, non
avevo il portafogli. Tornare dentro a prenderli
sarebbe stato troppo umiliante. Dove potevo andare a dormire quella notte se non in cantina?
Adesso so che, nel percorso che avevo compiuto fino a quel punto, la cantina era l'ultimo
tunnel da superare, l'ultimo paletto da aggirare
prima di giungere alla meta. Avrei potuto andare in strada, entrare nel primo bar e ubriacarmi e poi cadere
addormentato su una panchina del parco. Avrei potuto andare a casa di
un amico e parlare con lui come un pazzo fino
alle prime luci dell'alba. Avrei potuto fare tutto
questo e invece, come un automa, ho cominciato a scendere i gradini.
In cantina ho trovato ciò che mi mancava.
Una bicicletta. Una bicicletta nuova, con un
fiocco rosso vicino al campanello. Sul manubrio, c'era appeso il sacchetto di un negozio da
uomo.
Avevo avuto ragione, nel cambiamento di
Anna c'era davvero un altro uomo, un uomo
così arrogante da nascondere la sua bicicletta
nella mia cantina. Già, venire in bici era più facile che venire in auto, lasciava meno tracce.
Perché era li? mi sono chiesto.
Magari, un giorno, era stato sorpreso dalla
pioggia così era stata lei a riaccompagnarlo a
casa in macchina. «La bici lasciamola in cantina», aveva detto, «tanto mio marito non ci mette mai piede.»
Mentre io impazzivo per quel bosco, loro
stavano tra le mie lenzuola a scambiarsi frasi
dolci.
Era il primario o non era il primario? A
questo punto non aveva nessuna importanza.
Mi bastava sapere questo, che non mi ero ingannato.
Ora il fuoco dei larici divampava dentro di
me. Sentivo le fiamme lambire il tronco, i rami
crepitare un istante prima dello schianto.
Non era possibile dormire là dentro, per un
po' sono rimasto seduto. Poi ho visto due vecchi
manubri da ginnastica. Li ho afferrati e ho cominciato a muovermi. Ho fatto i pettorali, i dorsali e poi delle
brevi frazioni di corsa sul posto,
delle flessioni a terra e altri pettorali. Sentivo
dentro di me un'energia tremenda. Alla base di
ogni energia, c'è qualche forma di calore. Per
non esplodere, dovevo dissiparla. In cantina non
si vedeva l'alba, così guardavo tutto il tempo l'orologio. C'era un pulsante che illuminava il quadrante per
alcuni istanti.
Le cinque e mezzo.
Le sei.
Le sei e un quarto.
Alle Otto Anna accompagnava Giulia all'asilo, avrei aspettato il suo ritorno per salire e dirle ciò che pensavo
della sua condotta. La mattina stessa, sarei andato dall'avvocato e avrei
chiesto la separazione. Una separazione per
colpa con custodia della bambina. Mi sentivo
molto prossimo al trionfo.
Tutto si è svolto in modo molto rapido. Alle
otto e mezzo sono salito. Davanti alla porta di
casa c'era un grande cane bianco che non avevo mai visto.
«Spostati!» gli ho detto.
Ma lui ha continuato a fissarmi come se non
mi avesse sentito. Allora ho afferrato con forza
la pelle del collo e con un movimento brusco
l'ho scaraventato giù dalle scale.
Anna non era ancora tornata. Sono rimasto
ad attenderla in piedi all'ingresso. Ho aspettato
tra i cinque e i dieci minuti.
Quando è entrata e mi ha visto, ha detto:
«Dove hai dormito? Sono stata in pena tutta la
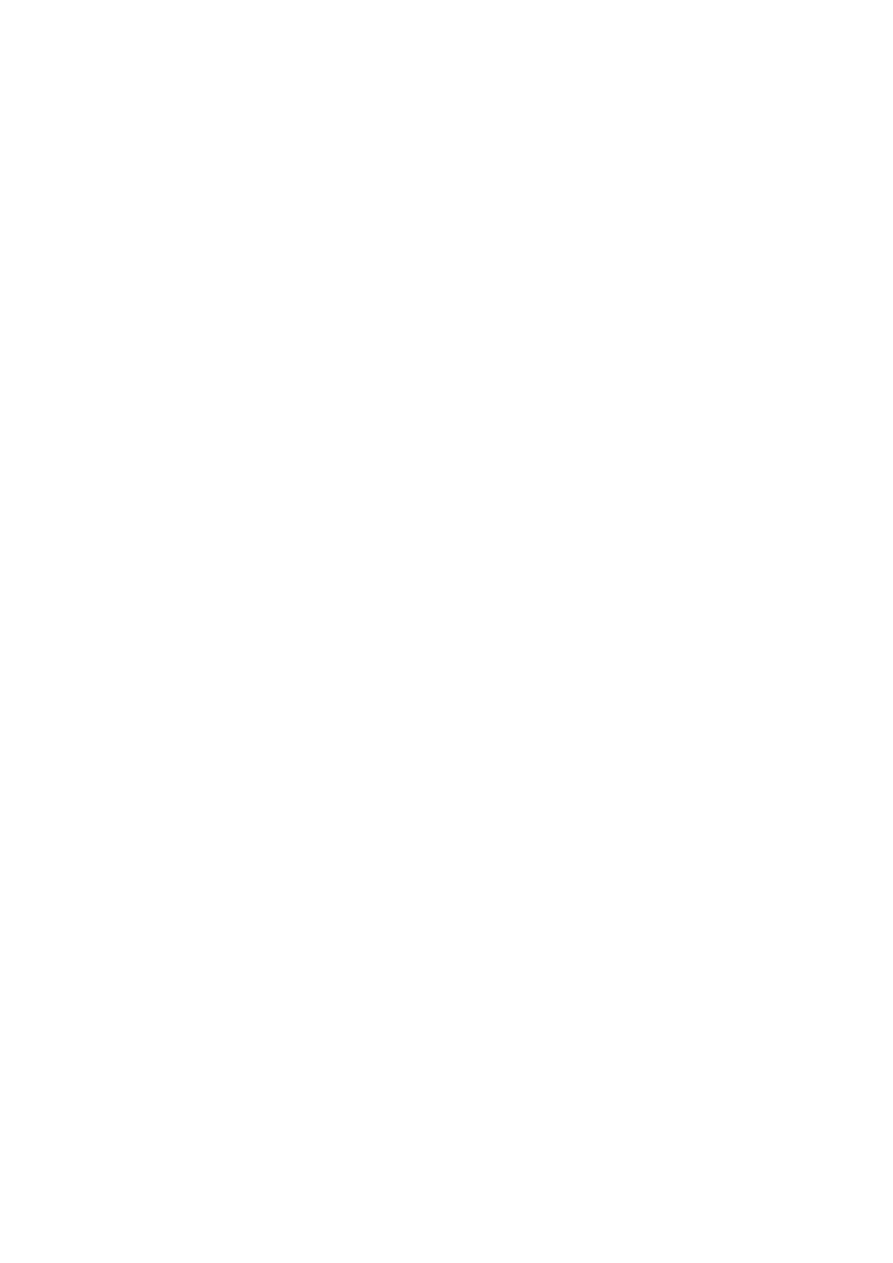
notte». Atteggiava il viso ad una finta tristezza.
«Non ti sei accorta? Ero vicinissimo.»
«Vicinissimo dove? »
«Sotto i tuoi piedi.»
«In cantina?»
«In cantina.»
Ho goduto studiando l'espressione del suo
volto. Sembrava delusa. «Allora hai già visto
tutto? »
«Ho visto tutto.»
A quel punto mi aspettavo che scoppiasse in
singhiozzi, che si buttasse ai miei piedi implorando perdono. Invece ha sorriso, anche gli occhi erano allegri.
Ha aperto le braccia dicendo:
«Allora buon comple. . . ».
Perché avevo ancora uno dei pesi in mano?
L'ho sollevato ed è ricaduto sulla sua fronte. C'è
stato un rumore sordo e Anna è caduta a terra
come uno straccio.
V.
Del bosco non ho saputo più niente. Dove
saranno finiti tutti gli appunti che ho preso,
tutte le cartelle con le analisi e i rilevamenti?
Molto probabilmente il proprietario avrà rinunciato a salvarlo.
Una mattina saranno arrivati lassù due operai
forestali e con la motosega avranno segato i tronchi, uno dopo l'altro. Per un'intera settimana la
valle sarà stata invasa da quel suono di morte.
Denti di metallo che aggrediscono ciò che un giorno era vivo. Poi il rumore si sarà spento e sarà tornato a
gorgogliare il ruscello. I picchi avranno ripreso a beccare altre cortecce e i lucherini e gli organetti a volare
stupefatti su quella grande chiazza nuda che un giorno era stato il loro mondo.
Perdere i denti, perdere i capelli. Di notte non
sognavo altro che questo. Il bosco che moriva e
io che restavo sdentato. Sdentato e calvo. I denti
non cadevano uno a uno, ma tutti insieme. Tintinnavano sul pavimento simili a biglie di vetro.
I capelli non se ne andavano in modo diverso. Passavo la mano in mezzo e me ne restavano ciuffi interi tra
le dita come fossero una parrucca. Allora mi mettevo a piangere. Piangevo
piano in silenzio. Dove sarei potuto andare conciato a quel modo? Senza denti, senza capelli
potevo soltanto far ridere o far pena. Non avrei
più potuto ispirare né rispetto né paura. Per
questo non ho più voluto comparire in pubblico.
Il bosco era morto e anche Anna era morta.
L'avevo vista lì sul pavimento e mi ero sentito
impotente, come con gli alberi. Non pensavo
fosse così facile premere l'interruttore. L'avevo
appena sfiorata ed era andata via.
Per alcuni minuti ho pensato a uno scherzo,
ho ripetuto: «E dai, alzati. Stavo scherzando».
Le ho portato un bicchiere di acqua fresca.
Le labbra non si sono aperte e l'acqua è scivolata lungo il collo, bagnando la camicetta.
Potevo scappare? Certo, ne avrei avuto tutto il tempo. Avrei potuto prendere la macchina
e correre a tavoletta verso il confine. Avrei anche potuto metterla in un sacco e scaricarla in
qualche fiume.
Invece sono rimasto seduto accanto a lei tenendole la mano.
Quando qualcuno ha bussato alla porta, sono andato ad aprire.
Era il postino. Ho preso il telegramma e ho
detto: «Venga. Ho ucciso mia moglie».
Giulia era ancora all'asilo.
Un mese dopo, l'avvocato mi ha portato un

quotidiano con la sua foto. Sapevo che era lei
dalle scarpe, dal grembiule, dal cestino. Il volto
era coperto da una macchia sfuocata, ai bordi
spuntavano due codini con un fiocco a quadretti. Deve essere stata scattata la mattina della tragedia perché
solo Anna sapeva legarli a
quel modo. Dal bagno la sentivo canticchiare:
«Di chi sono questi codini? I codini di un topolino».
Una persona sconosciuta la teneva per mano. Lei sembrava un fantoccio, le braccia molli, le gambe
trascinate. Le avevano detto qualcosa o aveva capito da sola? La sfocatura, comunque, era un'ipocrisia.
Sotto la foto c'era
scritto: La piccola Alice (nome di fantasia) figlia dell'agronomo uxoricida.
Poi un giorno, mentre stavo già qui con l'odore e il rumore del mare, all'improvviso ho
aperto gli occhi e capito perché era morto il bosco. La sua fine non era stata causata né da un
insetto né da un cancro né da un virus, ma soltanto dall'invidia. Invidia perché i larici crescono in mezzo o
accanto agli abeti bianchi, agli
abeti rossi, ai pini silvestri. D'estate sono talmente uguali che i profani li chiamano soltanto
alberi di Natale, ma in inverno tutto cambia. I
larici si spogliano e gli abeti e i pini mantengono gli aghi. Così loro, nudi nel gelo, li vedono
tutti morbidi avvolti dalla neve. La gente passa
e dice, guarda questi che belli e come sono tristi, invece, quelli già morti.
Così i larici sono diventati invidiosi. Non
avevano pace: cosa abbiamo noi meno di loro?
Se è Dio ad averci fatto, perché non ci ha fatti
tutti uguali? Ha dato gli aghi e una forma piramidale a tutt'e tre. Cresciamo alla stessa altitudine e nutriamo
gli stessi tipi di animali. Con la
nostra legna si fanno delle belle casse. I vapori
delle nostre resine guariscono i mali dei bronchi. Perché allora i pini e gli abeti devono avere un trattamento
di favore?
Da un paio di anni sono in corrispondenza
con il monaco amico di Anna. E' stato lui a cominciare. Non gli ho risposto subito. Anzi, i primi tempi, quando
vedevo le sue lettere, le stracciavo urlando. «Cosa vuole da me? Non soffro
già abbastanza? » Alla fine, gli ho scritto un biglietto chiedendogli di smettere. Lui mi ha risposto. Ho
lasciato passare altri mesi e gli ho risposto anch'io. E' stata l'unica persona a farsi
viva in questi anni.
La mia teoria sulla morte del bosco l'aveva
molto divertito. Aveva aggiunto però una postilla. I larici, aveva scritto, non sono invidiosi degli aghi perenni,
ma dell'amore. Non succede la
stessa cosa anche tra gli uomini? Perché crede
che Caino abbia ucciso Abele? Perché riteneva
che fosse più amato. E perché mai i fratelli di
Giuseppe lo hanno buttato nelpozzo? Perché il
padre lo preferiva al punto da regalargli una
tunica con le maniche lunghe, la stessa tunica
che verrà trovata insanguinata tra la sabbia.
Chi vive nell'amore rischia più degli altri, e
spesso deve pagare un prezzo molto alto. In
tanti anni di guida delle anime, non ho mai
cessato di meravigliarmi di questo. Invece di
aprire l'anima, l'amore molte volte la fa chiudere. Perché? Si teme forse che sia come il cibo,
come l'acqua, come i soldi, che arrivi qualcuno
più ingordo di noi e ce lo divori sotto i nostri occhi? Ma l'amore è come l'aria. Infinito. Non si
può dividere in pezzetti, mettere nei tascapani,
nelle borsette, conservare nella dispensa. Non
si può prendere uno spicchio d'amore perché
troveremo sempre qualcuno il cui spicchio ci
sem fra più grande.
E' così che il demone dell'invidia devasta il
mondo. La paura di non avere abbastanza rende gretti. Arraffo, afferro. Più arraffo e più afferro, più ho
paura di perdere, di non aver avuto abbastanza.
Si ricorda il nostro primo incontro? Il colore
della sua anima era rosso fuoco. Non c'era cattiveria dentro di lei, ma confusione. E' proprio
quando non si sta attenti che un incendio divampa. Si getta un mozzicone e quel mozzicone

fa ardere un'intera foresta.
Amava Anna e aveva paura di perderla,
continua a chietermi. Ma si è mai chiesto se l'amava davvero? Ha mai visto veramente la persona di Anna?
O l'amava di un amore narcisistico?Amava
il suo amore per lei, il modo in cui era capace
di proteggerla. Amava la sua fragilità, la sua
dipendenza?
Quando è diventata una persona forte, autonoma, il suo sentimento si è capovolto. Ha cominciato ad avere
paura di Anna dal momento
in cui lei si è liberata dalla paura. Non è un
gioco di parole ma qualcosa di serio su cui riflettere.
Che vita è una vita vissuta nella paura? E' la
vita di chi cammina con lo sguardo basso. La
vita di uno schiavo. Ma il destino a cui siamo
chiamati non è quello di schiavi, bensì quello di
figli e di fratelli. E' il destino dell'amore e della
libertà. Perché la libertà vera non è fare quello
che ci pare, ma vivere come creature libere dalla paura.
Ripenso spesso all'ultima volta che ho parlato con sua moglie. E' stata la notte prima della tragedia, Anna mi
ha telefonato. C'era ansia
nella sua voce.
«Saverio mi ha dato uno schiaffo ed è sparito. Non si è mai comportato così fino ad ora. Il
peggio è che anche la bambina comincia a te-
merlo.»
«Non farà una sciocchezza?» ho chiesto.
«Spero di no. Domani è il suo compleanno»,
ha continuato dopo una pausa. «Gli ho comprato la bicicletta che desiderava. Spero che gli
piaccia, che si tranquillizzi un po'. Del resto
non si può pretendere che il matrimonio sia
sempre sgombro da nubi. Saverio vive nel suo
bozzolo e ha paura che qualcuno lo tiri fuori.
Prima, nel bozzolo vivevamo in due, poi io sono
uscita e lui è rimasto solo. "Torna dentro!» è
come se gridasse.»
«E tu vuoi tornarci?»
«Anche se volessi, sarebbe impossibile. » Poi
ha aggiunto: «Padre, finalmente comincio a capire quella frase...».
«Quale frase?»
«Quella che parla dell'odio del mondo. Fino
ad oggi mi ero sempre chiesta, com 'è possibile
che la gente ti odi quando tu vivi amando?»
«Hai paura?»
«L'ho avuta, ma adesso sono serena. Del resto l'amore non è anche pazienza? Amo mio
marito, amo la nostra bambina. So che anche
lui ci ama, che è soltanto questione di tempo.
Deve solo uscire dal suo mondo di fantasmi.»
Vede, caro Saverio, lei ha avuto il grande
privilegio di scendere la scala fino in fondo.
Non la prendo in giro quando dico questo. Da
un punto basso si vedono le cose con assai più
chiarezza che da un punto medio. Lei avrebbe
potuto continuare a galleggiare tra la confusione dei sentimenti per il resto dei suoi giorni. Ci
sarebbero state schiarite e annuvolamenti. Una
mattina avrebbe odiato sua moglie e la sera
l'avrebbe ricattata con il suo amore. Ci sono
coppie che vanno avanti così tutta la vita senza mai essere sfiorate dal dubbio che si possa
uscire dall'inferno quotidiano.
Nella sua vita, la farsa si è trasformata in
tragedia. Per cancellare tre vite, le è bastato alzare un braccio efarlo scendere con rabbia sulla fronte di
Anna. Quanto sarà durato il tutto?
Un secondo? Mezzo secondo? Il secondo dopo,
lei stava già piangendo accanto al corpo di sua

moglie.
Molti, a questo punto, scriverebbero laparola "fine". A me, al contrario, piace pensare che
ogni fine sia in realtà un nuovo inizio. Certo,
qualcosa è finito, ma il "qualcosa» non è mai il
tutto. Quello che noi chiamiamo fine, spesso è
solo una fase di trasformazione. Lei che ha studiato così a lungo gli insetti, dovrebbe aver ben
chiaro questo concetto. Anna è morta, ma anche
una parte di Saverio è morta. Adesso, la parte
viva di Saverio deve rimettersi in marcia.
Compiangersi, disprezzarsi, odiarsi, sono
tutti modi per rendere vano il sacrificio di sua
moglie. Sarà un Altro, un giorno, a giudicarla.
Intanto, nel suo cuore, lasci uno spazio all'azione della misericordia. Si carichi sulle spalle
il suo zaino colmo di cecità, di violenza, di confusione, di odio, di amarezza e cominci a camminare.
Cammini anche se le dicono che è inutile, o che non ne ha più il diritto. Continui a
camminare anche se non vede più la strada,
anche se la nebbia l'avvolge e procede incerto
sul bordo di un precipizio. E camminando, prima o poi, si accorgerà che la vita è un percorso da compiere e
non un bozzolo nel quale, al
massimo, ci si può stiracchiare le gambe.
La maggior parte delle persone ormai non
vive, attende semplicemente che la vita passi.
Cosa diventa la vita allora? Soltanto un contenitore di svaghi per ingannare la noia. Poi all'improvviso arriva
la morte o la devastazione
di una malattia e tutti gridano: «Imbroglio!
Truffa! Tra le regole del gioco questa non era
prevista».
Ma la morte è davanti a noi fin dal momento del nostro concepimento. La morte sta lì
come un enigma, un 'interrogazione perpetua
che ci portiamo dentro anche nel più felice dei
giorni.
Se si deve morire, che senso ha la vita? Ogni
uomo che nasce deve riscoprire il significato di
questa domanda. E scoprirlo non vuol dire diventare padroni di qualcosa, ma liberarsi. Liberarsi da tutte
quelle cose che ci portiamo nello zaino, dall'avidità, dall'invidia. E soprattutto dall'idea di noi stessi.
Ho detto "liberazione» ma avrei potuto dire
altrettanto bene "purificazione". Purificazione
da ciò che esce dal nostro cuore, dalla nostra
bocca, da quella cosa così desueta ma in realtà
sempre così straordinariamente viva che si
chiama «peccato". Il peccato non è una trasgressione alle regole di un ordine gerarchico,
ma un telo nero che ci gettiamo addosso. In
quell'oscurità artificiale, non vediamo niente,
non sentiamo niente, eppure siamo convinti di
comprendere ogni cosa.
Il peccato è dunque una mancanza, un
danno che facciamo soltanto a noi stessi. Qualcosa che ci allontana drammaticamente dalla
nostra condizione di creature nate per vivere
nella Luce. Lei aveva davanti l'amore luminoso
di sua moglie, l'amore affidato di sua figlia eppure, nella tela spessa nella quale si era lasciato avvolgere,
non solo non li ha visti, ma li ha
anche scambiati per una minaccia.
La morte di Anna deve servire a squarciare
questo telo.
Ormai sono vecchio. Nella mia vita ho vissuto e visto molte cose, ho avuto diverse visioni
del mondo. Col tempo, mi sono accorto che
queste visioni, in apparenza fondate e stabili,
erano in realtà come gli specchi rifrangenti di
un caleidoscopio. Ogni volta pensavo: ecco,
questo è il mondo, questa è la vita. Bisogna
agire così oppure cosà. Quanto duravano questi pensieri? Bastava un soffio perché si infrangessero e da
quel mondo ne uscisse un altro e

poi un altro e un altro ancora.
A un certo punto mi sono ribellato. Tutto
questo è follia, ho gridato. E' follia l'esistere. Sono una follia io. E' follia tutto ciò in cui ho creduto. Per anni
mi sono inginocchiato davanti al
vuoto. Per anni ho parlato del vuoto. Per anni,
ho cercato di convincere chi mi stava vicino che
il vuoto fosse pieno, e che quella pienezza avesse un nome e un senso degni di venerazione e di
rispetto. La mia disperazione era assoluta. Ogni
mattina mi alzavo e mi chiedevo, cosa faccio?
Continuo a vivere con la mia tonaca come se
niente fosse, spargendo menzogne o pongo fine
direttamente ai miei giorni?
E' stato terribile, sa?
Confessavo le persone, ricevevo le confidenze di anime smarrite, tutti aspettavano da me
una via, una certezza, mentre io mi aggiravo
nel buio più totale, senza poter confidare il mio
smarrimento a nessuno. Giravo il caleidoscopio
con rabbia, cercando una nuova risposta alle
mie domande. E' stato a quel punto che mi è
sfuggito di mano, ed è caduto in terra, infrangendosi in mille pezzi. A un tratto, mi sono accorto che tutto
quello in cui avevo creduto fino
ad allora non erano state altro che idee, proiezioni delle mie ansie, delle mie paure. Avevo voluto rendere
afferra bile ciò che è inafferrabile,
avevo voluto limitarlo, dargli un nome, un tempo di svolgimento. Avevo voluto riportare tutto
alla limitatezza della mia mente di uomo.
E' stato in quel momento che ho cominciato
davvero il mio cammino. Il momento in cui sono rimasto completamente nudo, completamente inerme,
completamente senza voce.
Adesso, ogni giorno mi alzo e vado alla finestra e so che quella giornata potrebbe essere
l'ultima. Non c'è più paura in me, né senso di
vuoto, piuttosto la trepidazione un po' adolescenziale di chi attende il primo incontro con
l'Innamorato.
Ogni mattina, poco prima dell'alba, mi affaccio alla finestra di questo brutto edificio di
cemento, guardo fuori e vedo i campi abbando
nati e, più in là, le sagome scure dei capannoni e delle fabbriche e le luci delle macchine. Ci
sono tante persone che vanno a lavorare a
quell'ora! Sto lì mentre la luce prende il sopravvento sul buio.
E' uno spettacolo che non cessa di stupirmi.
C'è delicatezza, in quell'istante, fragilità e anche un 'immensa potenza. Allora, la macchia
scura del campo diventa erba. Vedo gli steli uno
vicino all'altro e la rugiada che li copre e gli insetti che si abbeverano alla rugiada. Vedo i
passeri che si posano sulle fronde dei cespugli.
Sento il loro pigolare scomposto, gioioso, e il pigolare più preciso dei fringuelli e delle cince.
Sento il rumore delle macchine e vedo le persone dentro. Vedo i loro cuori come ho visto la rugiada sugli
steli, uno ad uno, le loro storie, le
loro ansie, le loro inquietudini. Vedo i loro cuori e i cuori delle persone che stanno loro intorno. I bambini che
ancora dormono a casa, protetti dal tepore delle coperte e le mogli già sveglie e i genitori anziani che hanno
trascorso
una notte insonne e ora ascoltano la radio. Vedo i cuori e sento i respiri. Sento i respiri di coloro che
nascono e i respiri di chi se ne Va, come un gran concerto suonato dal Vento. E' musica di organo oppure di
flauto. Sale, discende,
sale. Tra cielo e terra è uno scambio continuo.
Ed è per questo che ogni mattina, su questo
brutto davanzale di cemento, punto i gomiti e
piango. Piango come forse possono piangere
solo i vecchi, sommessamente, in silenzio. Pian
go perché vedo l'amore. L'amore che ci precede
e l'amore che ci accoglierà. L'amore che, nonostante tutto, accompagna ogni cammino, anche
il più piccolo, anche il più contorto, anche il più
ricco di errori. Piango per l'amore, e per tutti
quei cuori che nascono, vivono e muoiono sigillati come casse da morto.
Prego per lei. Prego perché anche lei un

giorno possa affacciarsi, come me, alla sua finestra.
Sotto lo scarabocchio della sua firma c'erano ancora delle righe.
P.s. Negli ultimi mesi ho incontrato diverse
volte sua figlia. E' un 'adolescente asciutta e longilinea, porta i capelli come la madre, legati a
coda di cavallo e ha anche gli stessi occhi, mentre il colore, così come la forma delle mani, sono i suoi. E'
una ragazza riflessiva, abituata,
come lei, a ragionare meticolosamente. Ci vuole un po 'per accorgersi della sottile inquietudine che le
serpeggia nel profondo. Le prime volte ha rifiutato bruscamente l'argomento. Alla
terza è riuscita a dire: «Mio padre è un assassino».
Le ho risposto: «Tuo padre è un uomo che
ha compiuto un gesto tremendo, ma non è un
uomo cattivo».
Stavamo seduti, uno accanto all'altra, su
un muretto, i suoi pantaloni avevano l'orlo sfilacciato, dondolava nervosamente le gambe
avanti e indietro. Guardando lontano ha detto:
«Non si uccide, se non si è cattivi».
Nell'adolescenza tutto è bianco o nero! Così ho risposto: «A volte si fa qualcosa di brutto
perché si è deboli o confusi, perché si ha paura.
Cosa faresti, ad esempio, se adesso dal muretto
uscisse un serpente? Anche se ami gli animali,
probabilmente lo uccideresti».
Col tempo, ho potuto parlarle di voi due,
dell'amore che legava i suoi genitori. «Quando
tu eri piccola, tua madre stava male e tuo padre si è preso cura di te come pochi altri avrebbero fatto. »
Alla base del muretto c'era una pianta di
malva. Un 'ape, ronzando, si è tuffata dentro.
«Lo vedi», ho osservato allora, «l'ape ha bisogno del fiore. Ma anche il fiore, per esistere,
ha bisogno dell'ape. Siamo tutti legati da un
invisibile abbraccio. Tuo padre ha bisogno di te
e tu hai bisogno di lui.»
E' rimasta a lungo in silenzio, con le mani si
tormentava una ciocca di capelli. Teneva la testa girata in modo che non potessi vedere il volto. Ha preso
due o tre respiri profondi, sembrava volersi ribellare a qualcosa che la stava
soffocando. Poi, con voce incrinata, ha chiesto
piano: «Ma la mamma, mia madre, sarebbe
contenta?».
Le ho detto: «Sarebbe la mamma più felice
del mondo».
Con la lettera in mano sono andato alla finestra. Era il crepuscolo e i gabbiani tornavano
dalla terraferma. C'erano due adulti sopra di
me. Stavano quasi immobili con le loro grandi
ali bianche. Dietro di loro, seguiva uno più giovane. Aveva ancora il piumaggio scuro e, a intervalli regolari, li
chiamava con un lungo fischio.
Il mare doveva essere un po' mosso perché
sentivo le onde infrangersi contro gli scogli.
Quando era agitato, sentivo il mio sangue fare
un rumore simile, il cuore lo pompava fino alle
orecchie e dalle orecchie scendeva nuovamente
al cuore.
Nella busta del monaco, c'era un'altra lettera. Era più piccola e con una carta rosa a quadretti. L'ho aperta lì
in piedi, mentre il sole
scompariva all'orizzonte.
Caro papà...
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Susanna Tamaro Rispondimi
Susanna Tamaro Va Dove Ti Porta Il Cuore
Toto susanna
24 Carleton Susannah Małżeńska kampania
Susanna
Carr Susanna Wyspa marzeń
D222 Davis Susannah Rudzielec
Czułości nocy Erwin Susannah
Mozart Susanna moto di gioia part cors f
Mozart susanna moto di gioia part vla
Mozart Susanna moto di gioia part cors
0595 Carr Susanna Gwiazdy Bollywoodu
więcej podobnych podstron